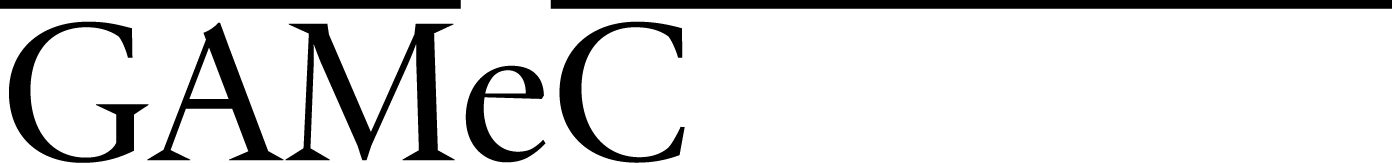“L’anno nuovo comincia con il disgelo e io respiro l’odore forte e bagnato del bosco. L’umidità ha gonfiato il tappeto di foglie cadute che copre il suolo e l’aria è soffusa di inebrianti aromi frondosi. Allontanandomi dal sentiero che si snoda lungo la discesa, mi inerpico attorno a un’enorme roccia erosa coperta di muschio. Attraverso un breve varco sul versante del monte, vedo il mio punto di riferimento: un lungo masso tondeggiante che sporge dalla lattiera come una balenottera. Questo blocco di arenaria definisce un lato del mandala. Mi occorrono pochi minuti per attraversare il ghiaione e raggiungere il mio masso. Passo accanto a un grande noce americano, appoggiando la mano sulle strisce di corteccia grigie, e il mandala è ai miei piedi. Faccio il giro, passo dalla parte opposta e mi siedo su una roccia piatta. Mi fermo, respiro l’aria intensa, mi metto in osservazione.”
Queste sono le prime righe del libro La foresta nascosta – Un anno a osservare la natura di David George Haskell, che in questo momento ho al mio fianco sul tavolo.
Per un anno intero lo scrittore, quasi ogni giorno, si è recato sul luogo prescelto e ha descritto quello che vedeva all’interno di un fazzoletto di terra dentro una foresta del Tennessee. È la stesura di osservazioni, sotto forma di brevi capitoli, a partire dagli accadimenti che vede: piccoli processi ecologici, passaggi di animali e insetti, l’alternarsi delle stagioni e il loro deposito.
È un po’ quello che stiamo facendo in queste settimane dentro le nostre case, muovendoci dentro stanze e osservando la collezione dei nostri oggetti e i titoli dei libri sugli scaffali delle librerie. Di alcuni proviamo a rileggere alcune pagine, altri vengono rimessi al loro posto, magari dopo una spolverata con la finestra spalancata sul cortile: l’eco del suono delle copertine una contro l’altra rimbalza sui muri dei palazzi intorno. L’altro giorno ne ho presi in mano troppi e ho cominciato, energico, a sbatterli. All’improvviso mi sono scappati delle mani e, dal davanzale della mia finestra al sesto piano, sono precipitati nel cortile.
Solitario, il Dottor Pasavento di Vila Matas, è stato l’unico a sopravvivere.
In basso, sempre con lo sguardo e l’orecchio verso il cortile interno, due bambine pedalano in tondo con le loro biciclette rosa. Per terra, disegnato con gessetti colorati, un po’ scolorito c’è il gioco del mondo.
Partendo dal coinvolgimento degli autori che hanno partecipato al progetto End. Words from the Margins, New York City* e alla pubblicazione The Sound of The Woodpecker Bill: New York City (con Francesca Benedetto, Lorenzo Giusti, Mario Maffi, Cecilia Canziani, Steven N. Handel, Francesca Berardi, Claudia Durastanti, Anna de Manincor) mi espando verso altre voci e altri sguardi.
Le pagine di questo quaderno, che si alterneranno nell’arco delle prossime settimane, sono una riflessione intorno alla mostra Il suono del becco del picchio inaugurata il 13 febbraio alla GAMeC negli spazi dell’Ala Vitali dell’Accademia Carrara e chiusa a causa dell’epidemia qualche settimana fa.
Non potendo più camminare intorno ai margini delle nostre città e dentro le stanze dei musei, possiamo però inventarci nuove esplorazioni verso geografie che non richiedono sforzi fisici, ma soltanto uno spostamento immaginifico del nostro pensiero, in grado di spalancare finestre su altre possibili realtà.
Ringrazio la GAMeC che mi ha invitato ad arricchire una stanza del suo museo e tutti gli artisti, scrittori, fotografi e giornalisti che hanno accettato di accompagnarmi con il loro sguardo in questo nuovo, improvviso e imprevedibile ‘giro del giorno’, perché la geografia dei luoghi è un’immagine elastica che si allunga e si stringe in base al nostro umore e alla nostra capacità di collegare storie anche molto diverse e lontane nel tempo, come i punti luminosi di una costellazione.
Narrare per immagini è, soprattutto, un modo per immaginare un altro mondo possibile.
Antonio Rovaldi
.
.
.
CAPITOLO 1: LAST STOP
Una lettera a William B. Helmreich
Antonio Rovaldi, artista, Milano, Italia
Milano • via Petrella 9 • 2 Aprile 2020
Caro William,
questa mattina mi sono svegliato che albeggiava. Ho aperto la finestra del soggiorno e c’era un cielo terso con una sfumatura rosa e ancora qualche camino acceso con il fumo bianco. La strada era deserta: uno strascico di inverno misto a una primavera semi sbocciata che ora possiamo vedere solo dall’alto, in questi giorni tristi e sospesi, ma non per questo solo angoscianti nel silenzio protetto delle nostre case. Ho saputo della tua improvvisa scomparsa, a causa di questo maledetto virus, dal mio amico botanico Steven N. Handel che, barricato anche lui nella sua casa da qualche parte nel New Jersey, mi invitava a leggere la notizia attraverso un ricordo pubblicato sul New York Times. Per Steven, forse, era l’ultima email della serata, per me è stata la prima di questa giornata e mi è venuta un po’ di malinconia. Ho ripensato alla breve lettera che ti scrissi circa due anni fa per dirti che avevo cominciato una lunga camminata lungo i margini di New York City che mi avrebbe tenuto impegnato nei due anni a seguire. Avevo cominciato a leggere il tuo ultimo libro The New York Nobody Knows / Walking 6.000 Miles in The City – acquistato da Strand nella sezione dei libri dedicati alla città – durante la primavera del 2016, quando vivevo con Francesca in una casa di mattoni rossi a West Harlem, all’angolo tra la 123a strada e Manhattan Ave. Quella lettera, poi, non te l’ho mai spedita. Steven non sapeva che il tuo bellissimo libro è rimasto dentro il mio zaino per un lungo periodo – tra pellicole fotografiche, quaderni e barrette energetiche – quando cominciai a camminare a piedi l’intero waterfront della città per realizzare il libro The Sound of The Woodpecker Bill: New York City, di cui tanto avrei voluto farti avere una copia. Magari te lo allungo la prossima volta che ritorno a New York, ma chissà quando capiterà. Ho sempre amato moltissimo camminare nei cimiteri, luoghi dove ci si può ancora proteggere dal rumore della città. Spero tu abbia trovato il tuo albero vicino. Tornando al tuo libro, è stato uno dei primi a dare il via a una ricca collezione di testi dedicati a New York City che nei mesi, mentre camminavo intorno ai margini della città fino a raggiungere l’oceano, si sono appoggiati sul mio tavolo, prima nella casa di Harlem e poi nel mio studio in via Padova, qui a Milano, dove ora ti sto scrivendo. Tu e il mio amico Steven del New Jersey, più di altri newyorkesi, conoscete bene il piacere fisico che si prova camminando lungo alcune zone del waterfront di New York City, soprattutto in primavera quando l’aria sa di mare, di cielo pulito e di cementi dolciastri. Sei stato fortunato ad aver avuto un padre che ti ha accompagnato alla scoperta della tua città attraverso il gioco della ‘ultima fermata della metropolitana’– Last Stop – attraverso il quale hai cominciato a esplorare, blocco dopo blocco, i quartieri ai margini e i suoi abitanti, viaggio che poi hai completato nel tuo ultimo bellissimo inno alla città: The New York Nobody Knows. Come ha detto il tuo amico e professore di storia ebraica, Jonathan Sarna, ricordando la tua socialità spiccata nell’articolo uscito il 30 Marzo sul New York Times: “He was in the wrong profession for the coronavirus. Willie loved talking to people. Social distancing was not in his nature.” Ero a New York City solo un mese fa, in occasione della presentazione del mio libro insieme a Steven N. Handel. Il 5 marzo sono rientrato in Italia e dopo pochi giorni la città si preparava alla quarantena. Da quei giorni non sono più uscito di casa. Non so quando potremo tornare a camminare normalmente per le strade delle nostre città. Comincia a mancarmi il mio studio, che è solo a qualche centinaio di metri da casa mia. Oggi dovrebbe arrivarmi il tuo libro, l’ho ordinato per la seconda volta perché l’avevo lasciato a New York a casa di amici.
Spero che la portinaia squilli presto al citofono per dirmi che è arrivato un pacco per me!
Grazie per avermi accompagnato con il tuo sguardo pungente e ironico e il tuo passo curioso verso la fine della città, riemergendo sempre dal fondo del mio zaino ogni volta che mi fermavo a riposare davanti all’oceano con un bagel in mano.
Ci vediamo presto a New York City all’ombra del tuo albero.
Ti porterò in cambio il mio libro, che un po’ è anche figlio del tuo.
Antonio
.
.
William Helmreich, Sociologist and a Walker in the City, Dies at 74 / By Joseph Berger, March 30, 2020 / New York Times
https://www.nytimes.com/2020/03/30/nyregion/william-helmreich-dead-coronavirus.html?smid=em-share
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.

Antonio Rovaldi, dalla serie History of King’s County, Including Brooklyn, N.Y, 1884/2018-2020
____________________________________________________


.
CAPITOLO 3: DARE VOCE AL MEDITERRANEO
Ettore Favini, artista, Cremona, Italia

Au Revoir, 2020, bronzo, vernice murale
Cremona • 6 Aprile 2020
Caro Antonio,
ti ringrazio per questa tua lettera che, oltre agli aggiornamenti quotidiani, mi permette di fare alcune considerazioni relativamente a questo tempo sospeso. Sono ormai da oltre trenta giorni che non mi muovo da casa, se non per le necessità primarie concesse dal Governo. Il due aprile avrei dovuto inaugurare Au Revoir, la mia mostra personale presso il Carré d’Art Contemporaine di Nîmes, curata da Connecting Cultures e attualmente installata in un enorme museo che ha chiuso le sue porte. Tutta la serie di presentazioni relative al progetto e al libro, vincitore della VI edizione dell’Italian Council, sono state rimandate a data da destinarsi. La nostra pratica, più di altre, ci porta a viaggiare per conoscere e mappare luoghi e territori, lo abbiamo sempre fatto, da soli e insieme, e spero potremo continuare a farlo presto. Il mio progetto di indagine intorno al Mediterraneo nasce dalla necessità di raccontare i confini, gli scambi di idee, l’origine e l’evoluzione dei simboli che hanno sempre trovato forma in questo mare circoscritto. Ognuno di noi, di colpo, a livello globale, si è trovato a dover riconfigurare completamente i propri confini quotidiani. In queste settimane ho ragionato proprio intorno all’idea di confine, ho capito quanto questo concetto sia labile e debba essere necessariamente messo in discussione. A proposito di questo lungo progetto, che ha preso forma nel tempo un po’ come il tuo intorno ai margini di New York City – vorrei soffermarmi su un’opera in particolare.
_______________________________________________________________________________________________

Victoire Levasseur, 1833, Carte de la Géographie Primitive des Grecs d’après Homère et Hésiode, collezione dell’artista

Mappe e documenti dall’archivio familiare dell’artista
_______________________________________________________________________________________________
Il ciclo di opere Mer fermée si è ispirato alla geografia, o meglio allo sviluppo cartografico, partito proprio dalla rappresentazione del Mediterraneo in età greca. Sono sempre stato affascinato dalle carte geografiche, non solo perché sono la rappresentazione di una porzione di geografia, più o meno estesa, ma per il significato che noi attribuiamo a uno territorio specifico. La prima mappa del mondo risale a 2500 anni fa, è una tavoletta babilonese in argilla, rinvenuta vicino alla città di Sippar, con un buco al centro circondato da incisioni di forme geometriche e cerchi concentrici. È la prima rappresentazione del mondo conosciuto che a quel tempo si estendeva solo alcuni chilometri oltre Babilonia. L’autore della Mappa Mundi babilonese di Sippar non voleva rappresentare un territorio ma il mondo, e ha deciso di farlo con una visione dall’alto, in pianta: una visione divina del mondo conosciuto che era al momento l’unico mondo possibile. Allo stesso modo, se chiediamo a un bambino di disegnare una mappa, inizierà dalla sua casa – il suo mondo – con gli elementi che la compongono: la sua prima necessità umana di tracciare dei limiti attorno a ciò che conosce.
In questa opera sono andato alla ricerca di carte geografiche, planisferi e mappe che sono state fondamentali per le popolazioni intorno al bacino del Mediterraneo, cercando di capire le ragioni della necessità di tracciare dei confini. Durante la mia ricerca ho scoperto che le mappe sono oggetti magici perché conferivano un potere oscuro sia a chi le realizzava che a chi le possedeva. I cartografi venivano spesso condizionati dalle idee o dalla politica dell’epoca. Sono descrizioni parziali o falsate del mondo, ma sono rassicuranti, perché indicano dove siamo e da cosa siamo circondati, ci danno l’illusione di controllare un territorio o il mondo intero.
La prima mappa in cui mi sono imbattuto, il più antico planisfero di cui si abbia notizia, è attribuito ad Anassimandro (610-546 a.C.), allievo di Talete. La mappa originale non esiste più, come tutti i documenti dei presocratici, ma grazie alla sua descrizione è stato possibile ricostruirla. La sua particolarità è che la parte più importante della mappa non sono le terre, bensì l’acqua. È di fatto una rappresentazione abbastanza reale del mar Egeo, ma anche del Mediterraneo nel suo insieme.
Spero di rivederti presto, tra Milano e Cremona.
Ettore
Qui puoi vedere meglio la mostra allestita al Carré d’Art-Musée d’Art Contemporain a Nîmes
http://www.connectingcultures.it/au-revoir/?lang=en
https://www.carreartmusee.com/en/exhibitions/ettore-favini-158



Mer fermée, 2019, cianotipia su tessuto a mano

Mer de plusieurs noms, 2019, ricamo su jeans
Foto di © C. Eymenier, © M. Monnecchi, © E. Favini
.
.
CAPITOLO 4: EMPTY WALLS (WAITING FOR SIMON)
Farid Rahimi, artista, Milano, Italia
 .
.
 .
.
 .
. .
.
.

.

Foto di © F. Rahimi
.
.
.
CAPITOLO 5: UN’AVVENTURA CROMATICA
Alice Guareschi, artista, Milano, Italia
Milano • 16 Aprile 2020
Caro Antonio,
grazie per il tuo invito. Come credo avrai intuito dai nostri ultimi scambi, in questo momento mi è davvero difficile proiettare lo sguardo verso il futuro — l’immagine è del tutto sfocata — e il mio presente, come quello di molti, è fatto di un tempo sospeso, dilatato, scandito da giornate identiche a sé stesse e da umori incerti. Per risponderti, e dare un mio contributo, ho deciso quindi di rivolgermi al passato, attingendo in particolare a un progetto realizzato ormai più di dieci anni fa, tra il 2009 e il 2012, in cui molte delle tematiche che questo tuo lavoro su New York interroga sono state anche per me oggetto di riflessione e di esperienza diretta. Troverai dunque qui il testo che ha accompagnato il film Bianco Giallo Rosso Nero. Un’avventura cromatica sin dalla sua prima proiezione e che ho voluto includere, qualche anno dopo, anche nel libro omonimo pubblicato a conclusione del progetto — unico contributo scritto a dare voce alla nuova selezione di immagini. È una dichiarazione di poetica, nonché il racconto di un movimento che parte da un’immagine astratta, si fa viaggio fisico ed esperienza diretta, per tornare infine ad una forma di immagine più complessa, perché sintesi di realtà, memoria e sguardo. Ho scelto di condividerlo com’è, senza tagli, senza commento e soprattutto senza provare a reinterpretarlo alla luce dell’oggi, lasciando a chi legge, come e se vorrà, spazio aperto a eventuali parallelismi e totale libertà di movimento, anche se solo della mente, per ora. Teniamoci stretto almeno questo.
Un abbraccio e buon lavoro,
Alice
“Mentre scrivevo il progetto, o meglio provavo a descrivere l’immagine da cui ha avuto origine questo lavoro, sfogliando l’atlante mi è tornato in mente quello splendido film di Herzog in cui lo scalatore Reinhold Messner, intervistato a più di 6000 metri di quota dentro la sua piccola tenda da campo, descriveva le sue spedizioni come gigantesche opere d’arte invisibili: nel salire in cima alle montagne, e durante la discesa che ne seguiva, aveva la certezza di tracciare nello spazio i contorni di effimere ma senz’altro sorprendenti figure. Non avevo mai notato prima che sono quattro i mari a prendere il nome da un colore: il bianco, a nord della Russia europea, all’altezza del circolo polare artico; il giallo, porzione di Mar Cinese Orientale tra la costa cinese e la penisola coreana; il rosso, segno lungo e sottile, stretto tra il continente africano e la penisola arabica; il nero, chiuso tra i paesi dell’Europa sud -orientale e la costa turca e georgiana. Dopo aver scelto un avamposto, un ideale punto di osservazione per ciascuno (in Russia, Cina, Eritrea e Turchia), ho voluto prendere questa imprevista associazione di luoghi lontani che mi si proponeva d’un tratto allo sguardo, questo quadrilatero immaginario che il caso aveva fatto emergere dalla bidimensionalità silenziosa del planisfero, come il pretesto per un’esplorazione, per un grande viaggio in quattro tappe, per una specie di soggettiva ricerca sul territorio. Non che cercassi qualcosa di particolare, la conferma di qualche supposizione, o qualche precisa risposta: volevo in realtà soltanto andare a vedere di persona questi posti. Soltanto attraversarli e guardare. La durata che ho poi scelto di dare a ciascuno dei capitoli, all’incirca tre settimane per ognuno, e le modalità stesse del viaggio per come poi si è svolto, sono divenute contemporaneamente e forse inevitabilmente in seguito anche le caratteristiche strutturanti e insieme il senso più profondo del lavoro. Un pensiero ricorrente mi accompagnava: questo viaggio è un lavoro, questo lavoro è un viaggio. Nessuna distinzione possibile.
In principio si è trattato dunque di seguire le suggestioni di una geografia totalmente astratta, costruita intenzionalmente secondo un criterio, il colore, così arbitrariamente azzardato da arrivare a mettere in relazione contesti del tutto lontani tra loro per storia, tradizioni e paesaggio. Con il desiderio di tracciare fisicamente i contorni di una figura immaginaria andandola a disegnare per davvero col corpo attraverso tre continenti, e associare ai nomi neutri dei luoghi la verità pur istantanea e parziale di qualcosa che è stato visto. Ma nel corso del viaggio, nel corso dei giorni e di una temporalità necessariamente alterata dalla lontananza, è stata la forza dei posti che stavo attraversando, la loro specifica e multiforme realtà con i suoi diversissimi codici, a scagliarsi prepotentemente in primo piano, azzerando qualsiasi principio di astrazione per riportarmi con forza su un piano decisamente esistenziale, fatto di interrogativi, di straniamento, di fatica fisica, di stupore, di dubbio, di certo molto lontano da una dimensione di quieta contemplazione, e molto prossimo invece alla tensione e alla carica di imprevedibilità propria di una performance. Questo scarto tra l’immagine o l’idea di una cosa e la sua esperienza è per me un aspetto davvero interessante. Il ritorno a casa, e il lavoro di montaggio del materiale raccolto, segnano infine una terza fase del processo di relazione con i luoghi, in cui la distanza geografica, l’oblio inevitabile dovuto al passare del tempo e alla ritrovata familiarità con gli oggetti intorno, il richiamo all’ordine della memoria in vista di una narrazione, e la suggestione ormai fantasmatica delle cose vissute, arrivano quasi a sovrapporsi. Una fase che riporta nuovamente, come se si chiudesse un cerchio, la moltitudine selvatica delle esperienze a un piano bidimensionale, a una geometria spaziale che si snoda nella durata del video, a un altro, seppur diverso, modo di comporre un atlante: questa volta soggettivo, frammentario, abitato e in movimento. Non credo esista sintesi possibile per quello che ho visto. Mi piaceva piuttosto l’idea di comporre un paesaggio continuo, irrealistico geograficamente ma non per questo non vero, un territorio immaginario in bilico tra la registrazione diretta della realtà e la sua messa in scena attraverso la scrittura filmica. Quattro colori, quattro paesaggi. Una sinfonia in quattro tempi.”
Alice Guareschi, settembre 2009
 .
.
 .
.

.
Il film Bianco Giallo Rosso Nero. Un’avventura cromatica (miniDv colore 92′, 2009) è stato realizzato grazie alla Borsa per i Giovani Artisti Italiani degli Amici del Castello dei Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, edizione 2008.
Il libro d’artista Bianco Giallo Rosso Nero. Un’avventura cromatica è stato pubblicato da Edition Taube nel 2012 in edizione numerata di 200 copie.
.
.
CAPITOLO 6: THE WONDER BOOK
Alessandra Spranzi, artista, Milano, Italia
Oggi, 13 aprile 2020, ho trovato 6 collage in un libro, The Wonder Book of Nature, edito da Harry Golding F.R.G.S. nel 1927.
Spesso, per descrivere quello che faccio, potrei iniziare scrivendo così: ho trovato.
O anche, sono stata trovata.
L’immagine appare, inaspettata. A un certo momento, con una strana precisione.
Aprendo il libro, ho trovato sei pagine con fotografie di alberi importanti – Trees you should know – in cui nell’angolo in alto è evidenziato il dettaglio delle foglie.
Tagliato, sagomato, con forme diverse. Ogni foglia ha la sua forma, la sua geometria.
Un montaggio, veloce e non nascosto, che cambia la misura dello spazio e dello sguardo.
Guardo le foglie, le tocco, e poi corro lontano, mi fermo, mi giro e vedo l’albero tutto intero, la sua sagoma, la sua altezza (se un uomo gentilmente si mette in posa sotto).
Si dice che se ci si addormenta all’ombra di certi alberi venga mal di testa e i sogni siano pesanti.
Anche l’ombra è importante conoscere.
Spesso quando finisco o riguardo un collage ho la sensazione di non aver fatto o deciso niente.
Come fosse avvenuto in uno stato di dormiveglia, o di assenza momentanea. Trovato.
 .
.
 .
.

.
A – Z
AMATEUR
Due giorni dopo, 15 aprile 2020
Guardo, come ho fatto tante volte, l’indice dei nomi comuni e scientifici di fiori e piante dal libro Amateur Gardening (The Gardener’s Treasury of Plants, Trees and shrubs), edito da A.J. Macself nel 1934.
Anche il libro comincia con la A.
Amateur.
Li leggo anche ad alta voce.
Si comincia con la lettera A.
È la prima lettera dell’alfabeto, oltretutto.
È anche l’iniziale del mio nome e del tuo, che mi hai invitato.
Se il fiato non si esaurisce, si può continuare con la lettera B, poi la C.
Si gira la pagina e si continua, fino alla Z.
Dopo i Botanical Names, ci sono i Common Names.
Si ricomincia, dalla A alla Z.
.

.

Milano • via Petrella 9 • 2 Aprile 2020
Ciao Alessandra,
mi manca molto non potermi riposare sotto un albero americano con il fusto largo, da qualche parte in un bosco di Staten Island dove, non di rado, si vedono i cervi.
Ora posso ombreggiarmi in soggiorno sotto il mio ficus indiano con il tronco intrecciato, che in queste giornate luminose è cresciuto molto. Pare che le piante, se in casa, una volta trovata la giusta posizione, sia meglio non spostarle. Non ricordo dove l’ho letto, ma sembra essere una giusta osservazione, quindi io non muovo nulla e lascio crescere.
Del resto, fuori, le piante restano ferme dove si trovano.
Ciao
Antonio

.
.
.
CAPITOLO 7: PIEDI NELLA FORESTA
Ivan Carozzi, scrittore e giornalista, Milano, Italia
Caro Antonio,
sono rimasto molto colpito da una foto dei piedi di Mike Fay. Fay è un biologo e un esploratore ambientalista, originario del New Jersey. È diventato famoso per la spedizione chiamata «MegaTransect», con la quale nel 1997 ha attraversato seimila chilometri di foresta equatoriale, tra il Gabon e il Congo. In questo viaggio ha incontrato elefanti che probabilmente non avevano mai visto un sapiens, a quanto afferma Fay. Inoltre Fay dice di aver raccolto da terra un guscio di noce che, stando a una sua supposizione, poteva risalire a prima di Cristo. Quindi una noce che è più antica della religione cristiana.
Ho letto un’intervista a Fay pubblicata nel 2017 sul sito del National Geographic. All’interno di questa intervista ho avuto modo di osservare una foto nella quale si vedevano i piedi di Fay. Non so se la foto risalga al 1997, cioè all’epoca del MegaTransect. Fatto sta che in ogni caso, come testimoniato in un documentario, a differenza delle guide bantù e pigmee che lo avevano accompagnato, Fay aveva attraversato la foresta in pantaloncini corti, a gambe scoperte, e con i piedi, altrettanto nudi, chiusi in un paio di sandali. Come nella foto.
Quindi ho guardato questi piedi, repellenti, sporchi. L’alluce destro è ferito. Il contatto prolungato con la terra e il fango sembra aver annerito per sempre il colore dell’incarnato. Le unghie paiono tagliate in fretta, servendosi di una lama primordiale, non certo di un paio di forbicine. La ripetizione orizzontale e fittissima dei solchi forma una trama di micropieghe, come nelle masse rocciose.
Quando ho visto questa foto, sono rimasto immobile e meravigliato. L’immagine si è fissata nella memoria. Avevo visto il documentario sul MegaTransect e sapevo da dove venivano quei piedi, avevo una mezza idea dei luoghi estremi e inaccessibili per i quali erano passati. È stato come se per la prima volta io vedessi un paio di piedi, l’idea di ciò che un piede è e la sua più radicale espressione terrena, e mi rendessi conto della consistenza della pelle, della scorza, dello spessore e della resistenza della quale la pelle di un piede è capace.
La foto mi ha impressionato, forse anche perché eravamo agli inizi della pandemia e al centro della mia attenzione c’era il virus e la sua capacità di attraversare il corpo. Vedere rappresentata in una foto la durezza della pelle di un piede umano mi ha rimesso al mondo e mi ha dato forza. Tutto qui.
Un saluto ai tuoi instancabili e pensanti piedi,
Ivan
.

.

.

Foto di © J. Michael Fay
MegaTransect era il nome di un progetto condotto in Africa nel 1999 dall’esploratore ecologista americano Michael Fay. Una spedizione a piedi di 456 giorni per 3,219 chilometri all’interno del Congo Basin, nell’Africa Centrale, regione conosciuta come Africa equatoriale.
La spedizione MegaTransect è stata concepita come una ricognizione ecologica in una striscia di vegetazione su larga scala che potrebbe essere utilizzata per eseguire un censimento ecologico degli ecosistemi. Le immagini sono state prese dal documentario MegaTransect.
.
.
.
CAPITOLO 8: PER FARE COSA
Anna de Manincor, artista e filmmaker, Bologna, Italia
Palesio • 13 Aprile 2020 (Lunedì dell’Angelo)
Ciao Antonio,
cosa darei per riavere quel monsone errante che esattamente un anno fa ha portato tanta pioggia in Italia. Un po’ di pioggia cambiava il nostro umore e qualcuno dei nostri programmi. Non sapevamo di essere fatti di ben altra fibra, ben altro è quello che ci sconforta adesso. La nostra lieve meteoropatia era lì per dire che siamo sempre legati a tutto. E adesso siamo invasi da quel tutto, dal tempo che abbiamo violato. Abbiamo accelerato così tanto che ci siamo superati e non ce ne siamo accorti, non ci siamo riconosciuti, con quelle facce incollate ai finestrini e agli schermi, morti di sonno come siamo. Posso rinunciare per sempre agli aerei presi al volo come autobus, agli appartamenti affittati con un clic, agli acquisti online, a tutti i tipi di delivery, alla fibra, alle app, agli assembramenti al bar, davvero, anche a tempo indeterminato. Ma non alle persone, alle famiglie allargate, agli imprevisti, agli incontri casuali, agli abbracci tenuti lunghi, ai balli sudati dove poi si prende freddo e viene il raffreddore e nessuno se ne cura.
Alle notti sui divani degli amici e degli amici degli amici. Alle tisane nella tua cucina a parlare di arte, di amore e della morte, finché è così tardi che è già domani. E bisogna uscire, bisogna andare, bisogna tornare. Non so se sarò capace di cambiare, la mia pellaccia è una pelliccia dove mi sento ibernata. Quando mi scongelerò sarò virulenta e si capirà che non ho fatto tesoro di questo tempo per pensare. È vero, non faccio che divagare, dilagare, derivare, delirare. E poi camminare! Ma ci pensi quanto abbiamo camminato e non potevamo immaginare… che vertigine, non lo so neanche dire.
Son passate un po’ di ore e sono tornata in grado di concentrarmi per qualche minuto di seguito. Rileggo le note conclusive del testo qui sotto, proveniente da quell’altra vita in cui tribolavo su un film senza nome coi miei compari. Cercavo di spiegare quel senso di frustrazione e di inquietudine per quelle cose che si intuiscono ma non si sanno dire, che si iniziano ma non si è buoni di finire: il presentimento di dover rifondare, trovare un terreno dove dimorare e partecipare alla storia collettiva.
Ecco ci siamo: aprile 2020, è quello che stiamo facendo ora. Senza rivelazioni, solo stando dove siamo e cercando di capire come ci siamo arrivati, in quanti diavolo siamo, da che porta usciremo, come ne usciremo, per fare cosa.
Nina
.

.
Il cielo verde, l’asfalto blu, esplodevano anche gli idranti
Anna de Manincor | ZimmerFrei
Testo tratto dalla pubblicazione The Sound of The Woodpecker Bill: New York City, Humboldt Books, 2019, parte di End. Word from the margins, New York City di Antonio Rovaldi, progetto realizzato grazie al sostegno dell’Italian Council (V edizione, 2019), programma di promozione di arte contemporanea italiana nel mondo della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo.
Esattamente dieci anni fa un monsone errante si abbatteva su New York e produceva una primavera anomala, come quella che quest’anno affligge lʼItalia (1) . Era l’inizio di giugno e pioveva ogni giorno.
Verso l’ora di pranzo cambiava il vento e la solita brezza che scende da Upstate lasciava il posto a uno strano vento caldo e umido che saliva dall’oceano.
Nel 2009 Antonio Rovaldi ed io ci trovavamo nello stesso luogo, al 1040 di Metropolitan Avenue, a due porte di distanza. La residenza in uno degli studi dell’ISCP – International Studio & Curatorial Program – era frutto di un premio che adesso non potrebbe più esistere: una nostra foto era stata selezionata per la copertina dell’elenco telefonico dell’Emilia-Romagna e si era aggiudicata il premio nazionale, sei mesi a New York. Anzi, a Brooklyn.
Dico ʻnostraʼ foto perché tutta la mia vita artistica e lavorativa è sempre stata plurale. Il nome collettivo ZimmerFrei è la capanna sotto la quale abbiamo dimorato in tre persone per quasi diciotto anni: Massimo, Anna e l’altra Anna che sono io. Non essendo riusciti a moltiplicare il grant per tre abbiamo dovuto dividerlo, e così ognuno di noi ha passato un periodo da solo a New York a nome di tutto il gruppo. Ognuno si è scelto i propri posti e le proprie abitudini, ma ad ogni arrivo si passava un periodo insieme per il passaggio del testimone.
Massimo mi ha fatto scoprire B&H (2) , il mondo dei sogni foto-audio video gestito da ebrei ortodossi a Midtown West, e mi ha portato alla Dream House (3) in Church Street, l’installazione sonora permanente di La Monte Young e Marian Zazeela dove nonostante l’altissimo volume si fanno meravigliose dormite sulla moquette alta tre dita. I miei luoghi segreti erano la practica di tango la domenica pomeriggio dietro Union Square, al quarto piano del quartier generale dell’immobiliare Katz, e la milonga nel ristorante Ukrainian East Village, dove andavo un po’ alla chetichella dopo le proiezioni all’Anthology Film Archives (4) , a notte fonda quando restavano solo gli insonni. Anna R. invece aveva scoperto un movimento di ʻexperimental geographyʼ e aveva preso a seguire un certo Matt (5) e il suo gruppo di camminatori e attivisti. Massimo è sempre stato un amante delle camminate senza meta, Antonio e Michael (6) avevano già iniziato a sgambare in lungo e in largo per i cinque i boroughs con il loro passo rapido.
Senza sapere l’uno dell’altro, a un certo punto siamo stati tutti contagiati dal sacro fuoco del camminare. Una pratica estenuante in una città inesauribile, ma tantʼè. In questa specialità io sono solo una peón, mi porto sempre appresso uno zaino troppo pesante e mi fermo troppo spesso a guardare qualcuno senza osare fotografarlo. Chi invece ne ha fatto una pratica costante, quasi agonistica con o contro se stesso, ha trovato una miniera in cui discendere sempre più a fondo, traendone pensieri, poesia, immagini fuggevoli, ricordi permanenti, nodi, respiro. Per parte mia, le mie dilettantesche scarpinate finivano sempre nello stesso modo: linea L. Tornare a Brooklyn era tornare a casa. E nel tunnel sotto lʼEast River mi addormentavo regolarmente.
Dunque si era tra la fine della primavera e l’estate e la residenza volgeva al termine. Il nerbo alpino infilzato nel nostro terzetto richiedeva di radunarci e trarre un qualche frutto da quella magica stagione di privilegiato sabba newyorkese. Diciamo un film. Il nostro brief summary a uso interno recitava così: “Documentario poetico ambientato nel nostro futuro e dislocato a NYC. Un non-fiction film che usa alcune zone remote dei quartieri della città di NY come reagente per far emergere cose altrimenti invisibili (identità auto-fondate, esotismo reciproco tra vecchia Europa e capitale immaginaria dell’Europa oltreoceano, proiezioni di immaginario epico, visioni di futuro)”.
Ci eravamo trasferiti nell’ennesima casa in prestito, una casetta con giardino a Fort Green (7), che era diventata il quartier generale della produzione del nostro film sperimentale. Tutta questa storia è tornata fuori mentre scrivevamo il testo per la mostra di ZimmerFrei da CLER (8) , lo studio di Antonio a Milano, parlando delle foto che abbiamo scattato entrambi alla fine di una giornata passata insieme a Coney Island (9).
.
Massimo: “Ma il camera-car che abbiamo girato lungo il canale Gowanus dov’è finito? Ti ricordi quell’inizio estate in cui pioveva ogni giorno?”
Anna: “Era come adesso, pioveva sempre, ogni giorno scendeva un tendone dʼacqua”. (10)
.
C’erano laghi dʼacqua nelle strade, il cielo verde, l’asfalto blu, esplodevano anche gli idranti. Il girato di quel giorno in cui pioveva come lʼapocalisse l’abbiamo perso tutto. Sono stata io, ho fatto una di quelle cazzate (idiozie) che poi mi sogno di notte per anni, cerco di fare rewind ma il tempo non si riavvolge. Era il giorno in cui avevo intuito che quel piano sequenza che finiva davanti al campo da basket allagato era l’immagine chiave, la visione dove tutto il montaggio doveva convergere. Ma il giorno dopo ho sovrascritto proprio su quella cassetta Mini DV, credendo di averla già acquisita su disco rigido. Quello che ho imparato è ben poca cosa, non devo mettermi a fare archiviazione a notte fonda. Sai che scoperta – come se non lo sapessi.
Di quel giorno ci è rimasta solo l’alba in cui abbiamo tamponato un truck in Kent Avenue e abbiamo aspettato la polizia per tutta la mattinata. Quel film non l’abbiamo mai finito e mai montato.
Non riuscivamo nemmeno a scriverlo, ogni volta che ne parlavamo si apriva una nuova pista. Se devo essere sincera non ho mai amato gli incompiuti, i progetti abortiti preferisco archiviarli e non pensarci mai più. Vengo dalle montagne, di quello che non esiste non si parla.
Ma Antonio ha insistito e sono andata a rileggere l’edit list dei girati giornalieri.
PRESAGI
Il cane attaccato dal corvo | Due uccelli trovati morti in giardino | Volo di uccelli: stormi di storni (Brighton Beach) | Voli di aerei: solchi nel cielo, strade maestre e tangenti | Suono ricorrente di elicottero | Thunders & storms, cielo in movimento, palazzi blu, cielo color piombo | Pioggia di notte sotto luce lampioni.
SCENA DI APERTURA / COMUNITÀ DI TESTIMONI
S. Oxford St., tableau vivant: barbecue rituale in giardino all’imbrunire, tutti in piedi con sguardo in macchina, immobili con i piatti in mano (Antonio con in mano la custodia di una macchina fotografica in finta pelle, Rä con un calice di bianco pericolosamente inclinato, Anna R. con calze cobalto a metà di un passo in avanti, Massimo di tre quarti. Il cane con la schiena ferita dal corvo è l’unico che si muove → esce dal quadro verso sinistra).
FLASHBACK / ATTO PROPIZIATORIO
Rogo 1: enorme fugaràza (11) di San Giuseppe sulla spiaggia di Rimini.
SOGNO PREMONITORE
Myrtle e Vanderbilt Avenue, Gulf Gas Station: murales a caratteri cubitali ʻAchtung Baby, Here Comes the Next Great Depressionʼ (+ réclame di Chez Lola Restaurant).
FLASH-FORWARD
Lungo il canale Gowanus, davanti alla ex-fabbrica: rogo nello spiazzo di cemento spaccato dall’erba (ripresa interrotta dall’arrivo della polizia, voce off al megafono: “Get out of the gate with your hands up”).
SGUARDI IN MACCHINA
Il bambino muto dietro il bancone di Freddyʼs Deli | Lo sguardo del bassotto nella vetrina delle mozzarelle su Metropolitan Avenue | Nick e sua madre allʼItalian American Grocery | Vecchio da solo al bancone del diner Honey-Chicken-Barbecue.
VEGLIA / ATTESA
Dumbo: Notte sul tetto (terrazza di Monia, amica di Antonio) | Long Island City: Veglia su tetto 2 (casa di un certo Joseph Coletti – memoriale domestico sul naufragio del Titanic).
PARTENZE / TRASLOCHI / RELOCATIONS
Visite con agenti immobiliari albanesi (Durata e Albina): casa in vendita 1 (Vanderbilt Avenue, Brooklyn), casa in vendita 2 (Harlem Studios)|Governor Island: interno di casa vuota con impronte di mobili e quadri visibili sui muri|Trasloco a Chelsea: tutta una vita dentro le scatole|Homeless con carrelli-casa|Antonio fermo in strada con grandi borse di plastica|Antonio riparte per lʼEuropa e lascia la casa ex-convento di Lorimer.
NUOVA COLONIA / COMUNITÀ DEL FUTURO
Coney Island: bambini sparpagliati sulla spiaggia al tramonto, tutti fratelli, i visi dipinti da Jocker, due in mutande e maglione con le gambe in acqua, le frange del tallit che spuntano da sotto la canottiera, nessun adulto allʼorizzonte|Wallabout Street: una dozzina di ragazzine e bambini satmar occupano tutto il marciapiede, biciclette BMX, riccioli, calze di filanca nera, vestiti lunghi fino alle caviglie con colletti bianchi, grembiuli a fiori (un altro secolo, un altro pianeta).
LA BESTIA UOMO
I meccanici messicani che dormono con la bocca aperta seduti davanti ai resti del pranzo nel garage vulcanizadora di Grand Street e Morgan | Il pollo rituale della domenica a casa di Robert Storr a Carroll Gardens | Le quattro portoricane che cenano col tavolino in strada | Ennesimo idrante rotto: la donna di cento chili seduta sulla sedia da giardino fuma una sigaretta sotto un arcobaleno d’acqua.
PRESAGI 2
Donna nel campo da soccer: predizione del futuro collettivo (American Spanish) | Harlem: il predicatore ubriaco nel retro del Saint Nickʼs Pub|Bronx, in fondo a Arthur Avenue, D’Auria-Murphy Triangle: sparo. Tutti scappano dal giardinetto. Un nonno obeso resta seduto sulla panchina e chiama il nipote: eXavieeeeeer!
HAUNTED PLACES
Flatbush: campi da handball (uomini seminudi prendono a sberle una pallina, a mani nude contro muri di cemento) | Gowanus, J.J. Byrne Playground: panoramica 360° a pelo d’acqua, al centro della pozza grande come tutto il campo da basket. Si aprono le nuvole, sole calante rosa e viola (tramonto color dell’alba), acqua color petrolio, (→ stessa direzione della panoramica) due bambini a bordo acqua disegnano la riva del lago col gesso.
FONDAZIONI
Cantiere con gettata di fondamenta sotto il ponte verso il New Jersey: delimitare sito fondazione con nastro giallo CAUTION | Scavi notturni, pali di ferro e plinti in legno affogati nel cemento, terreni sbancati (sito archeologico visto dal futuro).
IL PIANETA TERRA
Sparare razzi di posizione a Brighton Beach ← segnali in Atlantico verso l’Europa (rifilmare dal largo) | Long Island: onde lunghe (ciclo di 3+5, l’ultima si chiude a tubo) | Bagnini sui trespoli arancio davanti alle onde grigie di Rockaway | Arrivo a Moses Park sotto la pioggia battente (dub di Massimo nell’autoradio (12) ): due caprioli alla rotonda sotto la torre, cerbiatti tra i cespugli | Ocean Parkway: conigli lungo la strada | Babylon: grande parcheggio vuoto, Cadillac rossa con tettuccio beige parcheggiata in un posto qualsiasi (l’orizzonte è così ampio che si vede la curvatura della terra) | Camera-car: Lighthouse Road, Fire Island, Water Island, Hampton Dunes, destinazione Montauk.
APOCALISSE
NORD: Maratona, punto macchina in centro-strada verso Broadway Bridge: gente che corre di spalle, avenue deserta, gruppetti sparuti e claudicanti. La corsa degli ultimi | SUD: Il maestoso mall dei rifiuti di Staten Island, vapori e fuochi fatui | EST: spiaggia di Montauk, indistinguibile tra la bruma della sera che scende e la schiuma gialla delle onde sulla sabbia fradicia che non assorbe più nulla. L’acqua salmastra di Fort Pond trova la strada verso l’aperto, l’acqua amara dell’oceano dilava la terra, acqua dolce di pioggia che scende da giorni, acqua ovunque.
END / TITOLI
Bronx Playground: scritte START, FINISH sul tartan, quadrati con numeri cabalistici e piedi di bambini con corpo fuoricampo (gioco della campana?) | End (Landmark) | Dead End.
Non c’erano personaggi, a parte gli italo-americani che guardavano fisso in macchina senza parlare, non c’era una storia, solo una serie di piani sequenza, lunghi totali con noi di schiena e il presentimento di dover rifondare, trovare un terreno dove dimorare e partecipare alla storia collettiva.
La città però non era destino che fosse Brooklyn. Poi sono venute le ʻcittà temporaneeʼ 13 : Bruxelles, Budapest, Bologna, Marsiglia, Ginevra, e questo film non è mai uscito. Abbiamo capito molto dopo che quello era uno dei rari momenti di puro nutrimento, la restituzione è ora. Ecco, ha ricominciato a piovere.
.
 .
.
 .
.
 .
.

.
NOTE
(1) Il testo è stato scritto un anno fa, tra aprile e maggio 2019.
(2) Superstore su due piani, ubicato al 349 di West 34 th Street, dedicato alla rivendita di apparecchiature fotografiche e attrezzatura audio e video, con un incredibile sistema di rotaie sopraelevate che fa circolare la merce sopra le teste di clienti e commessi fino ad arrivare alle casse. Il sito web di B&H si rivolge così ai suoi visitatori: “Whether you’re a professional, a dedicated enthusiast or just a savvy shopper, prepare for an epic, tactile shopping experience youʼll always remember” (www.bhphotovideo.com).
(3) www.melafoundation.org.
(4) Annotare, ricordare e sciorinare i nomi dei luoghi è un morbo che affligge sia Antonio che me (in compagnia di molti altri, tra cui il maestro George Perec) e funziona come una personale songline, come la chiamerebbe Bruce Chatwin. Punti precisi del territorio che, al solo nominarli e inanellarli, sono in grado di produrre sia i luoghi stessi che i loro miti fondativi.
(5) Matt Greene ha fatto parte per anni del gruppo Burnsomedust ma il sito www.burnsomedust.com avverte: “Matt has taken a break from Hey, Iʼm Walkinʼ Here! since he started his walk across the USA.” Il viaggio pare sia ancora in corso.
(6) Antonio Rovaldi e Michael Höpfner, Shorakkapoch, 2009. Video di documentazione della camminata lungo la Broadway, da Wall Street fino a Inwood Park, lʼuno senza vedere, lʼaltro senza udire.
(7) Casa-residenza a Brooklyn, S Oxford St, di proprietà del Ministero della Cultura e della Scienza della Bassa Sassonia e Fondazione Sparkasse, temporaneamente lasciata libera dal duo di artisti di Hannover Lotte Lindner e Till Steinbrenner. Rendiamo grazie a Lotte e Till.
(8) CLER, via Padova 27, Milano. Studio condiviso da Antonio Rovaldi con i grafici Alessandro Costariol e Francesca Biagiotti e il fotografo Andrea Camuffo.
(9) ZimmerFrei, Tomorrow is the question, 12 stampe digitali su legno, 2010. www.zimmerfrei.co.it/?p=199.
(10) Città Nuda (Ah, but remember that the city is a funny place), CLER, Brochure n. 06, Milano 2019. Conversazione tra Anna de Manincor, Massimo Carozzi e Antonio Rovaldi, in occasione della mostra personale di ZimmeFrei Città Nuda da CLER.
(11) La Fogheraccia, conosciuta anche come Focarina o Focheraccia (in riminese fugaràza) è un’usanza della tradizione contadina della Romagna
che si ripete ogni anno nella notte del 18 marzo, vigilia di San Giuseppe. Consiste nell’accensione di grandi falò che bruciano cataste di rami, stoppie, potature, legni venuti dal mare (e anche vecchi mobili o oggetti appartenuti a morti che tardano a liberare il campo anche da defunti). Le pire di fuoco avevano una funzione allegorica: liberarsi delle temperature rigide dell’inverno e propiziare l’inizio della primavera. Le fugaràze possono anche essere anticipate o ripetute per combattere il gelo fuori stagione (come quello di quest’anno) e sono occasione di feste popolari fatte di canti, balli, grandi grigliate e sonore bevute.
(12) Weight and Treble, Blind Star, 2010. soundcloud.com/weightandtreble/blind-star.
(13) ZimmerFrei, Temporary Cities (2010-2018), sette documentari su luoghi e quartieri in trasformazione in sette città e cittadelle dʼEuropa.
www.zimmerfrei.co.it/?p=1432.
CAPITOLO 9: LA DOMENICA DELLE PALME
Una conversazione a distanza
Antonio Rovaldi e Alessandro Biggio, artisti, Milano e Cagliari
Milano • 26 Aprile 2020
Alessandro,
mi sono svegliato presto!
Sono giorni in cui la mattina ha una luce bellissima che entra dalla finestra del soggiorno, spazio dove in queste settimane si consumano buona parte delle mie giornate. Verso le sette un fascio di luce si appoggia sul muro sopra il divano, raggiunge la baia di Galway — che in gaelico irlandese è Cuan na Gaillimhe — e si allunga in una sequenza di sei fotografie dove al centro c’è un faro e in tutte, a distanza diversa, un uomo che cammina. Molti anni fa, quando vivevo a Galway, avevo visto camminare questo vecchio su una spiaggia che collegava la mia casa con una isola di nome Rabbit Island. Pare che l’isola fosse popolata da famiglie di conigli bianchi, da lì probabilmente il nome. Io non ne ho mai visti. Quel giorno seguendo il passo lento del vecchio e il suo bastone, raggiunsi quello scoglio e mi mimetizzai nell’erba alta e spessa che copriva la roccia. Il vecchio, da lontano, alzando in aria il suo bastone per meglio farsi notare, con il suo accento irlandese mi disse di non addormentarmi perché, da lì a poco, sarebbe risalita la marea e quella striscia di terra che ci aveva fatto da ponte all’andata, si sarebbe velocemente ricoperta di acqua gelida e se non volevo restare tutta la notte su quello scoglio, sarebbe stato meglio che io cominciassi a rientrare con lui.
Così riemersi dall’erba imbambolato, alzai un braccio in cenno di saluto e scattai ancora una fotografia alla schiena di quel vecchio e pensai alla poesia The Strand che il poeta irlandese Seamus Heaney dedicò al padre, vecchio anche lui, che camminava sulla spiaggia di Sandymount, nella baia di Dublino dove ora, dallo schermo del mio computer, vedo che sta correndo una bambina…
Tre versi e in un unico gesto una durata così ampia…
The Strand
The dotted line my father’s ashplant made
On Sandymount Strand
Is something else the tide won’t wash away.
(Anche la linea incerta tracciata dal bastone di mio padre
su Sandymount Strand
è qualcosa che la marea non porterà via)
Da The Spirit Level, Seamus Heaney, Mondadori 1996 (questo libro dalla copertina tutta rossa, estratto dalla mia libreria, è datato 2000).
Questa breve poesia aprì il mio primo libro che prese il suo titolo a un’altra poesia di Seamus Heany: Markings / Marcamenti e in copertina c’era l’immagine di un faro in mezzo alla baia di Galway, lo stesso delle fotografie sopra il mio divano. Suonava l’anno 2005. Quel libro lo realizzai insieme al curatore e critico, nonché caro amico, Davide Ferri e pensa che proprio ieri mentre riprendevo in mano la raccolta The Spirit Level — dove alla pagina 133 si trova la poesia The Strand — mi ha telefonato da Roma.
Da una casa romana che non vedo da molto tempo — a Roma non sono mai più tornato dopo che ho lasciato la galleria Monitor con cui ho lavorato per dieci anni — sono passato a pensare a te e alla tua isola e al tuo balcone; tu un po’ arrabbiato perché ieri non riuscivi a fare stare in piedi una scultura di cenere con i solchi bagnati lasciati delle tue mani. Mi hai mandato una fotografia sul cellulare con un senso di frustrazione e fallimento per quel crollo di cenere che, per un attimo, ho avuto quasi paura. Settimane di finestre, balconi, soggiorni, cucine e ancora finestre. Sono così arcaiche le tue sculture e così antico il gesto che le fa nascere: il fuoco delle palme che bruci nella tua casa a Calasetta, la cenere che raccogli ogni anno nei sacchi neri, le tue mani che cercano di trovare una forma del tempo dentro quel materiale così carico di memoria eppure così effimero.
Mi hai detto che non puoi andare nel tuo nuovo studio, che ti manca la laguna dove il tuo spazio si affaccia — i fenicotteri — e che da casa riesci a lavorare male perché lo spazio del balcone non basta. Ma da casa tua, il mare, lo vedi?
Quando avevo raggiunto Cagliari in bicicletta per concludere il progetto ciclopico Orizzonte in Italia (2011-2015), mi fermai a dormire in città solo una notte, ma ricordo bene il lungo Viale del Golfo, con il mare da una parte e le saline dall’altra, Lorenzo che da Nuoro mi messaggiava spesso per sapere a che punto stavo, se avevo mangiato bene a casa di Gristolu e se ce l’avrei fatta a raggiungere Gavoi seguendo il calendario di marcia senza tradire le tappe decise in partenza.
Non tradii la tabella di marcia ma arrivai a Gavoi sfiancato dalla stanchezza (ero partito non allenato), terrorizzato dai pastori maremmani che mi inseguivano abbaiando ovunque per la Barbagia. Pare che i pastori maremmani siano belli matti e bisogna stare attenti — soprattutto quando si pedala, perché sono imprevedibili. Nessuno me l’aveva detto, l’ho scoperto pedalando.
Quella sera, a Gavoi, mi salì la febbre.
In che punto della laguna si trova il tuo studio? Me lo indicheresti sulla mappa, intanto metto su la seconda moka del mattino.
E pensare che in questi giorni avremmo dovuto inaugurare la tua mostra da Cler in via Padova, insieme a Linda Fregni Nagler e Gaia Carboni. Ci tenevamo così tanto. Gaia aveva costruito nel giardino della casa dei genitori in Romagna dei forni con mattoni refrattari rossi. Insieme a suo padre monitorava con cura tutte le fasi della cottura, fuori e dentro le buche scavate nella terra con la pala. Linda mi ha mostrato poche immagini dal suo archivio che avrebbe voluto esporre: un’antica eruzione del Vesuvio e corpi carbonizzati nella lava e un calco degli stessi, realizzato molti anni dopo. Sai che un’impronta lasciata sulla superficie lunare può restare immutata per 3.500 milioni di anni? Una specie di eternità. L’ho scoperto leggendo il libro di Stefano Catucci Imparare dalla luna* dove un uomo — bardato come noi quando usciamo di casa in questi giorni per andare al supermercato — saltella sulla superficie lunare lasciandosi alle spalle le impronte dei suoi scarponi.
Alla pagina 49, nel primo paragrafo del libro, con un pennarello rosso ho sottolineato: «Abbiamo fatto tutta questa strada per esplorare la Luna», avrebbe commentato ancora Bill Anders, «e la cosa più importante che abbiamo scoperto è stata la Terra».
Prima o poi ritroveremo il ritmo nel nostro lavoro e potremo tornare in studio e inaugurare la mostra dedicata alla luna e alla cenere.
Speriamo di non dover attendere 3.500 milioni di anni!
Ti abbraccio,
Antonio
*Stefano Catucci, Imparare dalla Luna, Quodlibet 2013

Antonio Rovaldi – Rabbit Island. Nel soggiorno di casa mia a Milano. Mattina presto. La luce si sposta su sei fotografie sopra al divano. 26 aprile 2020.
.

Antonio Rovaldi – Milano. Google Earth. Bambina che corre sulla spiaggia di Sandymount Strand, nella baia di Dublino. 26 aprile 2020.
.

Antonio Rovaldi – Milano. Il libro di Stefano Catucci Imparare dalla luna (Quodlibet 2013) aperto sul mio tavolo alla pagina 48-49. La didascalia della fotografia alla pagina 48 dice: Figura 4. Earthrise, fotografia di Bill Anders (Apollo 8) scattata il 24 dicembre 1968 da una distanza di circa 385.000 km dalla Terra. 23 aprile 2020.
.

Alessandro Biggio – Dal balcone di Cagliari. Lavorazione di una scultura in cenere. Terzo tentativo. Aprile 2020.
.

Gaia Carboni – Cottura dei manufatti in argilla nel forno auto costruito a casa dei miei genitori in campagna a Chiesuola di Russi, nei pressi di Ravenna. Autunno 2019.
.

Linda Fregni Nagler – Untitled (VULC-028-ML-LFN), 2020, Positive print of lantern slide on barite paper. Cagliari, 18 aprile 2020.
_______________________________________________________________________________________________
Cagliari • 18 Aprile 2020
Caro Antonio,
quante immagini e momenti e sensazioni diverse mi porta la tua lettera. Credo ci vorrà tempo per farle sedimentare e metterle in ordine per poterle scorrere meglio. In questo periodo come forse mai prima — per dirla con Gian Maria Testa — non è il tempo che mi manca. E non è neppure lo spazio. Per anni ho lavorato in ritagli di stanze, depositi o magazzini che temporaneamente mi venivano generosamente messi a disposizione da amici e parenti. Ti dirò, forse è stato più difficile adattarmi ad uno studio grande e bello come quello in cui mi sono trasferito a gennaio, che al piccolo balcone dove da qualche giorno cerco di lavorare un po’.
Eppure è vero, ieri quella cenere non voleva saperne di legarsi e tornare ad avere una forma. Non che fosse la prima volta, anzi. Utilizzando un materiale così incoerente e senza l’aiuto di colle o altri leganti, le cose non vanno quasi mai come si vorrebbe. Ma ieri era diverso dal solito.
Magari dipendeva dalla cenere. Era in un sacco che avevo dimenticato in cantina quando ho fatto il trasloco nello studio nuovo. Una cenere nera, bellissima ma difficile, magra. Nel sacco, nero anche lui, non c’era l’etichetta che di solito metto per ricordarmi in che occasione è stata prodotta quella particolare cenere, ma in mezzo ho trovato pezzi di palme carbonizzate, il che mi ha fatto pensare che fosse quella raccolta un anno fa a Calasetta — ho verificato la data delle foto fatte in quell’occasione ed era proprio il 18 aprile. Questo è il periodo in cui tutti gli anni vado nella casa di campagna della mia famiglia, per potare le palme, fare il trattamento contro il punteruolo rosso e il fuoco di aprile che di solito è il penultimo prima dei divieti estivi di abbruciamento.
Quest’anno temo non potrò fare nessuna di queste cose, ma mi piace sapere che sto lavorando proprio con la cenere prodotta in quell’occasione.
Forse la cosa cui ancora non riesco ad abituarmi in questa condizione sospesa che stiamo vivendo, e per cui probabilmente anche le molecole di quella scultura ieri non trovavano il loro posto, è il nuovo senso che improvvisamente ha assunto la distanza.
Il tuo racconto dello scoglio dei conigli e della lingua di terra che per effetto della marea lo rende meno raggiungibile a piedi, restituisce perfettamente l’idea di come in pochi minuti la percezione della distanza possa cambiare profondamente.
Il mio studio dista circa 10 km da casa mia. Ci si arriva comodamente in meno di 10 minuti. Il fatto che sia così vicino e facile da raggiungere è una delle caratteristiche che mi ha fatto decidere che fosse quello giusto. Eppure adesso, se penso di andarci, quella distanza mi sembra enorme. Sarà per le strade vuote, i posti di blocco, le autocertificazioni? Forse sì, ma credo dipenda soprattutto dal fatto che il mio senso della distanza è come se si fosse contratto, attorcigliato come un muscolo quando fai un movimento sbagliato a freddo.
Anche per te è così? Anche i tuoi ‘muscoli della distanza’ si sono aggrovigliati in una specie di crampo?
Nel tuo ultimo lavoro sui margini di NY, di cui ho avuto la fortuna di vedere gli esiti in occasione dei miei ultimi due viaggi — fatti appena prima del lockdown — a Venezia prima e a Bergamo poi, l’esperienza della distanza mi è sembrata uno degli aspetti centrali; nell’atto più geografico del misurarla ma anche — soprattutto? — in quello più intimo del misurarti con essa.
Questo aspetto mi colpì anche in relazione al tuo giro della Sardegna in bicicletta per quel progetto che aveva un titolo bellissimo, Mi è scesa una nuvola. E ricordo che avevi la febbre (ma quella era una febbre che raccontava di una bella fatica) quando ci siamo incontrati a Gavoi insieme a Lorenzo Giusti e Micaela Deiana, ma fu comunque una bella serata e anche la mostra lo era. Restituiva perfettamente la fatica, i paesaggi, gli incontri contenuti in quelle distanze misurate dai km che avevi percorso ogni giorno per completare il tuo giro nei tempi stabiliti.
A quel tuo lavoro, come a tutto Orizzonte in Italia, sono molto legato. Credo dipenda anche dal fatto che all’incirca nello stesso periodo feci un lavoro che aveva alcuni punti in comune con il tuo. Era una delle collaborazioni nate nell’ambito del progetto Braccia, quella con un altro amico comune, Michael Höpfner. Anche in quell’occasione fu fondamentale il supporto (e l’apporto) di Lorenzo — insieme a quello di altri amici — e anche in quel caso si trattava di percorre il giro di un’isola. La mia isola era quella di Sant’Antioco. La percorsi a piedi durante tre giornate di un agosto rovente, scattando foto con una macchina analogica su una pellicola Ilford in bianco e nero. Per quarant’anni avevo trascorso tutte le estati a Calasetta, sull’isola di Sant’Antioco e tante volte avevo fatto il giro dell’isola in macchina, ma mai l’avevo vista così: camminando e attraverso l’obiettivo di una vecchia Canon. Eppure anche quell’esperienza, per me incredibilmente forte e nuova, non mise in subbuglio il mio senso della distanza com’è successo ora.
Quello spazio minimo di sicurezza tra le persone che si è stabilito essere pari a 1 metro — che a pensarci non sarebbe né tanto né poco — essendo stato fissato in modo così netto, credo abbia modificato in me la percezione fisica dello spazio. È come se adesso nel metro d’aria che ci separa dagli altri venissero compresse tutte le distanze dai luoghi e dalle persone che amiamo o che eravamo soliti percorrere e che in un certo senso definivano la misura del nostro concetto di distanza. Ora che quel metro è diventato così denso, tutte le altre distanze sono esplose via, lontanissime.
Forse è per questo che la cenere ieri non stava in piedi, ero troppo vicino, o troppo lontano.
Ti lascio con una foto di qualche anno fa che mi è tornata alla mente leggendo della tua finestra e dei libri che cadono. Il libro è True story di Sophie Calle, è aperto alla pagina The view of my life. In secondo piano c’è la vista dal cancello della mia casa di Calasetta che, se non è proprio La vista della mia vita, è di sicuro una delle più importanti e una di quelle che oggi mi mancano di più insieme a quella dei fenicotteri che planano sull’acqua dello stagno di Molentargius, di fronte al mio studio dove i nuovi lavori, pronti per la nostra mostra da CLER, aspettano di partire per il viaggio siderale che li porterà a Milano, prima o poi.
Ti abbraccio,
Alessandro
https://www.moussepublishing.com/?product=/alessandro-biggio-braccia/
https://www.youtube.com/watch?v=1KONfCArFKk&list=OLAK5uy_mxu9jpj-rDKsvUQ0TGuIB8aQ7vNehiLxM&index=2
.

Alessandro Biggio – Cagliari. Parco Naturale di Molentargius. I fenicotteri davanti al mio studio, 2020.
.

Alessandro Biggio – Sophie Calle, True Stories, pag. 92, 93, Ed. ACTES SUD. Dal cancello della casa di Calasetta, 2015.
.

Alessandro Biggio – Palme che bruciano. Fuoco del 18 aprile 2019 a Calasetta.
.

Alessandro Biggio e Michael Höpfner – Dal progetto Braccia. Viaggio intorno sull’isola di Sant’Antioco in Sardegna, 2013.
_______________________________________________________________________________________________
Milano • 21 Aprile 2020
Ciao Alessandro,
ti rispondo brevemente, sempre incollato alla scrivania. Fuori il cielo è grigio e a Milano oggi pare essere ripiombato l’autunno. Fa quasi freddo in casa e mentre scrivo mi chiudo dentro le spalle. A proposito dei nostri spazi di lavoro…ieri ho preso la bicicletta e ho fatto una fuga in studio percorrendo — senza certificazione — tutta Corso Buenos Aires e quella porzione di Via Padova che mi divide da Piazzale Loreto. Due mascherine, una sopra l’altra — ancora non ho capito quale è meglio mettere sotto e quale sopra — un paio di occhiali trasparenti da saldatore e guanti bianchi in lattice, tipo da chirurgo.
Volevo dare un po’ d’acqua ai bambù davanti alla cler dello studio, da settimane assetati. Ho salutato a distanza Mamuna, la mia piccola vicina bengalese che nel frattempo ha messo su qualche chilo di troppo a forza di mangiar patatine fritte con il ketchup; ho preso due libri dallo scaffale della mia libreria che non pensavo neanche di avere (non certo due titoli allegri: Parlarsi, La comunicazione perduta di Eugenio Borgna e La morte come tema culturale di Jan Assmann); ho scambiato due parole con la portinaia Elisa — che a un certo punto ho anche un po’ allontanato perché mi stava addosso — preso due bollette da pagare e sono schizzato via di nuovo a cavallo della mia bicicletta. Prima di tornare a casa ho fatto sosta al supermercato di Piazzale Bacone, mi sono fatto misurare con una macchinetta la febbre all’entrata, ho sfregato le mani con un gel che sapeva di pronto soccorso e ho comprato una bottiglia di vino mediocre.
Stamattina mi sono svegliato con il mal di testa.
La fotografia di te che stringi le foglie di palma nella tua casa di Calasetta è un’immagine che amo molto, soprattutto riguardandola ora.
È una cosa che ti avevo già detto ben prima che scattasse la quarantena, quando ci siamo abbracciati a Bergamo in occasione dell’apertura della mia mostra alle Barchesse, dopo tanto tempo che non ci si vedeva.
Per me, ora, quell’immagine di te che abbracci le lunghe palme con i tuoi guantoni bianchi e spessi, appena prima di accendere un fuoco per ricavarne la cenere per le tue sculture, il terreno alle tue spalle che immagino ridiscendere verso una spiaggia a te familiare, ecco quell’immagine mi restituisce pace, tranquillità, una giustezza nell’essere qui, ora, in questo momento a scriverti.
Quindi grazie per avermi rimandato quell’abbraccio, mi arriva con tutta la sua forza e ha un profumo buono che sa di isola e di esercizi quotidiani che fanno bene al corpo e quindi ai pensieri.
Stai bene e non impazzire sul balcone di Cagliari, mi raccomando.
Antonio
.

Alessandro Biggio – Calasetta 18 aprile 2019.
.

Gaia Carboni – Iris Germanico Gigante, Piazza Cesare Augusto 7, Torino. Il fiore è sbocciato all’alba di ieri 22 aprile e io ho potuto contemplarlo appena scesa per fare colazione alle 8:30. Mandata ad Antonio sul cellulare il 23 aprile alle ore 18:43.
CAPITOLO 10: THE END DISSOLVES
Steven N. Handel, botanico, Bridgewater, New Jersey, Stati Uniti
The end has dissolved. The boundaries on the land that we saw and mapped were political and sometimes geographic. But there are no ecological boundaries; we are all connected now in a world of invisible viruses swirling from place to place. I read of the crises in Wuhan (where is Wuhan?), in Spain, and in dear Bergamo. These are destinations that once were far from my quiet life here in the States but now I know their fate is tied in with mine. Our little coronavirus visitor goes from one person to the next as if we were in one neighborhood, which we are.
These are the days of the virus. I call it the anti-life: no travel; no going to work; no eating out or theatre; no seeing friends; no plans for next week or next month; no ability to see and hug the little grandchildren. My daily life is like a dream, all experiences trapped within my body. We try to have phone conversations with our community and keep away from the topic of sickness and death even though those are the only topics.
An old memory welled up in me. When I was growing up, maybe eight years old, in the Rockaways, one of the “ends” of New York City celebrated in Rovaldi’s and Benedetto’s book, I remember a quiet fear we lived through every summer. It was polio, the disease not cured until Dr. Jonas Salk developed a vaccine in 1955. Before then our parents would be tense and made quiet plans. Should we send the children to the countryside where it might be safer? Should we put little necklaces of mothballs around their necks? They had heard a rumor that that might keep away the disease. Some of my little classmates had thin legs and walked awkwardly from the disease. I had not thought about them until now, a new time of fear, a world of viral disease and death.
We all thought we were so clever and modern with our WiFi, our smart phones, our encyclopedic Google searches, and our jet-setting. A little invisible virus, almost not alive, has ended our arrogance and reminded us that we are wrapped in an ecological world we thought we had left behind.
We think and write about a new beginning for our lives when this all ends. All beginnings are difficult, the sages say. This one, when again we can see wide skies and can have dreams of being outside our isolation, cannot be switched on like the electronic gadgets we stare at every day. We are trapped in a box built by an invisible enemy named Corona. It is a world turned upside down. Where is Jonas Salk now that we need him again?
.

.

.

_______________________________________________________________________________________________
Milan • April 23, 2020. Afternoon
Hi Steven,
It’s Thursday and the deadline for the delivery of the contents for Il giro del giorno is due every Friday. It’s becoming a bit of a weekly date. I’m writing to the authors that I would like to invite to take part in this project with their own contribution, and then I often speak to them on the phone to talk about it.
On Thursday evening – i.e. very soon – I’ll send everything off to Cristina in a little blue zipped folder, and from her home in Bergamo, she corrects my texts and then she sends them back to me and I back to her: a round of ping pong going to and from that generally lasts all weekend before coming to a close on Monday evening. On Tuesday we go online with the Museum newsletter. It looks like that’s the way it’s going at the moment. The contents are all digital, the museums trying to keep their balance and we artists along with them. I really care a lot about what I’m doing for the GAMeC over this period.
Like this morning, when I woke up to the voice of Stefano Graziani, a photographer friend who lives in Trieste and whom I hadn’t heard from for a while. It was past midday and I was still in bed. These days I often wake up early in the morning, around dawn. I make myself an Americano, and I drink it in front of the living-room window listening to the birds singing. Then I go back to bed to read, and often I fall asleep and wake up again when it’s practically lunchtime.
Yesterday, Camilla Marinoni, from the education course at the GAMeC, sent me some images that made me laugh. She got the kids on her course to make some horseshoe crabs out of paper. Some of them are really cool, and the ones I’m attaching here are ones that she made herself. Of course, I couldn’t but think back to our display in the library of the GSD at Harvard, and the letter you wrote to the United States National Park Service to get permission to go and gather horseshoe crab shells on a beach in Jamaica Bay, in Queens, which you then sent up to us in Boston in boxes – not before having sanded them down in your garden in Bridgewater, New Jersey.
Please find a few images attached.
Fondly,
Antonio
PS: I really like the way you edged your garden with pieces of wood resting on the ground to create a perimeter. It reminds me of a little vegetable patch that my mom made at our house in Parma. A perfect square of about two meters sown with lettuce and bitter radicchio.
.

.

Camilla Marinoni – Prove di limuli in carta realizzati per il laboratorio GAMeC Art Room “Limuli, all’arrembaggio!”. Bergamo, Aprile 2020.
.

Antonio Rovaldi – La paesaggista Francesca Benedetto si mette davanti al volto la parte anteriore di un grande Horseshoe Crab. Sul tavolo da lavoro del magazzino degli allestitori del dipartimento di Landscape di Harvard sono appoggiati tutti gli Horseshoe Crabs appena arrivati a Boston dentro scatoloni di cartone, spediti dal botanico Steven N. Handel direttamente da Jamaica Bay, Queens. Gli stessi animali sono stati poi posizionati con ordine sulle mensole della libreria del GSD, dove abitualmente vengono esposti per gli studenti bellissimi libri di architettura del paesaggio. Somerville, novembre 2019.
.

Steven Handel con Antonio Rovaldi e Francesca Benedetto – Horseshoe Crabs di Jamaica Bay (NYC), visione globale dell’installazione all’interno della LAB del GSD di Harvard, in occasione della mostra End. Words from the margins, New York City, novembre/dicembre 2019. Fotografia di Justin Knight.
.

Steven Handel con Antonio Rovaldi e Francesca Benedetto – La risposta del United States National Park Service esposta insieme a un esemplare di Horseshoe Crab alla LAB Library del GSD di Harvard in occasione della mostra End. Words from the margins, New York City. Novembre 2019.
CAPITOLO 11: CARO ANTONIO, F.
Francesca Benedetto, paesaggista e illustratrice, Milano – Boston, Italia – Stati Uniti
Milano • 23 Aprile 2020
Nel giro del giorno immagino questa lettera scritta su un foglio circolare in cui l’inizio e la fine sono vicini: “Caro Antonio, F”.
In questi giorni il suono del picchio è qui con me nella mia casa di Milano. Tracce riemergono in ogni metro quadro, come immagini e ricordi. Ma anche come oggetti: nei disegni, nei quaderni, nei libri e nelle fotografie. E non per ultime nelle parole e nei nostri innumerevoli incontri. Potrei disegnarti come una figurina intorno ai tavoli, quando sfogliavamo insieme i libri o mentre il suono del picchio cresceva piano piano sulla parete della sala.
Prendeva il suo spazio tra le altre cose, nel nostro tempo e nei nostri pensieri.
A volte penso che questa pubblicazione abbia avuto un carattere quasi premonitore: una NYC senza persone ma piena di memorie e di presenze altre.
Sono trascorsi pochi mesi dalla prima mostra ad Harvard GSD e ora la città assomiglia sempre di più a quella mappatura. Immagino i margini naturali che hai attraversato farsi spazio nell’ambiente costruito piano piano, ma il suono del picchio è inesorabilmente più forte e diffuso di prima.
Allo stesso tempo la città si sta riempiendo di tracce di dolore che rimarranno come un nuovo strato invisibile, radicato nella memoria.
La Natura avrà un ruolo importante in questo perché solo nella sua celebrazione potremo immaginare un futuro migliore.
Se il mondo fuori lo stiamo leggendo da lontano o guardando dalla nostra finestra, dentro casa è un altro mondo, è “il giro del giorno”.
La nostra casa ci racconta il nostro tempo passato e presente, dei tanti noi che siamo stati. Ospita i nostri ricordi e le tracce delle persone che hanno condiviso parte della nostra vita. Siamo circondati da memorie e geografie lontane che abbiamo vissuto, attraversato, letto nei libri.
Specialmente in quei libri che abbiamo scelto e protetto qui insieme a tutti gli oggetti collezionati con cura, da me e Federico. Il Ganesha dorato di Jaipur o la bambola inclinabile Nevalyashka con cui Sabbia, il cane di famiglia, usa giocare. La Sansevieria che mi ha sempre ricordato la forma della corona della Statua della Libertà. Le nostre case sono caleidoscopi, banche della memoria personale e della nostra emotività.
Se guardando dalla finestra emergono vivide le contraddizioni delle città in cui viviamo e gli errori e orrori commessi nel non vedere lucidamente le tematiche sociali e ambientali; dentro casa si amplificano le emozioni.
Le emozioni sono quelle che maggiormente occupano il mio tempo da ormai quasi due mesi. Con un gruppo di amici abbiamo deciso fin dal primo giorno di lockdown di creare una mappatura emotiva di questo momento. Quest’opera aperta si intitola DOWNTHERE, citando il film Là Bas di Chantal Ackerman.
Abbiamo iniziato a raccogliere immagini dalla finestra, tra cui le tue bellissime pillole sui bambini che giocano in cortile. E a questo archivio di viste abbiamo affiancato un lavoro molto intenso di interviste. Due al giorno. Dall’otto marzo a oggi sono state realizzate 57 interviste, di cui brevi estratti sono pubblicati sul profilo Instagram @downthere2020 a cui abbiamo deciso di dare un valore installativo e che raccoglie dei frammenti di interviste sia in forma di video che di testo, affiancato a delle viste della città vuota che a volte sembrano sguardi con gli occhi semichiusi. Ci sono poi dei testi estratti dalle interviste e dei temi che emergono sotto forma di parole, facendo sì che la mappatura diventi anche un dizionario delle emozioni e della memoria di questo periodo. Nelle interviste stiamo affrontando temi molto diversi con contributi precisi che spesso esplorano vari livelli temporali, in cui presente passato e futuro si rimescolano. L’obiettivo è che questa ricerca rappresenti in sé una fonte: è un lavoro sulla memoria ed è una mappatura di geografie materiali e immateriali.
Il progetto porta con sé a sua volta anche la memoria del suono del picchio, e si fa forte del tuo sguardo, Antonio, dalla tua finestra o delle parole di Steven Handel che ancora una volta, durante l’intervista, illuminandoci ci hanno portato a New York e in New Jersey.
Da casa mia ho imparato ad ascoltare le emozioni degli altri, tutti i giorni e a lungo. Con il suono del picchio in ogni centimetro quadro, lì ho spesso incontrato il mio Downthere, “Caro Antonio, F”.

Francesca Benedetto – Estate 2019. Lavorando alle mappe del libro The Sound of The Woodpecker Bill: New York City, 2019.
.

Francesca Benedetto – Water and Soil. The Bronx, pag. 380/381 del libro The Sound of The Woodpecker Bill: New York City, 2019.
.

Francesca Benedetto – Ganesha Dorato, 2019.
.

Francesca Benedetto – Monitor, 2019.
.

Francesca Bendetto – DOWNTHERE è un progetto a cura di Anghela Alò, Francesca Benedetto, Federico Bernocchi, Stefano Govi, Simone Russo e Carolina Stamerra Grassi.
Instagram: @downthere2020; sito: www.downthere.it
CAPITOLO 12: HELLO TORINO
Francesca Berardi, giornalista e scrittrice, Torino, Italia
Torino • 3 Maggio 2020
Ciao emiliano,
sono appena tornata a casa dal mio giro del mondo intorno alla stazione ferroviaria. Negli ultimi due mesi percorrere quel tondo è diventato per me un rito salvifico, sia per lo spirito sia per la circolazione sanguigna delle gambe. Ho sempre pensato di voler vivere vicino ad una stazione di treni, ma non immaginavo che uno dei vantaggi fosse che in tempo di pandemia puoi girarci intorno. In cima al cavalcavia mi fermo a guardare giù, come faccio a New York ogni volta che passo sul Pulaski Bridge. Là c’è un canale super inquinato con placide barchette ormeggiate e Manhattan sullo sfondo, qui invece c’è un fiume di binari che si intrecciano e una schiera di treni addormentati al cospetto di una gigante mezza luna di vetro e ferro. Tutto è fermo, ma il luogo è così evocativo da risultare rumoroso. Ogni volta è come se il mio orecchio anticipasse dei suoni che poi non si manifestano.
Dopo il cavalcavia proseguo sulla via che costeggia la stazione. È una strada divisa in due parti. Da un lato c’è una fila di palazzi d’epoca, hotel di lusso, pasticcerie storiche e un cinema porno ormai chiuso. In mezzo c’è un vialone per il passaggio delle auto e del tram, ora quasi deserto ma solitamente trafficato. Sul lato opposto una fila di alberi. Chiuso tra quella tenda di rami e foglie e la stazione c’è un largo passaggio pedonale. Si tratta di un tratto non molto battuto neanche in tempi di cosiddetta normalità perché – oltre al dopolavoro ferroviario – parrebbe non esserci niente. In realtà accadono molte cose e la città sembra all’improvviso disegnata per essere abitata.
C’è un bagno pubblico di cemento, di quelli mezzi aperti, con l’acqua che scorre di continuo. Sull’esterno c’è scritto “Hello Torino” con lo spray. Credo sia utilizzato soprattutto da uomini di una certa età. Le gambe che vedo sbucare sono all’antica, pantaloni di tela scura che cadono larghi e un po’ pesanti, e scarpe di pelle, allacciate o mocassini. Ma più di questo non so dato che tiro dritto con discrezione.
Poco più avanti ci sono due panchine. È difficile che ci sia qualcuno seduto, anche perché non offrono molto, a parte assi di legno scrostato e una vista su una lunga parete di mattoni. Chi le usa, infatti, ci si sdraia e chiude gli occhi. Immagino si tratti di persone che non hanno trovato posto nel dormitorio che c’è qualche metro più avanti, dietro quella parete di mattoni.
Una sera, verso l’ora del tramonto, la porta del dormitorio era aperta. Davanti c’era un uomo, avrà avuto forse la mia età, che fumava una sigaretta. Era vestito con un largo camice bianco di quei tessuti di carta usa e getta e con la mascherina tirata giù sotto il mento ma ancora appesa alle orecchie… hai presente? Non ricordo neppure come gli ho attaccato bottone, ma abbiamo chiacchierato a distanza e a lungo. Mi ha raccontato che lavora lì da pochi mesi mentre prima era impiegato in un centro di sostegno per persone dipendenti da eroina. Quando ha lasciato l’Albania per venire in Italia, 20 anni fa, non pensava che sarebbe finito ad assistere persone più in difficoltà di quanto fosse lui stesso. Alla fine della chiacchierata ho tirato anche io giù la mascherina per salutarlo.
Mentre proseguivo verso il parcheggio dei taxi ho realizzato che la ragione per cui sono così attratta dalle stazioni è che sono costruite per chi ha mete precise, e finiscono per essere il luogo prediletto di chi non sa dove andare. O di cose senza un posto, ma non ancora condannate a sparire. Per esempio una bici rosa con le ruote a terra, a cui rivolgo uno sguardo ogni giorno.
I taxi sono fermi e distanziati, e i taxisti in piedi, spesso appoggiati alla portiera aperta. Si parlano tra loro e il gioco che faccio sempre è di camminare lenta ai margini del parcheggio per sentire se parlano di coronavirus. Per ora non c’è stata una singola eccezione. Ma come non capirli?
A quel punto o attraverso la stazione entrando nell’atrio o passo davanti all’ingresso principale. Questa mattina sono entrata per sentire un po’ di fresco e ho visto che hanno disegnato frecce e percorsi a terra per regolare il passaggio delle persone. Domani è il giorno della riapertura e forse qualcuno andrà in stazione a cercare treni che non partono, per andare a trovare – senza abbracciare – parenti di sesto grado.
[…]
Oggi ci è mancato poco che fossi d’accordo con quello che dicevano i taxisti!
A questo punto dovrei raccontarti il tratto di strada che mi resta per arrivare casa, una decina di minuti circa, e che costeggia l’altro lato della stazione. Ma come accade sovente mentre cammino in quel tratto, mi sono distratta.
Quindi ti mando un abbraccio,
Francesca
.

.

.

Francesca Berardi – Il giro della stazione, 3 maggio 2020.
CAPITOLO 13: IN VIAGGIO CON OLGA (1996)
Paola De Pietri, artista, Reggio Emilia, Italia
In viaggio con Olga (1996)
25 anni fa si guardavano ancora le foto ricordo e di viaggio degli amici, una volta rientrati a casa.
Delle fotografie mi colpiva spesso quello che accadeva sullo sfondo, alle spalle del soggetto principale, che spesso era un ritratto. Questi gesti, piccole storie e accadimenti, mi sembravano in certa misura più autentici. Le immagini di In viaggio con Olga sono dei forti ingrandimenti di dettagli, scelti in modo arbitrario; di fatto questa operazione è diventata un viaggio dentro il viaggio di altri, dove la fotografia porta con sé tante delle decisioni, arbitrarietà e ambiguità che sono parte di ogni immagine.
.







.
CAPITOLO 14: LUPO NERO
Andrea Camuffo, fotografo, Milano, Italia
Umbria • Aprile 2020
Alla fine non siamo ancora riusciti a farci quella chiacchiera di cui si parlava, ormai, settimane fa. Ne approfitto allora per raccontarti un sogno (o forse sarebbe meglio dire due sogni combinati) davvero bizzarro che ho fatto stanotte. Ho sognato un lupo nero, italico, che mi passava davanti mentre io lo osservavo da dietro un rada fila d’alberi. Il lupo passa senza incertezze, non curante di me. Lo osservo, tenendo la mia mano sul coltello che porto nella tasca del giubbotto, pronto a difendermi con vane speranze di cavarmela se il lupo decidesse di divertirsi con me. Dipenderà dal fatto che da settimane mi introduco furtivamente in un campeggio abbandonato, qui vicino, pieno di casette in muratura attaccate ad altrettante roulottes stanziali. È l’unico luogo d’evasione, fisico e mentale, che sono riuscito a rimediare quassù. Vagare in mezzo a roulottes abbandonate, chiuse e congelate, mi ha restituito quel brivido puro e irresistibile che si provava da ragazzi. Mi è anche sembrato, sin dalla prima volta, una fotocopia metaforica di quello che stiamo vivendo. Terrorizzante e inebriante. Il vagare ripetitivo tra questi oblò chiusi con le tendine a fiorellini, lascia sempre aperta la porta all’idea che un nemico sconosciuto possa sbucare fuori da un momento all’altro per sferrare il suo agguato. Ma l’unica vera paura che ho quando vado lì è, appunto, di incontrare dei lupi.
La seconda parte del sogno è degna di Wes Anderson. Una volta scampato il pericolo del lupo, mi trovo improvvisamente in una lucente Milano e, dopo una lunga assenza, arrivo da Cler. Lo spazio è completamente diverso, più articolato, tra porte scorrevoli e piccole stanze. Tu sei appoggiato a una parete; sei tu, ma anche no. Indossi dei pantaloni larghi con le pences, una camicia hawaiana a maniche corte arrotolate e hai dei baffi importanti e curati. C’è un gran via vai di scatoloni e persone. Mi sorridi e mi dici che Cler è diventata una casa editrice. Mi presenti la tua nuova grafica, che è un mix perfetto tra Francesca (la tua amica montatrice) e Laura Morante. Siete entrambi più giovani di oggi e vistosamente belli.
Be’, che dire, mi sembra evidente che stare qui non mi faccia benissimo.
Un abbraccio dai boschi.
A.

.

.

.

.

.

.

_______________________________________________________________________________________________
Milano • 22 Aprile 2020. Mattina molto presto
Ciao Andrea,
grazie per la condivisione del tuo sogno, che ho letto ieri sera prima di cena. È strano ma questa mattina mi sono svegliato con la sensazione di avere visto anch’io dei lupi, da qualche parte in città. Immagino che la tua lettera muschiosa si sia incuneata da qualche parte del mio cervello nel dormiveglia e poi me la sono trascinata sotto il piumone durante la notte.
Sono giorni che mi sveglio presto. I primi due minuti di palpebre pesanti di solito li consumo davanti alla finestra del soggiorno, che poi è quella con la vista più ampia di tutta la casa. In questi giorni ci sono delle albe pulite e gli uccelli sembrano più numerosi, ma forse è solo l’effetto di una suggestione da lockdown, un po’ come il filmato che mi hai mandato in cui si vede la tua Venezia silenziata, con una luce tersa e i riflessi dell’acqua sotto i ponti e i gabbiani davanti al piazzale della stazione deserta. Due giorni fa sono passato in studio con la bicicletta a passo veloce, zigzagando la polizia piazzata tra Corso Buenos Aires e Piazzale Loreto (finalmente i marciapiedi sono diventati le piste ciclabili che mancano a Milano).
Sono arrivato che la portinaia stava dando acqua ai bambù e Mamuna si è affacciata subito dalla finestra per salutarmi. «Hey, tu, vieni qui!», con quel suo tono imperativo che mi è sempre piaciuto. Sono tre anni che condividiamo merendine pomeridiane e non è mai andata oltre a quel «Vieni qui!». E pensare che aveva appena cominciato ad andare a scuola… Non la vedevo da oltre due mesi. È ingrassata e gliel’ho detto. Si è messa a ridere, ma non credo abbia capito. Ha continuato a mangiare le sue patatine con i polpastrelli unti e grassi. Ho tirato su la Cler e le fotografie dell’ultima mostra Lo spazio tra le cose erano nella stessa posizione di due mesi fa. Immobili. Il vuoto delle immagini di Claudio Gobbi degli interni dell’Eur, se prima mi appariva nella sua austera eleganza, ora mi è sembrato sinistro e lontano. Le acque della laguna notturna di Marina Ballo Charmet sembravano la versione onirica del film veneziano che mi hai girato. Le tue fotografie erano leggermente inclinate, come se avessero accusato il colpo di questa tua fuga dalla città. Non che immaginarti solitario mentre vaghi tra roulottes sfasciate in un bosco umbro, umido e buio, mi restituisca un’immagine di te serena – come altrimenti in questo periodo – ma almeno so che sei a contatto con la natura e ogni tanto ti concedi delle esplorazioni solitarie. Ti vedo che sali sull’auto, non prima di esserti rollato una sigaretta stretto nella tua giacca di pelle nera, la macchina fotografica sul cruscotto davanti, senza custodia. Una sorta di versione umbra dell’agente dell’FBI Dale Cooper. Mi dà tranquillità sapere che hai sempre con te, nascosto nella tasca interna, un coltello Opinel. Sia mai che quel lupo nero guizzi all’improvviso dal tetto incassato di una roulottes, affamato di esseri umani un po’ ubriachi e scazzati.
Del resto pare che i lupi stiano tornando sui nostri monti. Sarà vero?
Stai all’occhio,
Antonio
.

.

P.S.: la mia amica montatrice è Federica, non Francesca.
CAPITOLO 15: HO TRALASCIATO FORME DI CORTESIA
Stefano Graziani, artista, Trieste, Italia
Trasmetto dal mio studio, comodo e relativamente remoto. Come preparazione a questo viaggio ti mando le fotografie del primo lavoro fatto qui, L’isola, sono passati diversi anni. Mentre pensavo a che fotografie fosse possibile fare avevo letto molto e poi dimenticato. La sequenza è aggiornata a oggi, ti chiedo di lasciare l’impaginazione automatica di Photoshop. Ho aggiunto pagine da manuale, da un manuale. Manuale di antropologia, superato ma perfettamente in grado di generare visioni. Anche in questo caso lascerei l’impaginazione che propongo. Mentre pensavo come poterti essere utile a questo tuo progetto, ho riguardato attentamente i libri disponibili, ho pensato alle cose che ho visto negli ultimi giorni, film e cartoni animati, e oggi ho ascoltato Bananarama, Lucio Dalla, David Bowie, Ozzy e Wolfgang Tillmans (soprattutto Make it up as you go along). Ho tralasciato forme di cortesia, sentiamoci al telefono così mi dici che ne pensi.
A presto, grazie.
Stefano


Stefano Graziani – L’isola, con una nota dell’autore e alcune citazioni tratte da Scritti, di Roberto Bazlen, Adelphi, Milano 1984, pag. 32, Galleria Mazzoli, Modena 2009.

CAPITOLO 16: SI VEDONO LE VIE DEL CIELO
Alessandro Sciarroni, coreografo e artista, e Antonio Rovaldi, Porto d’Ascoli – Milano, Italia
Milano • 25 aprile 2020, mattina presto
Caro Alessandro,
Eccomi qui, a Milano, nel giorno della Liberazione.
Ti scrivo dal soggiorno e dalle finestre entra una luce calda che impiega tutta la mattina per fare il suo giro. Quando mi sveglio presto, dopo il primo caffè, spalanco le finestre e scatto una fotografia al ficus indiano. Le mie biciclette sono ferme affiancate lungo una parete, due di loro hanno le borse da viaggio ancora montate, ma le loro gomme sono a terra. Non sai la voglia che avrei di fare una lunga scalata in bicicletta, di quelle in cui ti ammazzi di fatica a salire, ma quando poi hai raggiunto la cima girando intorno alla montagna, ti senti improvvisamente rinato. E poi tutta l’ebbrezza della discesa, il fiato trattenuto, i freni che si allentano dopo le curve a gomito, gli occhi che lacrimano…
La mancanza di movimento, il non poter camminare, per me è davvero la cosa più faticosa di queste settimane. Così ho riscoperto il salto alla corda (ne ho ordinate tre online, tutte diverse), e i primi giorni ho saltato come un matto. Ora sono di nuovo fermo perché mi fanno male le ginocchia; i vicini del piano di sotto saranno contenti che non batto più sulle loro teste.
Ammetto che ho esagerato.
Ieri sera dopo cena, mentre mi rollavo l’unica sigaretta del giorno sul balcone, ripensavo a noi a Parma quando eravamo ragazzini, a quando ci si incontrava la notte in giro per la città, tu con Lisa e Rocco, io sempre con Chicco, Filippo e Alice. Sono ricordi che sanno di Emilia, di infinite sigarette fumate fino a tardi (e non solo sigarette), di freddo umido, di cappotti e maglioni con il collo alto che poi puzzavano di fumo per giorni…
Pensavo al teatro Lenz a Parma, tu che all’epoca ci lavoravi, e ad Adriano, un allievo di mia madre – quando lei insegnava lettere al Conservatorio in Piazzale Boito – anche lui attore della compagnia. Era davvero altissimo Adriano, con una voce profonda e un sorriso contagioso. Suonava il violino. Sono immagini lontane, ma che fanno parte del mio diario di ricordi emiliani.
Poi per me è stata Milano, l’Accademia, lunghi capitoli a New York City, ora di nuovo Milano a pochi passi da Corso Buenos Aires, dove in questi giorni si può attraversare anche col rosso a occhi bendati. Anatomia dell’irrequietezza, ma anche elogio del movimento e della vista.
Tu, Alessandro, ora dove vivi quando torni dalle tue lunghe tournée? Ti immagino in una casa appena fuori Bologna, in collina, o forse mi sbaglio e stai nelle Marche?
Comunque ti vedo in un posto bello, con uno spazio grande per fare le prove dei tuoi spettacoli, i tuoi danzatori intorno, in un luogo dove gira l’aria e sono sicuro che ora ti stai prendendo cura della tua casa, che stai facendo ordine; sentivo che lo dicevi a Radio GAMeC qualche giorno fa a Leonardo Merlini – «prendersi cura della propria casa» – ti ho poi riascoltato dal sito del museo perché a capire come funzionano le dirette Instagram ci ho messo un po’. Infatti, quando è toccato il mio turno ho avuto degli inceppi nella rete e sono entrato in ritardo con Lorenzo Giusti che mi spronava al telefono.
La prima settimana di maggio avremmo dovuto incontrarci a Bergamo in occasione della tua ultima danza – Save The Last Dance for Me – dentro la Barchessa dell’Accademia Carrara, dove ora c’è la mostra che racconta i margini di New York City attraversati a piedi da me tra il 2016 e il 2018. Mi dispiace che tu non abbia potuto vedere la mostra, e ancor di più che le mie immagini non abbiano potuto fare da sfondo alla tua ultima fatica. Sarebbe stato un momento felice, al centro di una New York dal sapore un po’ emiliano!
Se mi dai il tuo indirizzo di casa ti mando per posta il libro del picchio, così ti accompagno in una lunga camminata dentro una New York meno conosciuta. Le immagini del mio libro raccontano una città come potrebbe essere in queste settimane: silenziata, con la natura che si riprende, di diritto, i suoi spazi.
Un giorno, dentro la sala del museo, mentre stavo cominciando a capire come allestire la mostra, è arrivato un ragazzo che lavorava all’organizzazione del Festival Orlando di Bergamo perché doveva prendere le misure dello spazio e capire se avresti potuto realizzare la tua polka chinata in una stanza stretta e lunga; scattava fotografie con il telefono, che poi ti avrebbe dovuto mandare. Ricordo che era un po’ perplesso per i plinti di legno che stavo posizionando nello spazio per ospitare due sculture di bronzo e gli dissi di stare tranquillo e che ovviamente avrei fatto sparire tutto il giorno del tuo arrivo a Bergamo. Alla fine la tua danza – che avrei letto anche come un saluto alla nostra Emilia – non si farà e quei plinti rimarranno immobili e solitari dentro le sale dell’Accademia Carrara dove, da fine febbraio, non è più entrato nessuno.
Meno male che ogni tanto a raccontare una mostra ci sono i libri. Le mostre prima o poi finiscono, i libri invece restano ed è per questo che, sempre di più negli ultimi anni, ho trovato nelle loro pagine un luogo ideale per distendere il mio sguardo. Credo sia una questione di durata.
Come la danza e il teatro che, senza corpi e senza pubblico, si allontanano.
Ora, mentre ti sto scrivendo, ho trovato un’immagine in rete che non conoscevo e che ti giro qui sotto: una radiografia alle sculture delle ballerine di Edgar Degas*. Il materiale che modella la carne dei corpi in movimento sfuma lasciando in evidenza l’ossatura di ferro su cui si appoggia. Sono sculture che si muovono nello spazio mantenendo un punto fisso, saldato alla base. Quell’immagine racchiude bene l’idea di movimento e immobilità al tempo stesso. La loro carne si dissolve nel nero e si fa evanescente, lo scheletro in ferro resta fermo nel ricordo di una presenza.
C’è una ballerina anche tra le numerose fotografie esposte nella Sala della Barchessa. È stata la prima fotografia che scattai quando cominciai a camminare i margini del Queens ed è quella che ho scelto per la locandina della mostra di Bergamo, perché racchiude bene il senso del quel progetto che si è sviluppato intorno ai margini di una città. Un progetto in cui il movimento circolare – camminare intorno ai luoghi, ripetutamente, per un lungo periodo – era alla base della sua costruzione.
Quella ballerina con le gambe ferite, dentro il suo movimento bloccato nella mia fotografia, raccoglieva le altre immagini raccolte intorno alla città, giorno dopo giorno, per la durata di due anni. Ora che i musei sono chiusi mi piace pensare che la sera, quando alla Barchessa si abbassa la luce dei lucernari, lei possa staccarsi dalla sua base, saltare giù dal piedistallo di cemento sul quale io l’avevo appoggiata, e ricominciare a ballare in tondo, un po’ come la tua polka chinata. La mia è una danza traballante e solitaria però, a tratti anche triste, per via di quelle ferite alle gambe, ma come potrebbe essere altrimenti, visto i giorni che le città stanno vivendo?
Ti va di raccontarmi com’è nata l’idea di quell’antica danza emiliana che si stringeva in un abbraccio di ginocchia maschili e che avresti dovuto presentare anche il 9 di maggio a Bergamo? Guardando un video su Vimeo** – dove tra il pubblico, seduta, vedo anche Lisa – i due danzatori, Gianmaria Borzillo e Giovanfrancesco Giannini, sono bravissimi. A un certo punto nel video si vede che uno dei due ha la camicia strappata. È bello vedere due uomini che danzano stringendosi con forza tra braccia e ginocchia, spingersi e sorreggersi al contempo, in quel movimento continuo e circolare.
È questo movimento ripetitivo e circolare che amo molto nel tuo lavoro, insieme a una certa idea di fatica – che non so davvero spiegare a parole – che sento appartenere molto anche alla mia pratica, quando cammino per lunghe distanze e cerco di trovare un compromesso, per nulla facile, tra le fotografie e la stanchezza. A volte non so a chi dare la precedenza e questa cosa mi mette a disagio, ma è anche una spinta che mi permette di andare avanti e completare un disegno che ho in testa. Mi piace pensare che le immagini – le opere in generale – nascano da una fatica fisica e che alla fine, quando il disegno che abbiamo in testa appare all’improvviso, come per magia, questo sforzo si dissolva e resti solo il piacere puro e inspiegabile di una visione.
Mi fermo qui perché sento che potrei continuare a lungo questa lettera e non voglio, ora, stancare te!
Lascio la corda dei salti appesa alla porta, riguardo la tua ‘danza salvata’ che mi arriva come un abbraccio e ti mando un saluto da Milano. Spero di rincontrarti un giorno, anche con Lisa e Rocco, magari proprio a Parma, camminando e fumando una sigaretta, di notte.
Un abbraccio,
Antonio
*La scultura di Degas: i Raggi X svelano la tecnica esecutiva
https://restaurars.altervista.org/la-scultura-di-degas-i-raggi-x-svelano-la-tecnica-esecutiva/
**Alessandro Sciarroni, Save The Last Dance for Me, 2019
https://vimeo.com/368651600
.

Antonio Rovaldi – April 15, 2017 / 41st Rd and 10th St, Queens (dal libro: The Sound of The Woodpecker Bill, New York City, Humboldt Books).
.

Immagine che mostra una radiografia alle sculture di Edgar Degas.
.

Antonio Rovaldi – Corda per saltare veloci sul pavimento di casa, un giorno della prima settimana di maggio 2020.
.

Helen Levitt – In The Street, NYC, 1939.
_______________________________________________________________________________________________
Porto d’Ascoli • 6 maggio 2020
Carissimo,
a undici giorni di distanza ho appena riletto la tua lettera. Spero che il tuo ginocchio si sia sfiammato e che da lunedì scorso tu sia riuscito finalmente a fare delle belle passeggiate e magari anche un giro in bicicletta. Qui oggi piove e devo ammettere che non mi dispiace affatto. Vivo in questa casa da più di due mesi e le giornate di pioggia mi sembrano più organiche rispetto a questo semi-confinamento. La mia casa è in un paese che si chiama Porto d’Ascoli. Si vede il mare. Il mio appartamento confina a nord col piccolo centro urbano, il lungomare e gli stabilimenti balneari e a sud con una riserva naturale che si spinge per qualche chilometro fino alla foce del fiume Tronto. Erano anni che non mi capitava di passare così tanto tempo qui. Da qualche giorno posso di nuovo andare nella riserva naturale. Lunedì mi è venuta una vescica ad un piede. Non ero più abituato ad indossare scarpe e a camminare.
Intorno alla fine di febbraio quando mi hanno detto che ci saremmo dovuti fermare, che avremmo dovuto cancellare le date degli spettacoli già fissati e che non avremmo potuto fare le prove della nuova produzione, ho pensato che il mio lavoro esiste ed è legittimato esclusivamente dalla presenza. Così ho preferito mettere in ordine la mia casa piuttosto che dedicarmi ad un qualsiasi processo creativo. Ho preso tempo per riprendere il controllo sui miei spazi, sugli oggetti e ho spolverato i libri uno ad uno.
Oggi quando ho ricevuto il pacco postale con le tue pubblicazioni, ho scoperto che sei passato di qua durante il tuo viaggio in bicicletta nel quale hai percorso tutto il perimetro della costa italiana. Ma ho visto che dopo Polverigi ti sei fermato direttamente a Giulianova, quindi hai saltato Porto d’Ascoli. Non so perché, ho provato un piccolo dispiacere quando ho visto la mappa del tuo viaggio nel (bellissimo) libro che mi hai inviato: Orizzonte in Italia. Se fossi stato qui mi sarebbe piaciuto portarti a fotografare l’orizzonte da un piccolo paese distante pochi chilometri da casa mia: Grottammare Alta.
Alcuni anni fa mi è capitato di presentare il mio lavoro lì. Lo spazio che ospitava la performance si chiama Teatro dell’Arancio, un edificio del Settecento i cui arredi lignei sono andati distrutti durante l’epidemia di spagnola, tra il 1916 e il 1918. L’interno del teatro presentava un palcoscenico, una platea e tre ordini di palchi lignei decorati. Oggi non rimane più alcun resto degli arredi originari. A causa dell’elevato numero di persone decedute per l’epidemia, il legname degli arredi è stato usato per costruire casse da morto. Sebbene il luogo abbia mantenuto lo stesso nome e le mura esterne siano originali, entrando è forte la sensazione di trovarsi all’interno di “un falso” e che il Teatro dell’Arancio sia andato perduto per sempre. Al contrario, la memoria dell’azione radicale che l’ha depauperato è incredibilmente presente.
Ho molto sorriso quando nella tua lettera mi hai ricordato del periodo in cui vivevo a Parma. È strano, ho vissuto in quella città per nove anni eppure mi sembra che non ci sia quasi nulla che mi leghi a quel posto. Invidiavo in un certo senso la vita che facevate tu e i tuoi amici. Tutte le sere io ero in teatro a fare le prove, finivo di lavorare sempre intorno alla mezzanotte e non c’era molto da fare a quell’ora. Nei fine settimana ogni tanto fuggivo a Milano o a Bologna. Una volta sono stato a casa tua, ma tu non c’eri, credo fossi a New York e avevi affittato una stanza del tuo appartamento. Me ne sono ricordato oggi quando è arrivato il tuo pacco con i libri e ho letto l’indirizzo: via Petrella. Ricordo che una volta rimasi a dormire a casa di tuo fratello, che se non sbaglio abita al primo piano del tuo stesso condominio. Avevo portato con me un libro di Derek Jarman, A vostro rischio e pericolo, che sto risfogliando in questi giorni assieme ad un altro suo libro: Chroma, dal quale ho rubato il titolo per un mio spettacolo. Probabilmente non è un caso che io abbia riaperto in questi giorni quei libri, scritti da Jarman nel momento in cui stava diventando cieco, a causa di un’altra terribile epidemia.
Si può conoscere il mondo intero
Senza muoversi di casa
Senza guardare dalla finestra
Si vedono le vie del cielo
Più si va
Meno si sa.
Mi è dispiaciuto molto essere stato costretto a cancellare lo spettacolo che si sarebbe dovuto svolgere all’interno della tua mostra a Bergamo. Avrei voluto tanto vedere il tuo lavoro e mostrarti il mio, il lavoro sulla polka chinata di cui parli.
Nel 2018 sono venuto a conoscenza del fatto che esistevano solo cinque persone in tutto il mondo ad essere in grado di ballare questa danza bolognese dei primi del ‘900. Si trattava di una danza nata spontaneamente nelle balere che si diffuse assumendo delle connotazioni quasi agonistiche fino ad essere ballata sotti i portici della città. Lo scorso anno abbiamo chiesto ai detentori di questa tradizione di insegnarci a danzarla e assieme ad alcuni festival italiani abbiamo deciso di attivare alcuni workshop di trasmissione per mantenerla in vita. Il progetto si chiama Save the last dance for me. Sono circa trecento le persone che hanno partecipato ai workshop e almeno venti di loro sono riusciti a raggiungere un buon livello tecnico nell’esecuzione. Quando abbiamo presentato l’iniziativa alla Pinacoteca di Bologna ho avuto l’occasione di parlare del progetto con un’antropologa, che mi ha spiegato che la danza non si estingue nella stessa maniera nella quale si estinguono le specie. La danza è un oggetto immateriale: nella sua natura è già contemplata la transitorietà e l’intermittenza. La polka chinata, in effetti, dopo essere sparita per decenni è tornata alla vita ben prima che io la recuperassi. Fu grazie ad un maestro di balli di sala, il quale la riportò in vita in tempi recenti grazie al rinvenimento di alcuni video degli anni sessanta.
Mi ha consolato molto durante il confinamento pensare che la danza possa tornare dopo essere sparita per intere generazioni e che si estingua solo se cade nell’oblio. Nelle mie coreografie la danza è sempre l’archetipo di una pratica, un mistero antichissimo che ci fa muovere all’unisono, il segreto di un segreto come diceva la fotografa americana Diane Arbus parlando del significato delle sue immagini. Per questo motivo in questo periodo mi trovo un po’ in difficoltà con le proposte di lavoro che mi sono arrivate. Non me la sento di fare le prove dei lavori via Skype, preferisco aspettare il momento in cui ci verrà concesso di incontrarci di nuovo.
Ti ringrazio per questo scambio di lettere Antonio, e per i libri. Sono davvero bellissimi.
È possibile che la data dello spettacolo di Bergamo verrà posticipata a quest’estate.
Sarei davvero felice di poterti incontrare di nuovo per quell’occasione.
Nel frattempo ti mando un caro abbraccio,
come fossi qui e ora,
Alessandro
.

.

Alessandro Sciarroni – Save the last dance for me, 2019, performance, ph. Claudia Borgia, Claudia Bruschini.
.

Alessandro Sciarroni – 27 / 23, fotografie.
CAPITOLO 17: IL TÈ VERDE DEL DOI KHAM
Pier Luigi Tazzi, curatore e critico, e Antonio Rovaldi, Capalle (FI) – Milano, Italia
Milano • venerdì 8 maggio 2020
Ciao Pier Luigi,
ti ho appena lasciato un messaggio su facebook in risposta al tuo ultimo post sul triangolo d’oro thailandese, tra coltivazioni di tè e papaveri da oppio. Mi parlavi del Doi Kham, del re Bhumipol, e della sua azienda/fondazione per «stimolare e proteggere i contadini del triangolo d’oro alla coltivazione del tè e distoglierli dalla coltivazione del papavero d’oppio». Parole tue e mi piacerebbe saperne di più.
Il re Bhumipol e il suo Doi Kham ora non possono che catapultarmi con la memoria a quella torrida estate del 2000 quando andai a insegnare, poco più che ragazzetto, alla Silpakorn University di Bangkok. Hidetoshi Nagasawa che, come ricorderai bene, era il mio maestro all’accademia a Milano, ricevette l’invito dall’Università per tenere un corso di un mese nella sezione di scultura della Silpakorn ma, non potendo andare per motivi di lavoro, mi invitò a prendere il suo posto (mi sarei diplomato l’estate successiva con lo stesso Nagasawa). Andai a Bangkok accompagnato da una ragazza francese, Anne, che seguiva anche lei il corso di scultura e con la quale, all’epoca, avevo una relazione. Io e Anne spesso realizzavamo lavori a quattro mani, e così decidemmo di trascorrere più di due mesi a Bangkok. Dormivano al distaccamento della Silpakorn University a sessanta km a nord – o a sud, non ricordo – della città, in un campus affollatissimo da studenti giovanissimi in flip flop, e ogni mattina prendevamo un autobus bollente per andare alla sede centrale in città a tenere le nostre pseudo lezioni al corso di scultura parlando lingue improbabili – non prima di aver fatto colazione a base di un riso piccantissimo che ci faceva grondare di sudore. Del resto, non c’era che quello. Cerco di ricordare il nome del professore-artista del corso di arte ma non mi torna in mente. Era un uomo con occhi belli e i capelli lunghi tenuti stretti da una coda. La prima sera che arrivammo ci portò a cena in un posto di fianco all’università. Era sporco ma decisamente molto ‘local’ e intrigante…
Ricordo che a metà della cena – piccantissima anche lei – andai a fare la pipì in una specie di bagno aperto dietro le cucine, il pisciatoio era pieno di limoni tagliati sul fondo e c’era una nuvola di moscerini. Da qualche parte dovrei avere una fotografia di quel bagno, ora la cerco. Il ricordo di quell’estate terribilmente umida a Bangkok è uno dei più vivi nella mia memoria di viaggi. È qualcosa che sento dentro con un peso specifico.
Poi la Thailandia, gli anni successivi, è stata quella vissuta attraverso i tuoi numerosi racconti, dopo la morte di Roberto. Gli anni precedenti ai tuoi futuri thailandesi venivo a Capalle prendendo l’autobus della Sita dalla stazione di Firenze e trascorrevo intere giornate primaverili dentro e fuori il vostro studio per assistere Roberto alla realizzazione delle mie ceramiche. Ricordo un giorno in particolare in cui tu bisticciasti con Roberto ed io sgattaiolai fuori dallo studio e mi spinsi in una passeggiata lungo l’argine del Bisenzio. Poi tornai, le vostre voci si erano silenziate ed io ripresi a modellare la terra in mezzo a nuvole di fumo, polveri di gesso e aromi di tè verde. Le pause pranzo si consumavano in un bar del paese o nella rosticceria di un’altra località della quale non ricordo il nome e la sera Roberto mi riaccompagnava sulla sua ape rossa traballante alla fermata della Sita. A volte ero un po’ intontito perché il pomeriggio capitava che io dessi un tiro di canna da quelle potentissime rollate da Roberto, mentre preparava il tè verde sul fornelletto da campeggio di fianco al lavandino. Capitava le prime volte, poi non ho più fumato. Tu eri sempre seduto al tuo tavolo polveroso sommerso di libri, la tastiera del tuo computer con qualche tasto schizzato via – è ancora vivo il pappagallo verde che forse era il responsabile di tali sparizioni? Ogni tanto passavano in visita Lapo o quel falegname amico di Roberto – che si chiamava Ludo se non ricordo male – che andava da lui per farsi cuocere le sue piccole e brutte ceramiche.
Nel mio archivio fotografico ho una cartella nominata “CAPALLE” e fra le tante immagini ci sei tu con Vittoria Ciolini. Indossavi un paio di anfibi neri che mi piacevano moltissimo e dei pantaloni militari e, ovviamente, stavi fumando una Marlboro.
Poi ho anche una cartella che si chiama “TAZZI” e dentro alcune immagini dell’inaugurazione della mostra Orizzonte in Italia, alla galleria Monitor di Roma, anno 2013. In quelle immagini vesti una giacca nera da uomo su una camicia rossa, la tua versione Dylan Dog che io amo particolarmente. Ci siamo noi che parliamo, io avevo ai piedi dei sandali acquistati in Grecia l’estate precedente ed ero decisamente in tema con la mostra!
Se riapro il libro Orizzonte in Italia alla pagina 246 vedo l’immagine dell’happening di Eustachy Kossakowski con le sdraio sulla bàttima e un uomo su una scaletta dentro l’acqua con le braccia alzate davanti all’orizzonte – Tadeus Kantor – Panorama Happening am Meer, Osieki, 1967. Questa era l’unica immagine che avevi scelto per il mio libro ad accompagnamento del tuo testo Soste (e) Marine. Tra le fotografie di Orizzonte in Italia scattate intorno al perimetro della Sardegna, ora ne ritrovo una che mi ricorda l’orizzonte di Kossakowki, solo che al posto della scaletta c’è un bunker. Te la mostro qui…
Non ti nascondo che avrei molta voglia di ascoltare le tue storie, di sapere come va con la casa di Capalle, ma se ti becco in momento un po’ ‘no’ poi mi dici che non ne hai voglia e mi dai anche del nostalgico. Quindi mi fermo qui e spero tu possa almeno dirmi qualcosa della Thailandia, che sta molto al di là dell’argine del Bisenzio, davanti al tuo studio.
Cosa farai ora con la Thailandia, appunto…
Adesso ti saluto e vado a fare una passeggiatina e a vedere se trovo il Doi Kham…
Antonio
.

Immagini tratte dall’archivio di Antonio Rovaldi. Roberto Cerbai modella la terra per una scultura in ceramica che rappresenta una grossa razza bianca mentre Pier Luigi Tazzi parla con Vittoria Ciolini, Capalle, primavera 2004.
.

L’argine del fiume Bisenzio visto dallo studio di Pier Luigi Tazzi e Roberto Cerbai a Capalle, una mattina di inizio primavera del 2004.
.

Dall’archivio fotografico di Antonio Rovaldi Orizzonte in Italia, Antonio e Pier Luigi Tazzi parlano all’interno della galleria Monitor a Roma, un pomeriggio di settembre del 2013.
.

Antonio Rovaldi – Orizzonte in Italia, Humboldt Books, pag. 246 / Eustachi Kossakowski, Tadeus Kantor – Panorama-Happening am Meer, Osieki, 1967.

Antonio Rovaldi – Orizzonte in Italia, Humboldt Books, pag. 241 / Pier Luigi Tazzi, Soste (e) Marine, 2015.
.

_______________________________________________________________________________________________
Capalle • 10 maggio 2020
Caro Antonio,
Grazie per la tua lettera che evoca due luoghi che mi sono particolarmente vicini: la Thailandia e lo studio di R a Capalle, dove fra l’altro ho passato ormai gli ultimi due mesi, devo dire con sempre maggior piacere, e ora sono decisamente preoccupato a dover affrontare di nuovo il mondo di fuori, con cui non mi sono mai trovato granché bene e che non mi sembra ora cambiato in meglio, anzi…
Del Doi Kham non ho molto altro da aggiungere a quanto ti ho scritto su Fb. Mi viene ora in mente che una volta che ero andato con Mit (Jai Inn) a trovare l’abate del tempio nella caverna sulla montagna, a cui Mit era molto devoto e con cui la prima volta che lo avevo incontrato, ancora attraverso Mit e Kamin (Lertchaiprasert), avevo avuto quella che potrei definire un’esperienza mistica di grande intensità, forse l’unica della mia vita, ci trovammo ad attraversare un villaggio, forse di Karen, difficile a dirsi, ché le uniche creature che vi circolavano erano dei bambini piccolissimi completamente nudi e dei maiali neri ancora più piccoli. Il villaggio era immerso in estese coltivazioni di broccoli, che, mi fu spiegato, avevano sostituito quelle del papavero da oppio a seguito del progetto del Doi Kham creato una decina d’anni prima da Rama IX (Bhumibol Adulyadej).
Del tuo soggiorno in Thailandia, che precedette di almeno tre anni la mia prima visita là, tengo particolarmente a una tua opera fotografica che esposi nella mostra Italiani in vacanza a Casa Masaccio nel 2008: un tetto di una casa immersa in un palmeto visti dall’alto in uno scorcio improbabile.
Anch’io non ricordo il nome dell’insegnante di cui mi parli, che pur riconosco e che mi è capitato di incontrare qualche volta: è un bravo artista, scultura e ambienti, e soprattutto un grande cultore dell’opera di Galileo Chini, di cui conosce tutto, e non solo del suo periodo bangkokkino, ma anche delle sue opere italiane di cui io mi sono accorto, attraverso di lui, ignorare in gran parte. È in contatto anche con i discendenti di Chini con cui continua ad intrattenere cordiali rapporti. Il ristorante dove ti portò è una sorta di sancta sanctorum per i docenti della Silpakorn: è estremamente esclusivo ed è un grande onore esservi portati ed esservi accolti. Io vi sono stato sempre accompagnato da qualcuno della Silpakorn, da Surasi (Kusolwong) spesso, quando ancora ci frequentavamo, ma anche da Inson Wangsam o da altri.
Penso che i due mesi che hai passato a Bangkok non fossero comunque la stagione calda che va da metà febbraio fino a maggio inoltrato, ma la stagione delle piogge che è molto più mite e che corrisponde grosso modo all’estate italiana. Oggi a NongPrue, dove abbiamo casa, erano 34° e pioveva, ma pochi giorni fa erano arrivati a 42°.
Oggi poi, 10 maggio, sarebbe stato il compleanno di R e l’avrebbe celebrato alla grande invitando tanti amici. Io occupo parte del suo studio come allora, forse mi sono un poco allargato, ci sono più pile di libri, carte, dvd, piccoli feticci. Quando sono a Capalle, e non solo in questo periodo di chiusura, passo qui la maggior parte della mia giornata. Il fornelletto da campeggio di cui mi dici è ancora qui e nello stesso posto: su quello preparo i miei parchi pasti, e il tè la mattina per colazione, e non è sempre verde. Ad un amico olandese che mi chiedeva oggi come vivessi la mia clausura dicevo che era come stare in una grotta su una piccola isola felice, come Calipso a Ogigia, e che il peggio, ripeto, è il fuori.
La casa: la devo obbligatoriamente in parte restaurare e devo reperire i fondi necessari, subito. E anche questo è un assillo.
La Thailandia è al di là dell’argine del Bisenzio ora in piena fioritura maggese, ma c’è: come la felicità sul mio personale orizzonte degli eventi. E ogni giorno telematicamente si rinnovano le promesse.
Vado ad annaffiare gli agrumi.
Pier Luigi
.

Antonio Rovaldi – Tetto, C-print su alluminio, 90×120 cm, 2000. Fotografia esposta alla mostra Italiani in Vacanza, a cura di Pier Luigi Tazzi, Casa Masaccio, San Giovanni Valdarno (FI), 2008.
.

Antonio Rovaldi – Mano che stringe una sigaretta, immagini estrapolate da un video girato a Bangokok una sera di agosto 2000 dentro un ristorante di fianco alla Silpakorn University.
.

Antonio Rovaldi – Il padiglione d’oro (pensando al titolo del romanzo di Yukio Mishima), immagini estrapolate da un video, Bangkok, agosto 2000.
.

.Antonio Rovaldi – Alba vista da una terrazza di un albergo nella periferia di Bangkok, immagini estrapolate da un video, agosto 2000.
_______________________________________________________________________________________________
Milano • domenica 10 maggio 2020
Ciao Pier Luigi,
grazie per la tua veloce risposta.
Come sai, non mi è difficile immaginarti dentro lo studio, con i tuoi libri e le scatole di tè. Non mi hai poi detto se il pappagallo c’è ancora, ma forse era volato via anni fa.
Incredibile che hai subito localizzato il ristorante di fianco alla Silpakorn University e, anche se non lo hai descritto, so che parliamo dello stesso luogo.
Cercando ancora nel mio archivio fotografico ho trovato altre due cartelle titolate: “MY TRIP / THAILANDIA STILL e THAILANDIA CARTOLINE”.
Nella prima ci sono due immagini estrapolate da un video che mostrano le dita di una mano con una sigaretta che avevo ripreso una sera durante una cena insieme a studenti della Silpakron, in quel ristorante che tu conosci bene.
Il nome di quell’artista thailandese che teneva il corso di arte cominciava forse la con T. Qualcosa tipo Thamarik?
Era un artista bravo. Ricordo una sua opera: una teiera su un fornelletto – tipo quello di Roberto – e del vapore che saliva su una tela e il colore che si scioglieva e colava al centro, il tutto ripreso da una videocamera, un po’ un Bill Viola prima maniera.
La fotografia che avevo stampato per la tua mostra a Casa Masaccio, che ritrae un tetto visto dall’ultimo piano di un albergo, è stata scattata una mattina dalla stessa altezza dell’ultima immagine che allego qui sotto. Ogni tanto io e Anne, per essere più vicino alla Silpakorn – e non dovere tornare ogni volta al campus su corriere bollenti e appiccicose – dormivamo in albergo o in Guest House nella periferia di Bangkok. Comunque quell’estate è stata davvero la più torrida della mia vita (se ci penso ricomincio a sudare). A fine agosto pioveva talmente tanto e forte che quando abbiamo raggiunto il triangolo d’oro in treno, il paesaggio era un unico grande lago e gli abitanti dei villaggi raggiungevano i passeggeri affacciati ai finestrini lungo la ferrovia su canoe distribuendo dei pacchetti avvolti da foglie di palma. Non ricordo cosa contenessero quei fagotti, ma mi piace pensare a qualcosa di buono.
Questa mattina sono uscito alle 5 in bicicletta, era ancora buio e mi facevo strada con le lucine led – il primo giro dopo sessanta giorni di totale immobilità – e ho raggiunto le risaie intorno a Milano. Hanno cominciato ad annacquarle e in alcuni punti sembrava di stare a Chiang Mai. Non ricordo se in Thailandia ci sono i coccodrilli, ma suppongo di sì, da qualche parte. Nelle campagne intorno a Milano i coccodrilli non ci sono, ma è facile avvistare grandi aironi cenerini con le loro gambe sottili che escono dall’acqua, prima di spiccare il volo appena ti sentono arrivare.
Sarei curioso di sapere di più della casa di Capalle, ma non è qui il luogo
giusto.
Spero di rivederti non troppo avanti…
Antonio
.

Cartoline acquistate durante il viaggio verso il Triangolo d’Oro in Thailandia, estate del 2000.
_______________________________________________________________________________________________
Forse trovato:
http://www.rama9art.org/artisan/artdb/artists/home.php?p=profiles&name=Amarit%20Chusuwan
Pier Luigi
.

Name: Amarit Chusuwan
Born: April 22, 1955 Nakorn Si Thamarat
Education:
1982 – B.F.A. Painting, Silpakorn University
1987 – M.F.A. Painting, Silpakorn University
.

Galileo Andrea Maria Chini. Foto di Mario Nunes Vais circa 1904. Fonte https://en.wikipedia.org/wiki/
_______________________________________________________________________________________________
Capalle (FI) • 24 maggio, 23:30 (1 ora fa)
Caro Antonio,
Bello rivedere il tuo Tetto. Mi ricordavo erroneamente un palmeto: le palme ci sono ma prevalgono i banani oltre ad altre piante che non riesco ad identificare. Si tratta alla fine di un tipico salvatico che si trova spesso intorno o a fianco di case più o meno isolate in tutto il Sud-Est asiatico.
Il cibo che ti veniva offerto dalle barche non era in foglie di palma, ma di pandano, un arbusto tropicale che può raggiungere a volte dimensioni arboree: il contenuto dei fagottini può variare dal pollo al riso aromatizzato, al taro e ad altro ancora.
L’airone cinerino compare anche nel Bisenzio, ma sono più frequenti e più leggiadre le garzette, che somigliano molto ai trampolieri bianchi delle risaie thailandesi.
Jeab (nick di Gridthiya Gaweewong) mi ha aiutato a rintracciare il nome di Amarit Chusuwan e mi ha anche detto che, dai tumulti del 2010, Amarit era diventato un leader delle Yellow Shirts e era uso arringare gli studenti di Silpakorn contro le Red Shirts. Le sue prese di posizione anti-democratiche lo hanno portato recentemente a promuovere e partecipare a progetti artistici obsoleti e, da convinto monarchico, a sostenere l’attuale re Rama X. Che è molto diverso non solo da suo padre Bhumibol Adulyadej, Rama IX, il più longevo della dinastia Chakri, ma anche di tutti gli altri regnanti della terra fino alla sua morte nel 2016, molto amato dai suoi sudditi e che aveva ridato una centralità politica alla monarchia dopo un intervallo di 14 anni dopo la “Rivoluzione del 1932”, che aveva trasformato la monarchia assoluta in monarchia costituzionale e il Regno del Siam in Regno della Thailandia, ma molto diverso anche dal suo bisnonno Chulalongkorn, il re che aveva voluto Galileo Chini a Bangkok. Il regno di Chulalongkorn, 1868 – 1910, corrisponde al contemporaneo Periodo Meiji in Giappone, 1868 -1912: un’apertura molto ampia alla cultura e alla civiltà occidentale, che interrompe in entrambi i casi la continuità di una tradizione fino a quel momento ininterrotta, una continuità di oltre due millenni per il Giappone e di circa 500 anni per il Siam. Chulalongkorn è figlio di re Mongkut e della regina in carica nell’anno della sua nascita, ché di mogli il padre ne ebbe 35 e di figli 82, mentre lui fra mogli e concubime ne avrebbe avute 96 che a loro volta gli avrebbero dato 77 figli fra maschi e femmine. Per volontà del padre, Chulalongkorn a partire da 9 anni ebbe come educatrice l’anglo-indiana Anna Leonowens che gli trasmise i valori della cultura occidentale primo fra tutti il senso di giustizia, così come dal padre, che prima dell’ascesa al trono per molti anni era stato monaco, aveva appreso i precetti della moralità e spiritualità buddhisti. La storia di Anna Leonowens alla corte del Siam divenne prima un romanzo, quindi dal 1951 uno fra più acclamati musical di Broadway The King and I di Rodgers e Hammerstein, e infine nel 1956 un film dallo stesso titolo e con lo stesso protagonista maschile, il russo Yul Brynner, mentre la Leonowens fu interpretata da una magnifica Deborah Kerr, che vinse per questa sua interpretazione il Golden Globe. Brynner, che non era molto somigliante a re Mongkut, tanto da diventare una sorta di sex symbol a partire proprio da questo film, che fra l’altro vinse cinque Oscar, replicò sul palcoscenico il personaggio del re del Siam 4625 volte, fino al suo ultimo anno di vita.
Il 18 agosto del 1868 Mongkut era in un piccolo villaggio a sud di Hua Hin, con altri membri della sua numerosa famiglia fra cui Chulalongkorn, per assistere ad una eclissi totale di sole, che lui stesso, appassionato di astronomia, aveva previsto. Sia lui che Chulalongkorn contrassero la malaria che provocò la morte del re qualche settimana dopo, mentre il figlio sopravvisse e gli succedette. Chulalongkorn aveva solo 15 anni e fino al raggiungimento della maggior età ebbe come reggente il potente ministro Chuang Bunnag.
I Bunnag, una famiglia che vantava origini persiane, erano stati fin dal regno di Ayutthaya influenti e potenti ministri dei vari re, e solo nel corso del regno di Chulalongkorn iniziò il loro declino. Ho una discreta familiarità con un loro diretto discendente Eric Booth, attualmente Assistant Managing Director della Jim Thompson. Eric è figlio di William Booth, l’assistente anche lui americano di Jim Thompson che prese le redini dell’azienda dopo la clamorosa scomparsa del suo creatore nel 1967, e di Patsri Bunnag, fashion editor e ultimo rampollo di una certa notorietà dei grandi Bunnag. Patsri Bunnag, insieme al figlio Eric e al marito, l’antiquario francese Jean Michel Beurdeley, ha fondato il più importante museo privato di arte contemporanea della Thailandia, il MAIIAM di Chiang Mai, e è deceduta prima della sua apertura, che ha avuto luogo nel 2016 con una grande personale di Apichatpong (Weerasethakul) curata da Jeab.
Chulalongkorn continua l’opera di modernizzazione del paese iniziata da suo padre e con grande abilità diplomatica riesce a sottrarre il Siam all’espansionismo colonialista britannico e francese. Gli attuali confini della Thailandia risalgono al suo regno. Compie viaggi in Europa nel 1897 e nel 1907: in Italia gli piace molto Torino dove sosta per ben due volte, e, dalla fine del secolo, architetti e ingegneri soprattutto piemontesi trasformano Bangkok. Nel viaggio del 1907 visita la Biennale di Venezia e si appassiona alla pittura di Galileo Chini. Dà quindi mandato a Carlo Allegri, il suo ingegnere capo, di contattare Chini per invitarlo a decorare l’Ananta Samakhom Throne Hall a Bangkok, che, su progetto dell’Allegri stesso, è in via di costruzione. Nel 1910 a Firenze viene firmato il contratto e Chini si imbarca per Bangkok nell’aprile del 1911. Chulalongkorn intanto è morto nell’ottobre dell’anno precedente e gli è succeduto il figlio Vajiravudh: Chini arriva a Bangkok alla vigilia della sua incoronazione. Accolto a corte, resta attratto dalla città e di questa attrazione può render testimonianza un suo magnifico dipinto, Festa dell’ultimo dell’anno a Bangkok, oggi alla la Galleria d’arte moderna di Palazzo Pitti a Firenze. Nonostante la fascinazione del posto Chini tuttavia rientra in Italia nel 1913. Un suo predecessore, quell’ingegner Allegri che lo aveva formalmente ingaggiato, vi resterà per più di 25 anni, e cambierà l’immagine della città. Un suo successore, il parimenti fiorentino Corrado Feroci, ve ne rimane 38, fino a morirvi, ed è considerato ancora “il padre dell’arte moderna thailandese”. Si vede che, nonostante tutto, Chini non ha sofferto “il mal di Thailandia”. Per quanto mi riguarda, io ci sono, a tratti più o meno lunghi, dal dicembre del 2006.
Buona notte,
Pier Luigi
.

Jeab e plt, Molam Concert, NongPrue, 21 dicembre 2015.
.

Jeab, Galleria d’arte moderna di Palazzo Pitti, Firenze 14 novembre 2015.
.

Arin Rungjang, Jeab, Chutima Dumsuwan, plt e Eric Booth, Siam Center, Bangkok 2014.
.

Soichiro Shimizu, plt e Ray, opening MAIIAM, Chiang Mai, luglio 2016.
CAPITOLO 18: LO STAGNO DEL JFK
Una lettera come un ritorno a New York
Leonardo Merlini, giornalista, Milano, Italia

Leonardo Merlini – Jfk Airport, New York City, 2013.
Era una giornata grigia, ventosa, dell’autunno del 2013. Dalla fermata della metro di Smith-9th Streets si percepiva tutta la storia metallica della città. Era come stare dentro una poesia di Raymond Carver, che non a caso aveva intitolato la sua raccolta di versi Orientarsi con le stelle, perché in certi luoghi che avevano la loro stessa scomparsa già impressa dentro – e non parlo solo delle cittadine del Midwest care allo scrittore, ma anche dei grandi snodi autostradali, di certi negozi h 24, della Gowanus sopraelevata qui davanti – non si poteva alla fine fare altro che guardare in su e cercare un’altra direzione. Anche io guardavo in su, mentre aspettavo il convoglio della Linea F, guardavo attraverso la grata di ferro e a un certo punto, piccola e assolutamente anonima, mi sono accorto che quella sagoma laggiù in fondo era la Statua della Libertà. La grata era il mio confine, la manifestazione tangibile di tutti i sogni che avevo fatto per anni, sogni di arrivare qui. La grata era il limite invalicabile, ma anche la prova che ero arrivato davvero a New York.
Questo invece è un pomeriggio di caldo oltre la media, a inizio maggio del 2020. Sono in coda, con mascherina e guanti, per entrare in un supermercato Coop nella sperduta provincia lombarda. Ingressi contingentati per l’emergenza Covid e un ragazzo gentile che regola il traffico davanti all’unico accesso. A ben guardare queste attese in fila sono momenti di libertà, forse gli unici (insieme a quelli di scrittura a tarda notte) veramente miei in una quarantena abbastanza grottesca di padre che deve lavorare da casa, per cui mi porto cose da leggere mentre aspetto. Ci ho portato John Berger e Don DeLillo, ci ho portato Ben Lerner e una raccolta di saggi su Roberto Bolaño. Oggi invece ho con me The Sound of the Woodpecker Bill di Antonio Rovaldi. Ho bisogno di quelle fotografie che mi sembrano gli scarti della narrazione ufficiale sulla città, che mi rimandano al rimosso dall’immaginario collettivo, al confine che ancora fa sì che la parola “New York” significhi qualcosa di altro, e di mio. Ho bisogno di ricordare, e le immagini del libro lo fanno, di quando, durante un temporale pazzesco nella primavera del 2019, ho preso un autobus per l’aeroporto di Newark, quella Newark che per me era tutto Philip Roth e quindi una specie di luogo dell’anima, e ho attraversato una serie di paesaggi contigui eppure in costante contraddizione tra loro, fino a quando, davanti al terminal, lo skyline di Lower Manhattan, quel punto nodale del mio immaginario più profondo, non si è rivelato per quello che era davvero: una sagoma scura contro le nuvole, lontanissima, in fondo inaccessibile, quasi ostile. “Una sorta di eternità”, per dirla con l’artista.
Caro Antonio, adesso posso fare finta che questa sia davvero una lettera, un tentativo di darti una mia presenza nella tua storia, con la faccia un po’ strafottente del clandestino intellettuale (ma sotto la strafottenza c’è sempre, sempre, una paura). Nei giorni scorsi avevamo parlato delle fotografie di Walker Evans per quel capolavoro pazzesco di James Agee che è Sia Lode ora a uomini di fama. Oggi l’ho ripreso in mano, l’ho sfogliato seduto in balcone e mi sono ricordato di quando per un compleanno, credo nel 1994, ho ricevuto dai miei quattro cugini – i ragazzi con cui sono cresciuto in una sorta di simbiosi biologica – una grossa busta marrone che conteneva quel libro, insieme alla Merriam Webster Encyclopedia of Literature. Credo sia stato il regalo più importante che ho mai ricevuto (insieme a un altro pacco di libri da mia mamma, per una Epifania nei primissimi anni Ottanta), perché in un certo modo quei due volumi sono state le basi di ciò che sono diventato, (qualunque cosa io sia diventato).
E, per intrecciare ancora di più le trame, quando, dopo il mio primo viaggio a New York, ho provato a raccontare ciò che mi era successo, l’ho fatto trovando una voce che, finalmente, era diventata la mia voce e non ho potuto che intitolare quel lungo e a tratti delirante para-diario con un omaggio al titolo di Agee e Evans: era il mio modo di dire grazie per quella narrazione che era “un libro soltanto per necessità”, mentre “più seriamente era un’impresa di esistenza umana in atto”. Un principio che, senza saperlo, è diventato l’ispirazione del mio modo di (non) essere un giornalista, nonché, almeno per come l’ho vissuto io, anche uno dei possibili sensi del tuo peregrinare lungo i margini della Città. Quantomeno uno di quelli che arrivano fino a me.
(Poi, come dire, Sia Lode ora a uomini di fama è anche il libro che Alexander Portnoy regala alla Scimmia quando vuole indirizzarla verso letture serie ne Il lamento di Pornoy di Philip Roth… Non so se riesco a rendere l’idea).
L’altra immagine di cui avevo bisogno, in questi giorni nei quali sento che il mondo fuori sta scomparendo pian piano, era quella delle acque intorno a New York: tante, diverse, con storie che vanno dalle anitre di Salinger alle baleniere di Melville. Io, ti confesso, nelle tue fotografie acquatiche cercavo Venezia, la grande Lacuna del mio presente, il buco al centro della stessa affermazione di me in quanto viaggiatore e cronista del mondo culturale. Sto perdendo Venezia, mi sento dire di continuo, e per oppormi a questa auto-affermazione in quei bacini americani diseguali sono andato a ricercarla, in piedi sui sampietrini davanti a un supermercato in un giorno qualunque durante la peste del XXI secolo. Non so se l’ho trovata, ma in qualche modo sento di averne rallentato la perdita.
(Ancora il 2013. Sono sul treno che mi porta al JFK, sto ripartendo. Quando il convoglio, ormai da tempo nell’area dell’aeroporto, fa una curva e si inclina, prossimo all’arrivo, mi accorgo che sotto i binari c’è un grande stagno, con tanto di canneto e vegetazione selvatica. Mentre un grande aereo appena decollato lo sorvola, ricordo chiaramente di essermi chiesto che cosa ci facesse lì uno stagno, perché in quel punto dell’aeroporto più famoso del mondo ci dovesse essere quell’angolo di palude. Oggi so che era un’anticipazione della mia domanda di acque newyorkesi, era lì solo perché io lo vedessi e, sette anni dopo, lo capissi. Anche grazie alle tue fotografie, Antonio).
(Forse era anche l’Area X di Jeff Vandermeer, ma questo sarebbe ancora più difficile da spiegare e questa specie di lettera è già troppo lunga e sconclusionata).
.

.

.

Leonardo Merlini – Brooklyn, 2013.
_______________________________________________________________________________________________
Milano • lunedì mattina 11 maggio 2020
Buongiorno Leonardo,
grazie per il ricordo del tuo primo viaggio newyorkese, l’ho letto mentre stava salendo il caffè. Ora non posso risponderti come vorrei perché Cristina Rota, come sempre ogni lunedì mattina, da qualche settimana attende che io le mandi i contenuti del martedì per Il giro del giorno e oggi sono un po’ in ritardo.
Mi limito a riaprire velocemente il libro strepitoso che raccoglie il reportage di James Agee e Walker Evans che tu citi qui sopra, Sia lode ora a uomini di fama. Lo sfoglio e l’occhio si ferma sulle pagine che ho fotografato ora e che allego qui sotto, soprattutto su quel paio di scarpe di cuoio. Alla pagina 81, in alto, ci sono due segni a matita – molto probabilmente risalgono al 2003, quando mi regalai il libro – e leggo:
“Ma non sono soltanto i loro corpi ma le loro posture che io so, e il loro peso sul letto o sul pavimento, di modo che anch’io mi sdraio dentro ciascuno di loro esausto in un letto, e divento non l’io che sono con sua forma e peso, ma quello di ciascuno, e per intero, affondati nel sonno come pietre; di modo che quasi so i sogni che non ricorderanno, e anima e corpo di ciascuno di quei sette, e di loro tutti insieme in questa stanza nel sonno, come se loro fossero musica da ascolto, con ciascuna voce in rapporto con tutte le altre, e tutte udibili, in singolarità, come un solo organismo e una musica che non può essere comunicata; e così stesi in tal silenzio riposano.”
L’immagine del bambino steso su un cuscino di lino spesso con un piede fasciato e tutto il corpo coperto da uno straccio bianco – tranne un pugno chiuso e i due polpacci che restano scoperti – parla di quel sonno torrido pomeridiano, di mosche e moscerini in una campagna del sud, di un sogno non ricordato eppure così presente, ancora oggi, questa mattina, in quella fotografia di Walker Evans.
Ti abbraccio,
Antonio
.

Leonardo Merlini parla a Radio GAMeC e compare sullo schermo del mio telefono un giorno di aprile 2020.
.

.

.

Fotografie scattate questa mattina alle ore 9:00, in risposta alla lettera di Leonardo Merlini. Il libro aperto sul tavolo è Sia Lode ora a uomini di fama, James Agee & Walker Evans, Il Saggiatore, 2002.
CAPITOLO 19: DO YOU WANT A PEACH?
Michael Höpfner, artista, e Antonio Rovaldi, Vienna – Milano, Austria – Italia
Vienna • May 10, 2020
Dear Antonio,
Last week on a walk in the mountains near Vienna with my tent and food for three days; silence, solitude; around me nature with its ticks, viruses, creatures and psychological tricks and other kind of human fear.
An excerpt from my notebook, early morning:
“Watching nature makes me smile… the chaos of nature… always and forever incomprehensible for humankind… nature makes me doubt and fall into despair… strange enough it has something deeply reassuring.
With my steps I can put it in order… not nature, order in myself. It forces me to be the observer, in silence, a contemplator, unpretentious. The time of the steps is soothing. I realize again that I have to stand on this earth, a state of being that can’t be changed. Each of the steps makes me understand the being in place and time.
While walking: walking is not just moving on, it is about to pause and think, to constitute a place, a place to eat or a place that I clean with my walking boots, stamp down the grass, kick the little rocks aside to pitch the tent for the night.
All these years it is a continuous decision-making how to embed myself into this chaos. Where do I want to walk? Roaming. Wandering. Rambling. Tramping.
At least nature is the chaos that helps me to understand that I am not the centre.” Notes, evening:
“Nature is not recreation. While walking I am deeply occupied with nature – all my senses. It is emotional – it for sure always was for humankind.
Again thinking about fear: a little tick can bite and I end up in a wheelchair the rest of my life. This kind of chaos is around us – we just forgot about it.
Camp under a huge free standing fir tree; strong wind moves the branches of the fir; loud whispering; the fir speaks to me; the streamlet next to my tent speaks to me; I feel the cold air of the snowfield; how can I understand?”
Let’s meet soon in your studio!
My best from Vienna
Michael
.

Michael Höpfner – nomads_walkers_001.jpg, on the way to Tagtse, day 9, cup of tea, 15.7.2004.
.

Michael Höpfner – nomads_walkers_002.jpg, along with Targo Ri, day 20, cup of tea, 10.9.2007.
.

Michael Höpfner – nomads_walkers_004.jpg, along with Tangra Tso, day 31, cup of tsampa, 21.9.2007.
.

Michael Höpfner – nomads_walkers_005.jpg, early morning on the way to Pilio, some pistachios, day 7, 1.6.2019.
_______________________________________________________________________________________________
Milan • May 11, 2020, 1.30pm
“While walking: walking is not just moving on, it is about to pause and think, to constitute a place, a place to eat or a place that I clean with my walking boots, stamp down the grass, kick the little rocks aside to pitch the tent for the night.”
Ciao Michael,
I agree with you. Walking is not just moving your body on, step after step, but it’s also stopping, thinking over the distance covered, taking a rest with your shoes off, and then picking up the rhythm once more. The spaces of a pause lie within a walk, like punctuation. I walk, I stop, I start again, I sleep, I start all over…
Like that July 20, 2018—the only time I saw you, apart from two evenings ago on Radio GAMeC!—when after your journey around Mont Blanc you stopped off at my studio in Via Padova, Milan, to eat a couple of peaches and take your climbing boots off, before getting on a coach that was about to take you back to Vienna overnight.
Looking back now at the photographs I shot of your boots on that July afternoon, I notice a great likeness with those that I bought for myself last November, along with a pair of ice crampons (which I will never use!). I hope to be able to put them on soon and leave the shape of my foot inside them.
You’ve made me feel like eating a peach now!
We’ll be in touch soon, I’m sure.
Antonio
.

Michael Höpfner mangia una pesca nel mio studio a Milano il 20 luglio del 2018, prima di ripartire con una corriera notturna per Vienna. Giorno caldo a Milano.
.

Gli scarponi di Michael prendono aria nel cortile di via Padova 27 a Milano.
.

Gli scarponi da alta montagna che mi sono regalato a Novembre e che ancora non ho usato.
CAPITOLO 20: A CHILD CRYING, N.J. 1967
Diletta Colombo, libraia di SpazioB**K, e Antonio Rovaldi, Milano, Italia
«Il viaggio da Napoli a Capri mi ha fatto sentire il petto più aperto. Davvero non mi ero accorta che fosse chiuso.»
Con questo stato d’animo Ali Smith raggiunge nel 2011 il suo museo del cuore: la Villa San Michele di Capri, creata a fine ottocento da Axel Munthe, «forse uno dei pochi musei al mondo ancora capaci di farti restare umano in mezzo ai loro pezzi» (Pezzi da museo. Ventidue collezioni straordinarie nel racconto di grandi scrittori, Sellerio 2019). «Munthe porta il cielo dentro casa, ti fa voltare in direzione di un orizzonte, suggerisce che “vero” e “falso” non colgano nel segno. Aveva capito (grazie soprattutto alla sua vista difettosa) che in un luogo così splendido, colorato e luminoso, l’enigma più che mai implica l’oscurità. Non voleva la “musealità” ma il gesto leggero e birichino, il vitale cambiamento di forma, l’atto dell’immaginazione. Ecco cos’è questo posto costruito in cima a una scogliera.»
.
Veduta della Villa San Michele a Capri trovata nel web sabato mattina, 16 maggio 2020.
.
Nel 1990, quando aveva diciannove anni, Hisham Matar perde il padre, incarcerato e fatto sparire dal regime di Gheddafi. Poco tempo dopo lo scrittore, appassionato di pittura senese medioevale, inizia ad andare tutti i giorni alla National Gallery di Londra e a contemplare un quadro diverso ogni settimana: “Ne traggo grande beneficio. Un quadro cambia mentre lo guardi e cambia spesso in modi inaspettati. Ho scoperto che un dipinto richiede tempo. Ora impiego parecchi mesi o più spesso un anno prima di riuscire a guardare oltre. E nel frattempo quel quadro diventa un luogo mentale e fisico della mia vita” (Punto di approdo, Einaudi 2020). Venticinque anni dopo, insieme alla compagna Diana, raggiunge Siena per immergersi completamente nelle immagini e nel paesaggio delle opere che lo hanno tenuto ancorato alla vita. «Solo dentro un libro o davanti a un dipinto si può avere realmente accesso alla prospettiva di un altro. […] Mi ero chiesto, e me lo chiedevo nella Sala dei Nove a Siena, se sarei mai riuscito a scrivere qualcosa se non avessi amato. […] L’Allegoria di Lorenzetti, il Davide di Caravaggio, e a dire il vero tutta la storia dell’arte possono essere letti così: come un gesto di speranza e anche di desiderio, l’esplicitazione del segreto anelito dello spirito umano a congiungersi all’amato, di vedere il mondo coi suoi occhi, di colmare la tragica distanza tra ciò che si vorrebbe dire e il discorso, in modo da poter essere, finalmente visti davvero, per essere riconosciuti, […] per continuare a cambiare mantenendoci riconoscibili per chi ci riconosce meglio.»
.

Ambrogio Lorenzetti – Allegoria ed effetti del Buono e del Cattivo Governo, Palazzo Pubblico di Siena, 1338-1339.
.
Marocco ha quattordici anni e vive a Napoli, sua madre se n’è andata il giorno in cui sarebbero dovuti partire per il mare dopo l’ennesimo litigio col marito, che le ha impedito di lasciare andare a letto il figlio emozionato, vestito con pinne e boccaglio; gioca a calcio ma lo appassiona di più leggere riviste che parlano di cose paranormali e Dylan Dog sopra i libri di scuola; spaccia con il suo migliore amico Lunno per comprarsi un motorino da dividere a metà, è il protagonista di Giovanissimi di Alessio Forgione (NN, 2019); tutto dentro lo attraversa ma fuori non esce nulla.
«Soprattutto, volevo dire che ogni persona è l’ulteriore possibilità di qualcun altro. Non lo feci.»
E poi, s’innamora. Un vulcano, lava che scende, fluida, compatta, incandescente, travolgente. Quell’amore che fa uscire parole più forti della paura per tenere vicino chi desideriamo, quello dell’attrazione irresistibile del corpo, quello che ti fa ottenere con complicità il permesso di andare in vacanza in campeggio per raggiungere la tua ragazza anche se sei stato bocciato, che ti fa lasciare indietro per la prima volta il rione e tuo padre, che ti aiuta a non pensare che le cose ci vuole tanto per farle arrivare e poi finiscono in un attimo. Ma l’amore vulcanico dell’adolescenza si scontra a tutta velocità col sangue, reale, della morte, la fine anche di ciò che educhiamo e seppelliamo crescendo. E come si fa a lasciare andare una persona e tenere tutto insieme, la lava dell’essere giovanissimi e la diga del diventare adulti.
.

L’occhio di Napoli, immagini trovate nel web sabato mattina del 16 maggio 2020.
.
Ecco, Antonio, mi hai chiesto di parlarti della mia storia d’amore tra l’Italia e il Messico attraverso i libri. Non sapevo cosa raccontarti. Non mi ero accorta che il mio petto fosse chiuso. Ora è un po’ più aperto, seguendo tracce d’arte e letteratura nel mandala disegnato sul pavimento della camera da letto che ha cullato le mie letture.
Bambina mia, ti tengo stretta tutta la notte se ti svegli in pianto, il lettino può aspettare. Il tempo è un soffio.
.

Fotografia scattata al libro di Diane Arbus, An Aperture Monograph, A Child Crying N.J., 1967, Aperture Foundation Books, New York 1967.
_______________________________________________________________________________________________
Milano • 16 maggio 2020, sabato
Diletta,
Passo in libreria in bicicletta la settimana prossima a ritirare Amitav Ghosh (che fra l’altro ho sentito a Radio3 due giorni fa che parlava de La grande cecità. Ti ho pensato perché quel libro l’avevo preso da B**K ed è citato nell’introduzione di The Sound of The Woodpecker Bill: New York City).
Antonio
CAPITOLO 21: L’OPPOSTO DI QUESTA SOLITUDINE
Andrea Marinelli, giornalista, e Antonio Rovaldi, Milano, Italia
Caro Antonio,
sfogliando il tuo libro ho riavuto New York e gli incontri fortuiti di una passeggiata lungo i fiumi. In questi giorni di quarantena, che ci tengono lontano dalla città, mi ritrovo ad avere continui flash, attimi newyorkesi che si materializzano all’improvviso: vengono e se ne vanno rapidi, lasciando una piccola traccia in fondo alla memoria, che spesso devo sforzarmi per riportare in vita. Ce ne sono alcuni, però, che sono diventati ricorrenti come i sogni, come un fioco abat-jour che illumina la fine di questa vita sedentaria.
Mi è apparsa spesso una passeggiata notturna sotto la neve, per tornare a casa dal cinema fra la 19esima strada e Broadway. Eravamo soli, io e Serena, abbiamo attraversato Gramercy Park senza incontrare nessuno e poi abbiamo visto spuntare fra i fiocchi le luci colorate sulla vetrina di Rolf’s, un ristorante tedesco che ho sempre amato pur senza esserci mai entrato. Non ricordo altro – né quale fosse il film, né cosa accadde dopo aver girato l’angolo della 3rd Avenue in quell’inverno del 2015 – ma in testa ho l’intensa felicità di quei pochi isolati che avrei voluto continuare a percorrere per anni.
E sarà che nei miei ricordi solo la neve può svuotare le strade di New York come questo lockdown, ma per la mente mi è capitato spesso il ricordo di una tempesta furibonda di qualche anno prima, sarà stato il 2012, affrontata con un cappotto pesante, due maglioni e qualche bicchiere di bourbon in un bar di Bushwick: l’unica cosa che ricordo è la porta che si apriva e il brusio che, mischiandosi al vapore, usciva sciogliendosi nella neve.
C’è una terza immagine su cui inciampo spesso in questi giorni, spesi vagando fra la cucina, il soggiorno, il terrazzo e la camera da letto, pestando di tanto in tanto un giocattolo abbandonato, come quei pattini bianchi solitari che hai incrociato sul marciapiede di Zerega Avenue, nel Bronx. È il pianista che suona vecchie canzoni in un angolo del Water Club, una chiatta ancorata sull’East River dove una volta c’era il mio ristorante preferito di Manhattan: era sotto casa dei miei genitori, ci festeggiavamo compleanni, arrivi e partenze e belle notizie. L’unico suono che sento, però, è il caminetto che scoppietta alle spalle del pianista.
Ti racconto questo, Antonio, perché mi sono chiesto da dove venissero questi ricordi, ma soprattutto dove mi volessero portare. Poi, qualche giorno fa, ho capito che è il modo con cui la mia mente intendeva partecipare alla quarantena e alla solitudine della città che mi ha reso adulto e da cui, mai come in questi giorni, sono stato felice di esserle lontano e triste allo stesso tempo.
C’è un’altra cosa a cui penso, camminando con te lungo i confini della città: mi tornano in mente, chissà perché, gli adesivi con la scritta United We Stand attaccati dopo l’11 settembre al parabrezza di ogni camion, sul lunotto posteriore di ogni auto, sulla canna di ogni bicicletta. Ci penso perché, seppur spaventata, quella era un’America che remava unita e orgogliosa nella stessa direzione, come i fratelli Abbagnale della nostra infanzia.
Come tutte le grandi tragedie umane, climatiche ed economiche che in questo millennio hanno colpito New York, l’11 settembre è stata un’esperienza comunitaria vissuta, consumata ed elaborata insieme. Lo sono stati anche l’uragano Sandy che ha allagato Manhattan e spazzato via Long Island, e la crisi finanziaria del 2008: avevano svuotato le strade e i locali giusto il tempo di schivare il pericolo, per poi ripartire tutti insieme.
Questo virus che ci ha chiuso in casa, invece, è un’esperienza comunitaria vissuta in solitudine, che ha intaccato l’unità con cui l’America sapeva affrontare le avversità: una coesione umana, ma anche politica. Come ha raccontato al New York Times lo chef Andrew Carmellini, «dopo l’11 settembre, quando tutti cominciarono a uscire dalla nebbia, volevi socializzare. Volevi ubriacarti, farti un hamburger, vedere i tuoi amici per sentirti al sicuro e a tuo agio», ha spiegato. «Questo è proprio l’opposto».
Opposto come le direzioni verso cui, scrivendo ogni giorno cronache americane, sento andare il Paese, trascinato dalle guerre culturali dei partiti – sulla quarantena, sulla gestione di questa epidemia, sull’uso della mascherina, ma anche sull’aborto, sull’immigrazione e chissà cos’altro – che ci fanno sentire tutti più soli contro il mondo.
Scriveva Marina Keegan – che prima di morire a 22 anni è riuscita a essere un’apprezzata scrittrice, giornalista, poetessa, attrice e sceneggiatrice – «non abbiamo una parola per l’opposto di solitudine ma, se ci fosse, sarebbe quello che vorrei nella vita».
Ecco, caro Antonio, quello che auguro a noi, a New York e al mondo è proprio l’opposto di questa solitudine che viviamo oggi.
Andrea
.

Hurricane Sandy vicino al suo picco di forza il 25 ottobre 2012, poco prima di colpire Cuba. Fonte: Wikipedia.
.

.

.

.

.

.

.

Antonio Rovaldi, il giorno dopo Hurricane Sandy camminando per Alphabet City a Manhattan, New York City, 30 ottobre 2012. Fotografie scattate in bianco a nero con una Bronica 6×4.5 che poi si è rotta cadendo per terra. Questi sono i suoi ultimi scatti.
_______________________________________________________________________________________________
Milano • 15 maggio 2020, venerdì
Ciao Andrea,
la tua camminata newyorkese mi ha ricordato un vecchio libro fotografico in bianco e nero sulla storia delle tempeste di neve a New York che avevo acquisto da Strand anni fa, trovato sui carrelli carichi di libri fuori dalla libreria all’angolo fra Broadway e la 12th St. Poi una serie di fotografie che scattai io stesso nel 2012 poco prima che Hurricane Sandy si riversasse sulla città e la mattina seguente quando mi risvegliai in una stanza nell’East Village dove avevo dormito da amici – quella notte in realtà non dormimmo per nulla e la passammo a camminare con gli stivali di plastica da pescatore per le strade allagate del Village, dove la gente del quartiere si era radunata tra la quarta e quinta strada su Avenue C per mettere in carica i cellulari all’unico generatore disponibile.
Andai a fotografare alcuni projects ad Alphabet City e poi lungo l’East River scoperchiato dalle raffiche di vento. Quelle immagini le scattai con una Bronica 6×4.5 che dopo pochi giorni mi scivolò dalle mani e si sfracellò su un marciapiede di Manhattan. Le immagini che ti mostro qui sotto sono le ultime che ha scattato quella macchina.
Fra le tante c’è una fotografia in cui si sono sovrapposti due negativi e si vede un uomo con un cappello e un bastone che mi ricorda un’altra fotografia, quella del poeta svizzero Robert Walser ritratto fuori dalla clinica di Herisau, nell’Appenzello svizzero, dove il poeta visse gli ultimi trent’anni della sua vita, prima di morire il giorno di Natale del 1956 su un sentiero che il poeta aveva percorso ogni giorno nell’arco di trent’anni. Quella fotografia è appesa di fianco al mio letto.
Walser in quell’immagine indossa il suo unico completo da passeggio, una cravatta un po’ sgualcita e tra le mani stringe il suo ombrello con quella sua tipica “ritrosia da uccello notturno”, unico oggetto a cui il poeta non si staccava mai. Cadono fiocchi di neve e forse quel giorno, anche nell’Appenzello svizzero, si scatenò una bufera.
Quell’anziano signore, che cammina indossando un cappello, un soprabito scuro e il suo bastone dentro un project nell’East Village dopo quella tempesta di fine ottobre, non può che farmi immaginare l’anima di Robert Walser che dopo aver attraversato le colline intorno a Herisau e il lago di Costanza, durante un giorno di neve, vaga nella città di New York fino alle prime luci dell’alba sullo sfondo di una città devastata da una tempesta.
Le immagini hanno il potere meraviglioso di portarci altrove e di dare un senso a cose, luoghi e persone apparentemente così distanti…
Ci sono dei giorni che se penso a New York mi manca il fiato.
Buona notte,
Antonio
.

Ritratto di Robert Walser fuori dalla clinica di Herisau, nell’Appenzello svizzero, fotografia scattata da Antonio Rovaldi il sabato pomeriggio del 16 maggio 2020.
_______________________________________________________________________________________________
Milano • 17 maggio 2020, domenica
Ciao Andrea,
solo per dirti che questa mattina sono passato in studio a prendere quel libro di cui ti ho faccio cenno nella mia prima risposta: Great Blizzard of New York City – A Photographic History of New York City’s Most Memorable Winter Storm, di Kevin Ambrose (pubblicato da Historical Enterpres, 1994).
.

Alla pagina 5 leggo: Introduction. Sotto vedo un disegno molto bello apparso sul New York Times il 15 gennaio del 1910. Due uomini camminano in direzione opposta, controvento.
.

Alla pagina 60 vedo: Snowbound cars on the Belt Parkway in Brooklyn, February 5, 1961. La strada a doppia corsia è completamente stretta nella morsa di neve ghiacciata, ci sono macchine in fila semi sommerse dalla neve. Sul ciglio della strada, sotto un palo della luce, si vedono quattro uomini. Alla pagina 270-271 del mio libro The Sound of The Woodpecker Bill: New York City due fotografie affiancate ricostruiscono il Fresh Creek, a Brooklyn. Lo nota alle immagini dice: November 2. 2017 / Belt Pkwy and Fresh Creek.
.

Alla pagina 108, nella sezione finale del libro titolata Other Storms, vedo: un lago ghiacciato con tre uomini – uno di loro stringe un lungo palo tra le mani – e uno strano oggetto di ferro con una scaletta. La didascalia dell’immagine dice: Apparatus to save ice skaters who have fallen throught the ice, February 28, 1917. Designed by George Hanlon, foreman of Queens’s Department of Parks – Library of Congress.
.

Immagino che pattinare su un lago ghiacciato possa restituire al pattinatore una sensazione euforica e adrenalinica; il ghiaccio all’improvviso potrebbe creparsi e aprirsi sotto i suoi piedi, con un rumore sordo aprire una crepa e in pochi instanti far scompare quel corpo dalla superficie del lago…
Suppongo che quel lungo palo servisse per arpionare il pattinatore sfortunato, o la pattinatrice, e avvicinarlo/a a quella scaletta collegata alla pedana manovrata da un secondo uomo, e infine portarlo in salvo, di nuovo tutti quanti in bilico sullo stesso strato di ghiaccio. Per cui deduco che forse, ogni tanto, anche quei tre salvatori potessero naufragare nelle stesse acque ghiacciate.
Loro, la scaletta, il lungo palo, coloro o colei che avrebbero dovuto salvare. Spero di sbagliarmi.
Ciao,
Antonio
CAPITOLO 22: IL FUOCO DEL CAMMINO COVÒ A LUNGO
Francesco Pedrini, artista, e Antonio Rovaldi, Bergamo – Milano, Italia
Bergamo • 16 maggio 2020
Caro Antonio
come stai?
La tua bicicletta? Che poi non è una bicicletta, è un portachiavi che tieni sempre con te. A pensarci bene non ti ho mai visto su di lei, ma sempre con lei; tra di voi sembrerebbe intercorrere un rapporto umano/amoroso, cerchi sempre di non lasciarla in strada e quando la leghi a un palo lo fai come se le chiedessi scusa, come se il mondo non capisse, ma io ho scoperto il vostro segreto.
Oggi mentre disegnavo l’aria di un tornado, mi è venuta in mente la tua mostra in GAMeC e ho fatto una specie di volo astrale che mi ha portato dentro le tue camminate, ho sentito la tua solitudine, ma quella bella, quella del solitario che ha una direzione, non dell’uomo solo.
Beato te.
.

Francesco Pedrini –Tornado#7, 2017, grafite, carboncino, pigmenti su carta Kozo, 100 x 140 cm
.

Francesco Pedrini – Tornado#8, 2017, grafite, carboncino, pigmenti su carta Kozo, 100 x 140 cm.
.

Francesco Pedrini –Tornado#9, 2017, grafite, carboncino, pigmenti su carta Kozo, 100 x 140 cm.
.

Francesco Pedrini, Tornado#14, 2018, grafite, carboncino, pigmenti su carta Kozo, 100 x 140 cm
.
Il camminare è una pratica per perdersi, non per fermarsi a immortalare qualcosa. Il ricordo è vivo, si modifica nel tempo, resiste in strati profondi, ma basta poco per farlo riemergere. La memoria è una continua tensione tra profondità e superficie, che ci investe e ci abbandona.
I ricordi sono brividi.
Penso un paesaggio senza il dovere di divenire immagine e quindi – solo ed enormemente – PASSAGGIO.
Non c’è paesaggio senza un passaggio. Serve qualcuno che lo attraversi e fissi nella memoria quella veduta.
Quando le parole si sfiorano è perché si dipendono, si sostengono e si completano.
Il ricordo è sempre di passaggio, anzi di più, alcuni ricordi sono nomadi, tornano sempre negli stessi posti.
Il brivido che ti voglio regalare è datato 2010, ora mi trovo lì.
Sono immerso nel tuo stesso silenzio, se tu volessi venire qui, oltre ad andare indietro nel tempo di dieci anni impiegheresti almeno cinque giorni, tre voli aerei, cinque bus e tanta strada per arrivare a El Peñon sulla Puna argentina. Oppure un volo aereo, una bicicletta e qualche settimana.
Dopo giorni di cammino mi trovo in mezzo ad un deserto circondato da vulcani alti oltre 6000 metri, è un paesaggio marziano, dove anche i batteri faticano a vivere e le stelle sono più numerose che altrove.
Quello che vedo è un mare bianco di pietra modellata dal vento che taglia in due una regione intera di vulcani, guardo l’uomo che mi precede e che è sempre vissuto qui e scrivo su un foglio:
“Ci sono persone che si nutrono di paesaggio, non hanno altro. Camminano giorni per arrivare in un luogo e sedersi lì, ma non lo guardano, non lo vedono, non lo immaginano, a loro non serve. È talmente dentro di loro che è impossibile da nominare o da indicare in quanto loro sono paesaggio. Questo uomo è piena natura fusa, fatta di visioni, spiritualità e di un altrove che io non posso conoscere. Io qui capisco che il nulla e l’infinito si toccano, sono quasi la stessa cosa e in quel ‘quasi’ c’è la storia dell’universo.
Qui c’è solo una sola nuvola che scompare e quella nuvola ha dentro tutto questo.
Non mi resta altro che tentare di comprendere il cielo.”
.

Francesco Perdini – Until#5, (Campo de Pedra Pomes), 2010, 9 stampe inkjet su carta grafica, dimensioni variabili
_______________________________________________________________________________________________
Milano • 15 maggio 2020, venerdì
Ciao Francesco,
ieri dopo avere letto le tua email, carica di scosse elettriche e vortici in mezzo a deserti sbiancati, a Milano ha cominciato a diluviare e ha continuato per quasi tutta la notte.
Non so da voi a Bergamo, ma qui sembrava di stare nel bel mezzo di un tuo ciclone.
Speriamo che tutta l’acqua che si è riversata sulla città abbia spazzato via un po’ del virus…
I tuoi disegni meteorologici a grafite mi hanno ricordato un video di Francis Alÿs del 2010 che ho sempre amato molto e che porta lo stesso titolo della cartella azzurra che mi hai inviato ieri sera: TORNADO. Una telecamera filma Alÿs che entra dentro un vortice di polvere, da qualche parte su un promontorio arido del Messico, poi la ripresa diventa soggettiva e l’artista sparisce dentro quella nuvola marrone e sia la sua videocamera che l’artista diventano un’unica cosa dentro quel movimento circolare. Come i tuoi disegni quel video contiene un potenziale creativo immenso, un luogo che non sai esattamente né dove comincia né dove finisce e quanto tempo impiegherà a essere fermato in un’immagine.
A Bergamo, durante i giorni di allestimento nelle settimane che hanno preceduto l’opening alla Barchessa, venivo sempre in bicicletta. La caricavo nella pilotina in testa al treno e poi, una volta arrivato alla stazione, pedalavo fino al museo, anche con una mano ingessata perché in quel periodo cadevo spesso, picchiando sempre nello stesso punto. Nella Stanza della Bachessa all’Accademia Carrara si vede il mio casco bianco di fianco allo zaino rosso da montagna. In quei giorni ero tutto un andare e tornare: Milano-Bergamo, Bergamo-Milano…
Scendere da un treno con la bicicletta mi fa sentire più vicino a una città che non conosco bene e più agile nel momento in cui decido di lasciarla. La bicicletta mi aiuta a dissolvere l’irrequietezza, che è sempre tanta.
Ora “Non mi resta altro che tentare di comprendere il cielo” di questo sabato, scendere di sotto e andare al mercato che oggi, dopo due mesi di assenza, è tornato a riaprire.
Antonio
.

.

.

Immagini prese del video Tornado di Francis Alÿs, Messico, 2010, 00:42min, dal sito dell’artista.
.

Un giorno di febbraio dentro la stanza della Barchessa durante l’allestimento della mostra Il suono del becco del picchio.
.

La mia bicicletta fotografata con il cellulare alla Stazione Centrale di Milano il 17 gennaio alle ore 08:02, poco prima di salire sul treno regionale per Bergamo.
CAPITOLO 23: HELLO AMERICA
Francesco Zanot, critico e curatore, Milano, Italia
Nel 1981 J.G. Ballard pubblica un breve romanzo di fantascienza (distopico, postapocalittico, il più attuale dei sui attualissimi racconti) che segue la spedizione di un gruppo di scienziati ed esploratori alla riscoperta degli Stati Uniti. Approdano in una New York completamente deserta, letteralmente, sommersa dalle dune calde sotto il sole di un mezzogiorno infuocato, prima di avventurarsi verso Ovest attraverso una terra resa inabitabile da un disastro ecologico e abbandonata cent’anni prima da un intero popolo ormai ridotto all’osso. L’anno è il 2114. Il racconto si intitola “Hello America”. In Italia viene pubblicato come “Ultime notizie dall’America” all’interno della collana Urania, in un numero doppio uscito a Natale. Per l’esattezza: Urania n. 908 – 27 dicembre 1981. Sul retro di copertina si legge: “Da oltre un secolo non si avevano più notizie dagli USA. Il grosso della popolazione americana s’è ormai ritrasferito da tempo nei continenti d’origine – Europa, Asia, Africa – e questi continenti sono stati troppo presi dai problemi della loro stessa sopravvivenza per occuparsi d’altro. Ora finalmente una spedizione europea che rinnova curiosamente quella di Cristoforo Colombo, viene spedita laggiù…”.
Francesco Zanot – Hello America, 21’ 25”
Tutte le immagini, se non diversamente indicato, sono tratte dal libro di Antonio Rovaldi The
Sound of The Woodpecker Bill: New York City, Humboldt Books, 2019
CAPITOLO 24: I AM VAST. VAST
Cecilia Canziani, Critico d’arte e curatrice, e Antonio Rovaldi, Roma – Milano, Italia
Caro Antonio,
una quindicina di giorni fa ti ho scritto di getto e ti ho mandato una fotografia di Timothy O’Sullivan. senza didascalia, e tu l’hai riconosciuto subito. In queste settimane succede così: qualcuno mi dice una cosa, nomina un libro, vedo per caso un’immagine, e io seguo la suggestione con molto puntiglio. Che in questo caso aveva a che fare con la tua mostra, che non sono riuscita a vedere (i buoni propositi per il futuro: non rimandare le cose mai più), la lettura delle tue corrispondenze pubblicate qui che mi sembravano restituire non la mostra, ma le ragioni del tuo lavoro – la sua spazialità –, e un verso della nuova canzone di Bob Dylan, preso in prestito da Walt Whitman, che non riuscivo a levarmi dalla testa. I am vast. Vast.
La questione della misura – o meglio della dismisura – nel paesaggio americano. Dopo la guerra di secessione tanti fotografi che l’avevano documentata, seguono la costruzione della ferrovia che attraversa l’America e poi le missioni geologiche a Ovest, e mi sembra una concatenazione logica, la costruzione della storia e del paesaggio, in fondo una forma di racconto epico moderno che è la caratteristica dell’arte e della letteratura americana.
La foto che ti ho mandato è stata scattata lungo il fiume Colorado. Tra i fotografi che hanno ritratto il paesaggio americano Timothy O’Sullivan è il mio preferito. Credo sia l’inquadratura ad averti fatto riconoscere immediatamente l’autore. Sono paesaggi monumentali, che esigevano una stampa di grande formato. William Henry Jackson per esempio sulle Montagne Rocciose usa lastre di 50 x 60 cm, perché la misura – la dismisura – del paesaggio può essere restituita solo attraverso un formato in eccesso.
Anni fa su una bancarella ho comprato un librino che ho tirato fuori dalla libreria in questi giorni, si chiama La Pittura Americana e l’introduzione alla traduzione italiana è di Francesco Arcangeli. La storia inizia con John White, che nel 1585 documenta piante, animali e abitanti della Virginia (i suoi acquarelli sono alla base dei parati dell’appartamento rococò di Palazzo Barberini, fatto realizzare da Cornelia Costanza dopo il 1750. Ti porterò a vederli). Scorrendo le pagine si trova la descrizione della veduta del Cotopaxi di Church, o del corso dell’Hudson di Cole, e una stupenda descrizione di Winslow Homer: “Così scomparvero dalle sue vedute gli uomini del mare e rivisse soltanto l’oceano sconfinato, battuto dai venti tempestosi che si abbattevano sulla costa. Le impressioni dei quadri sono potenti come se fossero opera di un gigante; sembra veramente strano che un simile pittore sia stato descritto come un piccolo e riservato gentiluomo di maniere gentili e senza ostentazioni”. I am a man of contradictions. I am vast. I contain moltitudes.
“Mentre lavoravo pensavo a coloro che avevo visto all’Est: parlavano continuamente dell’idea di scrivere il Grande Romanzo Americano, il Grande Teatro Americano, la Grande Poesia Americana. Non sono sicura che aspirassero anche alla Grande Pittura Americana. Nei loro discorsi, l’aria era così satura di Cezanne da rendere addirittura impensabile il sogno di una Grande Pittura Americana. Io conoscevo le pianure del centro del paese e le terre delle mandrie, avevo visto il Sud, sapevo che i nostri paesaggi erano ricchi e lussureggianti. Più volte avevo attraversato il paese in automobile” scrive Georgia O’Keeffe, che descriveva la sua Ford A, con cui si addentrava nel deserto, come il posto più comodo per lavorare. Nel New Mexico, dove si stabilisce, Georgia O’Keeffe dipinge paesaggi, ossa, semi e frutti. Come i suoi fiori, questi soggetti riempiono la tela, la scala è esorbitante, al punto da rendere illeggibile, astratto, quello che per lei è evidentemente figura: Grande Pittura Americana. Nel 1968 dopo diciotto mesi dalla sua partenza da New York alla guida di un pick up, Agnes Martin approda a quello stesso paesaggio, e si ferma. Lì, passati sette anni, ricomincia a dipingere – sono quadri nuovi, tele percorse da larghe bande dipinte con colori tenui. Celesti, gialli, rosa delicatissimi. Viola. Grigi. L’ispirazione – che Martin descrive come una forma di felicità, un aprirsi dei sensi – le è tornata davanti allo stesso deserto – aperto, vasto, incommensurabile – dove prima di lei ha vissuto O’Keeffe.
I saw the plains driving out of New Mexico and I thought
the plain had it
Questione di scala.
Probabilmente perché non si può viaggiare, a me che viaggiare fa sempre una gran pigrizia, è venuta voglia di guardare carte geografiche e atlanti. E i vasti paesaggi americani.
L’altro giorno sono andata a trovare mia madre che non vedevo da due mesi. Mi ha consegnato una borsa piena di fotografie, cartoline e mappe di un suo zio, che io ho conosciuto e a cui ho voluto molto bene. Era un sacerdote, è stato partigiano, ha viaggiato molto e ha molto amato viaggiare. Nelle fotografie sorride sempre.
Cerco di mettere in ordine le immagini che ha scattato: ci sono negativi arrotolati, diapositive, delle lastre Ferrania a colori di cm 6×6, cartoline e fotografie il cui formato tradisce il decennio in cui sono state stampate le immagini. Ho tenuto da parte un paesaggio sovraesposto del Mar Morto al tramonto e una veduta di Hong Kong dall’alto, che credo abbia visitato nei primi anni Sessanta. Sono immagini piccolissime. I ricordi delle nostre famiglie sono affidati a questi rettangoli minuti e sbiaditi, in cui a malapena si riesce a discernere un volto, un luogo.
Questioni di scala.
Cecilia
.

Timothy O’Sullivan – Black Cañon, Colorado River, Looking Below, Near Camp 7, 1871. MoMA.
.

Thomas Cole – View from Mount Holyoke, Northampton, Massachusetts, after a Thunderstorm—The Oxbow, 1836, oil on canvas, 130.8 x 193 cm, The Metropolitan Museum of Art.
.

Maria Chabot – Georgia O’Keeffe, Breakfast, The Black Place, 1944. Gelatin silver print, 5 x 3 1/2 inches. Georgia O’Keeffe Museum. Gift of Maria Chabot. © Georgia O’Keeffe Museum.
.

Gianfranco Gorgoni – Agnes Martin near her house in Cuba, New Mexico, 1974.
.

Georgia O’Keeffe outdoors with Pelvis Series Red With Yellow, 1960 CREDIT: Tony Vaccaro/GETTY IMAGES
.

Foto di famiglia, ritratto di Don Ugo Orso, anni ’40 (archivio di famiglia di Cecilia Canziani).
_______________________________________________________________________________________________
Fase 2, premessa
Ieri sono andato a fare una lunga camminata in montagna. Troppo lunga per lo stato di immobilità degli ultimi mesi. Non conosco le montagne lombarde e ho deciso che voglio cominciare a esplorare la regione in cui vivo, la Lombardia, non senza un grande ritardo rispetto alla mia biografia milanese.
Ieri con Gaia e Tommaso sono salito sul Resegone, una montagna brulla che sembra un pezzo di formaggio rosicchiato da un topo. Avremmo dovuto coprire qualche centinaio di metri di dislivello con una funivia anni ‘80, ma abbiamo preferito salire a piedi, fosse solo per non stare chiusi con le mascherine dentro un cubo di ferro sospeso nel vuoto, dopo due mesi di isolamento forzato.
Siamo arrivati in cima sfiancati dalla fatica e dopo aver avvistato un camoscio imbalsamato su uno strapiombo, abbiamo cominciato a ridiscendere. Siamo arrivati al parcheggio che cominciava a calare il sole, i polpacci tremolanti e il collo ustionato.
Milano • 22 maggio 2020
Cecilia, ciao
ho riletto più volte la tua ultima lettera, vasta come una Grande Pianura americana del Nebraska, dell’Oklahoma, persino del Kansas!
Le tue connessioni tra le immagini hanno fatto affiorare ricordi di pianure emiliane e americane, e viceversa, spalancato finestre su libri come un colpo di vento soffiato dalla strega dell’ovest contro le pareti della mia stanza, che in queste settimane vacilla dentro il giro dei giorni e basta un attimo che può staccarsi dal suolo e schizzar via…
(a volte vorrei che la mia casa volasse altrove)
Quando ho letto il nome di Francesco Arcangeli nella tua lettera sono andato in studio a recuperare un suo libro che mi aveva prestato mia madre anni fa, Incanto della città dove, in copertina, c’è un Paesaggio di William Turner: un sole che tramonta tra due promontori. Arcangeli era stato professore di storia dell’arte di mia madre durante i suoi anni universitari bolognesi e anche amico di suo padre, mio nonno, con il quale spesso si intratteneva in lunghe chiacchiere intorno alla pittura. Mio nonno, infatti, oltre a fare il preside in una scuola di Parma e insegnare latino con polso fermo ai suoi studenti – e a mia madre – collezionava mobili di antiquariato e tele di pittori minori cinquecenteschi. Mia madre mi ha sempre detto che il nonno, dalla sua cantina-laboratorio, capitava si lasciasse scappare anche dei Morandi, ma queste forse sono leggende emiliane che nel tempo hanno accumulato polvere di antichi telai, vecchi lampadari di vetro, e probabilmente qualche bicchiere di lambrusco di troppo…
Quando mia madre ricorda le lezioni di Francesco Arcangeli all’università, si commuove sempre e spesso nomina anche il fratello Gaetano, che era un bravo poeta. Tra le ultime pagine di Incanto della città c’è un capitolo intitolato La mia casa, dove all’estremità destra della pagina c’è una piega, fatta poco dopo che mia madre mi diede questo libro, non senza ricordarmi di averne particolare cura perché “questi sono i libri della libreria a cui tengo di più”. (sul retro: 15.000 Lire, IVA compresa)
Alla pagina 165 rileggo:
“Posso dire di non avere più una casa mia, veramente mia. Lo so con certezza da anni; da una sera soprattutto, una tarda sera di guerra che stavo con la fronte poggiata ai vetri di una stanza che abitavo da qualche anno; e ancora superstite, reso malfermo dal nostro appartamento distrutto quasi per intero dalla bombe. Una sera d’autunno, con l’ultima luce del giorno oltre file di tetti a occidente, lontano, al limite d’un cielo quasi verde, cupo del primo abbuiare; le prime stelle, che splendore, una luce tremante, candida. Io stavo con la fronte ai vetri, le spalle prese entro il buio di una vita ormai perduta, dietro, nella casa che non avrei abitato più. Pensavo a un mio amore lungo, vano, solitario; là, a occidente, dietro quei tetti, c’era la casa dove aveva abitato lei e dove non stava più da tempo. Anche quell’amore non sarebbe tornato mai più. Le case che avevamo lasciato, le vecchie case, le vere case della mia città, intonachi scoloriti come volti usati dalla vita, le persiane patinate dalla polvere, persiane verdi, brune, celeste pallido, le case fatte per l’ombra e per i brevi saluti del sole, la case fatte per raccogliere le lunghe tristezze, ma anche le intimità, la gioia della vita infantile o adolescente, quando si chiude nel giro indicibilmente geloso delle feste invernali: tutto questo non lo avrei avuto mai più.”
Quando ho letto questa pagina ho pensato a Davide Ferri, gli anni in cui andavo a trovarlo a Bologna nella sua casa sommersa di polvere, pile di libri e mozziconi di sigarette – tu sai di cosa di parlo – e poi ho pensato alle macchie di colore a olio lasciate da Luca Bertolo lungo i margini dei suoi quadri, “al limite d’un cielo quasi verde, cupo del primo abbuiare…”, dall’alto del suo Monte Altissimo, o dentro il suo giardino di Fabbiano, in Versilia, delimitato da muri di sasso.
(Le recinzioni non solo dividono un territorio e disegnano un paesaggio, ma ci fanno sentire protetti, come nella fotografia di Mattew W. Brady The Lutheran Seminary, dove si vede un uomo di spalle seduto a cavalcioni su una palizzata di assi di legno bianco che mi ricordano, con un salto di un secolo, le linee dipinte da Agnes Martin negli sconfinati e aridi spazi del New Mexico).
Tornando ai vasti paesaggi americani (sì, I am vast. Vast) e alla fotografia di Timothy O’Sullivan che mi hai mandato e che ho riconosciuto dopo averla per un istante confusa con un’altra roccia molto somigliante di Carleton Watkins, altro sguardo vastissimo di quell’America in cui il paesaggio, a cavallo fra i due secoli, era già tanto in trasformazione. Cercando su internet immagini di O’Sullivan ho trovato un ritratto strepitoso che il fotografo fece ad Alfred R. Waud, artista disegnatore di Herper’s Weekly, durante la guerra civile.
Waud è ritratto seduto su un masso: una gamba alzata fa da appoggio al suo album da disegno, l’altra allungata sulla roccia, due stivali di pelle nera fino al ginocchio, una pistola dentro il fodero legato ai fianchi, una giacca nera, una camicia con tre bottoni, un cappello inclinato su un lato, barba lunga e sguardo affilato rivolto verso destra dove, molto probabilmente, si era appena conclusa una sanguinosa battaglia. Il ritratto di Waud mi ricorda Autoritratto con cane nero di Gustave Courbet (1842), dove il pittore francese si ritrae con il suo cane, un blocco da disegno, un cappello a tesa larga su riccioli neri e una lunga pipa in una mano, avvolto in tessuti morbidi come le tonalità rosate della pietra alle sue spalle e del paesaggio serale sullo sfondo.
Il ritratto di O’Sullivan racconta un campo di battaglia attraverso lo sguardo di Waud: un fotografo che guarda un artista che osserva un paesaggio di guerra. Nel suo autoritratto Courbet ritrae sé stesso mentre si guarda, nel momento conclusivo di una giornata di lavoro all’aria aperta.
Geografie di sguardi tra vecchio e nuovo mondo.
So far so close.
All’epoca molti fotografi americani si spostavano nel territorio con attrezzatura pesante, spesso erano voluminose scatole di legno che poggiavano su solide gambe, tipo quelle dei cavalletti dei pittori – come l’illustrazione che ti allego qui sotto e titolata The Photographer’s outfit.
Timothy O’Sullivan ha fotografato il paesaggio americano durante la guerra di indipendenza, spesso le sue immagini mostrano il paesaggio a scontri appena conclusi, cadaveri allineati per terra, lunghi fucili appoggiati a muretti a secco, palizzate di legno divelte. Fotografare la guerra durante la sua azione, infatti, sarebbe stato decisamente troppo pericoloso, così O’Sullivan attendeva la conclusione di uno scontro fra le parti, posizionava la sua ingombrante attrezzatura e poi scattava immagini di una drammaticità assoluta. A guardarle sembra proprio di essere lì.
La fotografia come documento a volte può essere fastidiosamente reale, le immagini di O’Sullivan sono talmente reali che diventano pura bellezza anche quando ci mostrano i corpi gonfi di confederati stesi a terra dopo una battaglia. Sullo sfondo della fotografia The Battlefield of Gettysburg, si vede un uomo a cavallo e poco distante altri due uomini, probabilmente stavano contando i cadaveri di quel caldo giorno di luglio del 1883 a Gettysburg…
Se avessi la possibilità di schiacciare un bottone e per un momento ed entrare dentro epoche passate, fra le tante sceglierei di stare vicino a O’Sullivan mentre scatta una fotografia dall’alto di una pietra levigata su un colle, un paio di stivali di pelle alti e sgualciti, la barba lunga e una pesante lastra fotosensibile tenuta tra le mani, pronta per passarla a Timothy…(resterei al suo fianco per pochi istanti, solo il tempo di sentire il suo accento dalle origini irlandesi).
Oggi mi è arrivato un libro che avevo ordinato alcuni giorni fa e che la portinaia, come di consueto, mi ha messo dentro l’ascensore. Ho schiacciato il bottone e dal primo piano il libro è salito al sesto.
Jared Diamond, Come le società scelgono di morire o di vivere, Ed. Einaudi 2014.
Sono felice se riusciremo a passare un po’ di tempo tutti insieme quest’estate in Versilia, tra case di sassi, vecchie mulattiere e cave annerite dal tempo. Io, come ogni anno, vi raggiungerò con la mia bicicletta dal Golfo dei Poeti, poi Seravezza verso la salita di via Giustagnana, un saluto all’essenziale Pieve romanica di S. Martino e infine Fabbiano e la casa di Luca e Chiara.
Lontano, in basso, il mare.
(sempre che riaprano la Lombardia)
Antonio
.

Francesco Arcangeli – Incanto della città, Rapporti / Nuova Alfa Editoriale, Bologna 1984.
.

Carleton Watkins – The Art of Perception, San Francisco Museum of Modern Art • Harry N. Abrams, Inc., Publishers, 1999.
.

A sinistra: Timothy O’Sullivan, Gattysburg, Pa – Alfred R. Waud, artist of Harpe’s Weekly, Sketching on battlefield, 1863 July. 1 negative: glass, stereograph, wet collodion, 4×10 in. A destra: Gustave Courbet – Autoritratto con cane nero (1842), Petit Palais Musée des Beaux-Arts de La Ville de Paris – PH. SdA.
.

The Photographer’s outfit – immagine trovata nel web, maggio 2020.
.

Timothy O’Sullivan – The Battlefield of Gettysburg, July 1863. Library of Congress, Washington, D.C. (LC-B8184-7964-A DLC).
.

Stivali usati durante la Guerra di Secessione americana, immagine trovata nel web, maggio 2020.
.

Matthew W. Brady – The Lutheran Seminary.
.

Agnes Martin – untitiled, 1959, Oil on canvas, 24 x 48 in., Dia Art Foundation, New York in Nancy Princenthal, Agnes Martin, Her Life and Art, Thames & Hudson, 2015.
_______________________________________________________________________________________________
Dimenticavo Cecilia, la Sala della Barchessa all’Accademia Carrara ha riaperto le sue porte il 22 di maggio alla mostra Il suono del becco del picchio e resterà visitabile fino al 26 luglio. Se sali su al nord, fai un fischio che ti accompagno.
CAPITOLO 25: THOREAU 160/200
Alessandro Calabrese, artista, e Antonio Rovaldi, Milano, Italia
Milano • 12 maggio 2020
“Quando scrissi le pagine che seguono – o meglio la maggior parte di esse – vivevo da solo, nei boschi, a un migliaio di distanza dal più prossimo vicino, in una casa che m’ero costruito da me sulle rive del lago Walden, a Concord, Massachusetts; mi guadagnavo da vivere con il solo lavoro delle mie mani. Vissì colà per due anni e due mesi. Attualmente sono ritornato nel consorzio civile.”
Henry David Thoreau: Walden – Vita nei Boschi – Capitolo 1: Economia
Ciao Alessandro,
ci siamo sentiti al telefono qualche giorno fa e ti ho sentito bene.
Questa mattina, dopo la colazione, ho rimesso ordine alla mia cassettiera bianca, dove tengo i disegni e le stampe fotografiche. Dentro una cartella ho ritrovato dei negativi e delle stampe in piccolo formato di un viaggio che feci in America durante l’estate del 2005, a conclusione del mio primo lungo capitolo newyorkese. Avevo preso un volo per Boston da New York City e poi noleggiato una macchina per andare a visitare i luoghi dello scrittore transcendentalista Henry David Thoreau. Avevo appena terminato la lettura di Walden – Vita nei boschi e volevo andare a vedere il cabanon di legno, vicino a Concord, Massachusetts che lo scrittore costruì lungo le sponde di un piccolo lago – il Walden Pond – dove visse in quasi totale solitudine per circa due anni (dico quasi totale perché pare, che ogni tanto, anche Mr. Henry, colto da attacchi di solitudine, di tanto in tanto raggiungesse i suoi vicini a Concord per fare due chiacchiere, o viceversa. Capitolo VI: Visitatori).
Sul tavolo basso nel mio soggiorno stendo le fotografie di quel viaggio e vedo:
– paludi con erba spessa di diverse tonalità di verde circondate da boschi
– vapore che sale dall’acqua colpito da un raggio che filtra tra i rami del bosco
– il volto di una donna anziana con un’espressione introversa
– ancora una palude con erba più scura
– una casa nella cittadina di Concord costruita con fasce di legno dipinto di bianco (quella di Ralph Waldo Emerson?)
– un’altra casa bianca con le persiane verdi e una staccionata
– al centro una ferrovia con doppi binari, molto dritti e molto lunghi
– una lapide di pietra con delle pigne alla base e una scritta incisa: HENRY
– una bandiera americana mossa dal vento, un po’ strappata alla base
– due piccole case vicine, una in legno naturale – un ripostiglio? – e l’altra dipinta di bianco; quella bianca ha una tendina azzurra dietro la porta che sta centro di due finestre. La finestra di sinistra è chiusa con un pannello d legno, in quella di destra ricordo che ci avevo guardato dentro
– ancora vapore che sale dall’acqua di una palude del Maine
– una marina con scogli che escono da un acqua che ha lo stesso colore del cielo
Sempre stamattina ripensavo a un progetto di arte ambientale che realizzai insieme a Ettore Favini nel 2012 e che titolammo W18S. Era la trasposizione in pietra dei 18 capitoli che compongo Walden – Vita nei boschi, libro che sia Ettore che io abbiamo tenuto per molto tempo sui nostri comodini.
Avevamo fatto incidere da un abile scalpellino toscano tutti i titoli dei capitoli del diario di Thoreau su lastre di diverse pietre e poi disseminato ogni lastra in un bosco su una collina all’interno della Tenuta dello Scompiglio, vicino a Lucca. Ettore aveva disegnato una mappa con le 18 posizioni delle lastre dentro il bosco, così che ci si potesse orientare in un percorso e sostare davanti al titolo di ogni capitolo del libro.
CAPITOLO I: ECONOMIA / CAPITOLO II: DOVE VIVEVO E PERCHÉ / CAPITOLO III: LA LETTURA / CAPITOLO IV: SUONI / CAPITOLO V: SOLITUDINE / CAPITOLO VI: VISITATORI / CAPIToLO VII: IL CAMPO DI FAGIOLI / CAPITOLO VIII: IL VILLAGGIO / CAPITOLO IX: I LAGHI / CAPITOLO X: BAKER FARM / CAPITOLO XI: LEGGI PIU’ ALTE / CAPITOLO XII: VIVINI BRUTI / CAPITOLO XIII: IL RISCALDAMENTO DELLA CASA / CAPITOLO XIV: ANTICHI ABITATORI – VISITATORI INVERNALI / CAPITOLO XV: ANIMALI INVERNALI / CAPITOLO XVI: IL LAGO D’INVERNO / CAPITOLO XVII: PRIMAVERA / CAPITOLO XVIII: CONCLUSIONE
Questo progetto ambientale mi ricorda il tuo primo libro, pubblicato con Skinnerboox nel 2014, che hai titolato THOREAU. Ricordo che la copertina era di cartone naturale rigido e il titolo era fatto con un timbro. Mi piaceva molto. Me ne avevi promesso una copia anni fa, ma alla fine non l’ho mai vista. Rendo pubblica questa cosa al Giro del Giorno, così forse ti deciderai a porre rimedio!
Tra le tue fotografie di montagne, tubi che escono dal terreno e una baita di legno, a un certo punto si vede una persona di spalle con un K-Way giallo, forse dentro un bosco, non ricordo.
“Le qualità migliori della natura umana, come i fiori in boccio, si possono conservare solo avendone la massima cura”. Henry David Thoreau
Chi era quella persona di spalle?
Antonio
.

Viaggio in Massachusetts e Maine con una macchina rossa, estate 2005.
.

.

Antonio Rovaldi con Ettore Favini, W182, installazione ambientale all’interno della Tenuta dello Scompiglio, 18 lastre di pietra disseminate dentro un bosco, Lucca 2012.
.

Alessandro Calabrese, Throreau, Skinnerboox, 2014
_______________________________________________________________________________________________
Antonio,
eccomi qui, assieme al mio proverbiale ritardo, in realtà non ne sono sicuro però ormai lo do sempre per scontato, soprattutto se mi relaziono a te.
Inizio rispondendo subito alla domanda finale di questa tua lettera, agganciandomi, un po’ malinconicamente, alle parole di Thoreau che hai riportato poco sopra: mi chiedi chi fosse quella persona di spalle avvolta in un k-way all’interno di un bosco, beh è qualcuno (che tu conosci) del quale purtroppo non ho avuto la massima cura, sentimentalmente parlando.
Da una parte questa cosa mi fa pensare a un video che ho visto qualche anno fa e non ho più ritrovato (nonostante non abbia ancora smesso di cercarlo): un’intervista a Giovanni Lindo Ferretti nella quale gli si chiede cosa ne pensi della fine di un amore e lui – semplifico quanto ricordo – risponde fondamentalmente che c’è una sorta di energia positiva che si sprigiona da un tale evento e che se ne deve approfittare. Dall’altra non posso non ricordare David Foster Wallace che, nel celebre discorso per la cerimonia delle lauree al Kenyon College, scrive che bisogna saper tenere alle persone, sacrificarsi per loro, in una miriade di modi anche “unsexy” (uso la versione originale inglese perché la traduzione italiana non rende giustizia). Credo che sia tutto là il segreto, semplice da tramandare, difficile da realizzare, non solo in un contesto amoroso. Fatalità, sia GLF che DFW hanno in comune tra loro, e con Henry David Thoreau, una spiccata tendenza all’eremitaggio, tratto che affascina me quanto te, nonostante io veda te come un eremita migratore, io molto più stanziale e dalla scarsissima indole esplorativa, soprattutto se devo inerpicarmi tra la natura selvaggia! Infatti il libro al quale fai riferimento (Thoreau, Skinnerboox, 2014) nasce dalla mia seconda e ultima esperienza della mia vita in un contesto, per così dire, montano, ovvero una residenza d’artista di dieci intensi giorni all’interno del Parco del Mont Avic, in Valle d’Aosta, nell’estate del 2012.
La prima esperienza risale invece ai tempi dell’università, qualche anno prima, quando con il professore di Ecologia (Architettura del Paesaggio presso lo IUAV di Venezia), Virginio Bettini, io e i miei compagni abbiamo percorso un tratto di Via Francigena, da Losanna a Ivrea, valicando dalle parti di Colle del San Bernardo se non ricordo male, insomma una gran bella camminata.
Ogni mattina, prima di metterci in marcia, il professore ci leggeva un passo tratto proprio da Walden – Vita nei boschi, facendolo così volare immediatamente tra i grandi classici della mia piccola libreria privata e al tempo stesso cambiando per sempre il mio modo di pensare a me stesso, paradossalmente, come cittadino. “Per quanti uomini la lettura d’un libro è stata l’inizio d’una nuova era nella loro vita!” (Capitolo III: La lettura).
Tornando al mio libro, al suo interno si possono trovare solo fotografie a pellicola realizzate con la mia Pentax 67, tutte volte a raccontare il parco nella maniera più semplice possibile, alternando immagini di una natura molto selvaggia a quelle di una natura corrotta, per forza di cose, dalla presenza dell’uomo. Al tempo quel che mi interessava era la fotografia nuda e cruda, la sua composizione, o forse la sua scomposizione. Arrivavo dagli insegnamenti di Guido Guidi (altro eremita) e riguardare quella immagini oggi le trovo ancora ‘troppo belle’, come avrebbe poi detto in senso costruttivo (ma quanto ci rimasi male!) un’altra figura di riferimento per me, Vincenzo Castella. Ripensando a questo progetto, che si è poi rivelato essere il mio unico progetto puramente fotografico, quel che mi piace ricordare è ciò che accade a metà libro. Avevo deciso, un po’ istintivamente, di inserire un’immagine scaricata dal web e realizzata da una webcam, posta all’interno del parco e rivolta verso il picco del monte, durante l’anno in cui ho realizzato il progetto di residenza. Quel che si vede è il Mont Avic in una bellissima giornata serena, in sovrimpressione la data 21/12/2012 (come ricorderai, la data della presunta fine del mondo secondo la profezia dei Maya).
Il mio intento era quello di omaggiare Luigi Ghirri e una sua fotografia realizzata a Rimini nel 1977 per la serie “In Scala”.
Porta sempre a un leggero brivido fanciullesco lasciare indizi qua e là all’interno di un progetto, rivolti in realtà a se stessi con la speranza che qualcun altro li colga.
Non conoscevo, o forse ricordavo, il tuo lavoro su Thoreau con Ettore, meraviglioso, siete più tornati a cercare e fotografare le lastre? Mi viene in mente quella volta che ci siamo messi in testa di andare a visitare la casa di Thomas Bernhard, tra l’altro dovremmo aggiungerlo alla lista delle promesse delle cose da fare.
A tal proposito, qui la tua copia numera delle sole tre copie di Thoreau rimaste in mio possesso.
Un forte abbraccio da Milano Sud, più vicino all’Emilia che alla Brianza. A
Alessandro
.

Alessandro Calabrese, Thoreau, Skinnerboox, 2014
.

Alessandro Calabrese, Thoreau, Skinnerboox, 2014
.
 Luigi Ghirri, Rimini (in scala), 1977, © Eredi Luigi Ghirri
Luigi Ghirri, Rimini (in scala), 1977, © Eredi Luigi Ghirri
.

.

Fabrizio De Andrè, Rimini, cassetta arancione fotografata da Antonio il 23 maggio 2020.
CAPITOLO 26: THREE DAYS OF THE CONDOR
Luigi Fiano, fotografo, e Antonio Rovaldi, Milano, Italia
Ciao Antonio,
ecco il mio contributo per Il giro del giorno. Camminare, osservare, ricercare, perdersi, lasciarsi sorprendere. Tutte azioni che mettiamo in campo quando tentiamo di definire una geografia nella quale ci muoviamo, di comprendere in che relazione ci poniamo con un luogo.
Come sai, mi capita spesso di viaggiare. Per lavoro, negli ultimi due anni, ho toccato quattro continenti. Con alcuni luoghi ho sentito, a volte, un senso di prossimità inaspettato. In altri, pochissimi, in cui ritorno periodicamente, questa prossimità diventa totale aderenza. Non riuscirei a trovare una parola più giusta per descrivere quest’alchimia, che è più di un semplice riconoscersi in un luogo. È un sentirsi completato da esso, dalle sue strade, dai suoi palazzi, dalla sua orografia, dal cibo, dai suoni, dalle persone che lo abitano.
Basta questa sensazione a identificare un luogo come casa? Troppo facile mi dico a malincuore. Troppo facile, mi ripetono gli amici. Troppi gli elementi di novità e desiderio di scoperta che influenzano questo sentire. D’altro canto, dopo quindici anni vissuti a Milano, città che amo e a cui sono profondamente legato, mi ritrovo, ancora, a non riuscire a chiamarla con quella magica parola di quattro lettere, “casa” per l’appunto, nonostante coltivi in essa legami profondi. Pertanto, questo gennaio, rientrato dalle vacanze natalizie e dopo un anno alquanto rocambolesco, ho deciso di fare qualcosa che rimandavo da molto tempo: rimettermi (o forse mettermi per la prima volta) in ascolto con il luogo in cui vivo da tempo, allo scopo di trovare quell’aderenza di cui parlavo o, in caso contrario, decidermi a cercarla altrove.
Così, con occhi nuovi, ho ricominciato a camminare, osservare, ricercare, perdermi e lasciarmi sorprendere. L’ho fatto finché è stato possibile, prima che questa pandemia imponesse una pausa, riducendo il concetto di “casa” a qualcosa di estremamente circoscritto e materiale. Ho ripreso appena ci è stato permesso uscire nuovamente, immerso in un’irresistibile primavera ormai inoltrata. Le immagini che invio sono il primo, esile, risultato di questa ricerca, di questa camminata verso casa.
Un caro abbraccio.
A prestissimo,
Luigi
.

.

.

.

.

.

.

.

Foto di Luigi Fiano
_______________________________________________________________________________________________
Milano • 24 maggio 2020. domenica
Luigi,
grazie per le tue fotografie e parole che mi arrivano in tutta la loro essenzialità e urgenza. Quando parli di riscoperta della nostra città, Milano, partendo da brevi camminate senza una meta precisa, ti capisco bene e forse una volta ne avevamo anche parlato, quando l’anno scorso Lucia Tozzi ci aveva chiesto delle immagini per la pubblicazione cartacea di ZERO, dedicata al verde urbano dentro e fuori Milano. Tu avevi fotografato i giardini interni di palazzi milanesi e io un grande gatto – molto rosso e molto vanitoso – in mezzo a un cespuglio alla fine Martesana.
Viviamo a Milano ma vorremmo sempre essere altrove. Questa irrequietezza ci caratterizza entrambi e infatti credo trapeli anche nelle nostre fotografie e, più in generale, nel modo di guardare le cose.
Da quando sono tornato in pianta più stabile a Milano, dopo i miei numerosi pellegrinaggi oltreoceano, anch’io ho avvertito la tua stessa urgenza di riscoprire la città, anche se ora sento il bisogno di cominciare a distanza questa riappropriazione geografica dei luoghi. Ho iniziato timidamente a camminare le montagne lombarde – che conosco poco – e questo ultimo giovedì insieme a Gaia e Tommaso, abbiamo quasi raggiunto la vetta del Resegone. Una montagna un po’ greve, spelacchiata, poco rassicurante. Non mi è piaciuta.
Per fortuna alla fine non sei venuto con noi perché ci siamo ammazzati di fatica.
Mi hai detto che avevi appena ritirato gli sviluppi dei negativi in bianco e nero e che preferivi concentrarti su Il giro del giorno. Grazie ancora per la tua camminata silenziosa e con un bianco e nero così luminoso!
La prima fotografia che introduce la tua bellissima sequenza in bianco e nero, le foglie alzate da un colpo di vento, mi ha ricordato una scena del film I tre giorni del Condor (Three Days of the Condor), un capolavoro del cinema di spionaggio girato da Sidney Pollack nel 1976 con un Robert Redford mozzafiato e un’algida e bellissima Faye Dunaway.
Il film è girato a Manhattan ed evoca la New York degli anni ’70 – sconvolta dallo scandalo Watergate e dalla sconfitta del Vietnam – avvolta in un cielo plumbeo invernale.
C’è una scena del film in cui Redford, dentro la casa di lei (stravolto dalla stanchezza e dai pensieri), si sofferma su alcune fotografie in bianco e nero attaccate alla parete con gli spilli sopra il televisore:
Turner: “Tutte molto tristi”
Kathy: “Trova?”
Turner: “Com’è strana… Non fotografa altro che viali deserti e alberi senza foglie”
Kathy: “È l’inverno”
Turner: Concordo”
Kathy: “Grazie…”
(47’40”)
…si guardano ancora con sospetto – stanchi e soli entrambi – e per un attimo si innamorano. Sullo sfondo una New York che si riconosce appena, grigia umida e lontana…
A presto,
Antonio
.

Luigi Fiano, Milano – Il Giardino e la Città, fotografia pubblicata sul numero cartaceo di ZERO Milano, in occasione della XXII Triennale di Milano – Broken Nature, a cura di Paola Antonelli. Numero curato da Lucia Tozzi. 2019.
.

Antonio Rovaldi, A Milano camminando lungo la Martesana la domenica mattina si vedono gli animali. Fotografia pubblicata sul numero cartaceo di ZERO Milano, in occasione della XXII Triennale di Milano – Broken Nature, a cura di Paola Antonelli. Numero curato da Lucia Tozzi. 2019.
.

Immagini dal film Three Days of the Condor, di Sidney Pollack, 47’40”, 1976.
.

Robert Redford nel film Three Days of the Condor, di Sidney Pollack, 1’27”, 1976.
CAPITOLO 27: UNA SIRENA VERDE
Claudia Durastanti, scrittrice e traduttrice, Roma – New York City, Italia – USA
Roma • 25 maggio 2020
Caro Antonio,
c’è un libro di cui ti ho parlato la prima volta che ci siamo visti in un bar di Milano.
Non so se alla fine lo hai mai letto. Si chiama Counternarratives di John R. Keene. Tu mi raccontavi delle passeggiate che c’erano state, mi parlavi di frontiera interna, dell’inizio e della fine di una città. E io intanto pensavo a un racconto di quel libro che si chiama Manhattan in cui un uomo di nome Rodrigues vede quella che diventerà New York per la prima volta. Vede una croce fatta di rametti dalla sua barca che si allontana, mentre tutto sparisce in un nascondiglio incolto e verde; non ci tornerà mai più.
Nei mesi scorsi ho pensato molto al verde, perché quando sono davvero tornata a Brooklyn per abitarci dopo 29 anni di lontananza, convinta che sarei stata pronta e che sarei tornata da donna motherless e sofisticata, stavo finendo di tradurre il Grande Gatsby per una nuova edizione italiana. Non pensavo alla luce verde del molo, quella che porta Gatsby a Daisy e viceversa, ma al verde delle pagine finali, in cui Nick Carraway contempla gli stabilimenti chiusi dalla spiaggia, e l’isola gli appare come «il seno verde e immacolato di un nuovo mondo», fatta di alberi sradicati che un tempo avevano assecondato i più maestosi e definitivi dei sogni umani. Sarà che stavo leggendo The Overstory di Richard Powers in quei giorni (a voler essere onesta lo sto leggendo ormai da un anno, e mai finisce. Tu a che punto sei?), questa specie di Moby Dick del mondo vegetale e delle spore, ma NY non mi è mai apparsa così legata e tenuta insieme dai suoi alberi, e così ne ho fotografati tanti, in una specie di radiografia molto provvisoria e difettata dalla luce che nessuno userà per una diagnosi.
Questo slancio, credo, è una specie di salmo che ho imparato da te, osservando il tuo lavoro.
Non è stato un verde quieto. La mia recente esplorazione della città è stata sporca e chiassosa, fatta solo di sirene. Le ambulanze a tutte le ore del giorno e della notte; il NYT ha fatto un pezzo sul soundscape smarrito di NY, su tutti i suoni che sono mancati durante la quarantena, ma per me è come se si fossero sciolti e disintegrati in una sola nota allarmata e costante, che ha tenuto la città insieme proprio come fanno le radici di quegli alberi: lo spazio innervato da un senso di appartenenza e di pericolo, di minaccia riverberata con un che di triste e sacro.
Qualche anno fa ho visto una mostra del gruppo di lavoro di Forensic Architecture all’ICA di Londra. Tra le pratiche di ricerca artistica e di attivismo politico che mi hanno colpito di più, c’era la ricostruzione di una prigione siriana grazie alle testimonianze acustiche dei detenuti, le reminiscenze dei suoni e dei passi delle guardie da parte di stava bendato al suo interno. Un luogo che ufficialmente non esisteva sulla mappa, riportato in superficie grazie alla memoria del suono. Per me, per la mia storia, il suono non è mai bastato; è sempre stato un testimone affascinante ma poco affidabile del tempo, un bugiardo cronico, un affabulatore. Non gli avrei mai messo in mano una città, la mia città, eppure temo che sia successo proprio questo nella mia vita recente, a dispetto della mia capacità di controllo e del mio tenere insieme i pezzi prima con le parole, e poi con le immagini: mi è rimasto un colore, ma se devo essere sincera, di quei giorni mi è rimasto soprattutto un suono. E poco importa se la parola «sirena» mi parla del mare quanto di un dispositivo che annuncia una frattura e forse anche una morte: adesso che sono lontana, mi pare sempre più ineluttabile e necessario che queste cose vadano insieme, dentro e fuori da nuove acque.
Claudia
.

May 8, 2017 / inside Spring Creek Park, 159th Ave and 78th St. Antonio Rovaldi, fotografia alla pagina 274 del libro The Sound of The Woodpecker Bill: New York City, Humboldt Books 2019
CAPITOLO 28: SU UNA LEZIONE
Azalea Seratoni, Critica d’arte, Milano, Italia
Mercoledì 15 aprile 2020, al corso di Documentazione fotografica di Linda Fregni Nagler all’Accademia di Belle Arti di Brera.
.

Cari Linda e Antonio,
stavo quasi per scrivervi appena dopo la lezione ma ero in uno stato di irrequietezza, una sorta di veemenza mentale, che ho preferito andare a tagliare il prato; l’erba era alta, non la tagliavo perché non osavo tagliare le margherite, formavano una macchia larga e soffice come la pancia del mio gatto.
Nel tempo della scrittura di questa mail l’erba è ormai ricresciuta, quasi come prima, e le margherite sembrano anche di più. Avevo scritto meglio gli appunti scarabocchiati su un foglio, questo sì, e alcune altre cose che mi erano arrivate in testa.
Ho sempre pensato che avrei voluto essere nell’aula del corso di Composizione Architettonica di Corrado Levi, una studentessa universitaria a Milano agli inizi degli anni Ottanta che scopre in cattedra, accanto al suo prof., di volta in volta una presenza diversa: Carol Rama, Schifano, Ontani, Giulia Niccolai, e poi Trini, Marisa Merz, Boetti, Carla Accardi, Moschino, Tony Cragg. L’ho pensato con una consapevolezza diversa di quella che uno studente ha quando è studente. L’ho pensato fino a quando, sullo schermo, mi siete apparsi voi, prima Linda e poi tu, Antonio. Non eravamo a scuola. Linda, come altri, sta sperimentando una diversa relazione pedagogica che non si può dire scuola, e quel giorno ha scelto una cosa per dirne tante altre, anche a me.
Sempre Corrado diceva che l’architettura si fa a partire da sé: il partire da sé di Linda è la complicità con Antonio e, più in generale, la particolare relazione che c’è tra gli artisti. La vostra relazione, che va al di là della vostra amicizia, si fa pedagogia, sapere trasmissibile proprio nel senso in cui Kandinsky e Klee al Bauhaus avevano trasformato la propria poetica in una oggettivazione e formulazione disciplinare, culminata nella scrittura di Punto, linea e superficie e di quell’autentico trattato che è il Pädagogidches Skizzenbuch di Klee. Ci è stata offerta la possibilità di assistere in tempo reale allo sforzo di trasformare una relazione personale in un sapere condivisibile.
Lo sapete come si prendono gli appunti: io avevo dei grandi fogli bianchi, li ho usati in verticale, li ho riempiti tutti, davanti e dietro, ho iniziato in alto a sinistra, scrivi una cosa qui e una cosa là e nel farsi del discorso copri la superficie, mettendo un concetto vicino a un altro, a formare una costellazione o, per usare un’altra parola all’interno dello stesso reticolo semantico che avrebbe potuto usare Antonio, una geografia.
Una geografia che si relaziona alla mano e al corpo; il corpo che si fa fotografia e viceversa. Come dicevi, Antonio, molto elegantemente, sulla differenza con i cieli di Ghirri.
Forse la traduzione in scrittura di questi appunti-scarabocchi avrà la stessa forma.
“Give yourself an assignment”, interviene Linda citando Christopher Williams, e io penso al mio corso di basic design che sugli assignments è basato: è una sequenza di esercitazioni, formulate per iscritto e strutturate in obiettivi, elementi, nonché regole e vincoli esecutivi, che possono essere viste come una simulazione di complessità ridotta di un brief progettuale. Anceschi aveva sperimentato negli anni Settanta all’ISIA di Roma “una formulazione molto spinta della prospettiva problem solving, un’esercitazione in cui regole e vincoli erano così rigidi da costringere il discente a imboccare la via della rottura e della ridefinizione di essi (problem setting) per poter pervenire a una soluzione. Proprio come nella prassi”. Proprio come nei tuoi viaggi, Antonio. Tradire il piano iniziale per una propria traduzione, come sto facendo io con questi appunti, come ha fatto Linda, ad esempio, con la mostra e il libro su Hercule Florence.
Ho scoperto solo di recente che anche John Baldessari alla CalArts lavorava così; penso che introdurrò uno dei suoi assignments nel prossimo semestre, se mai il corso inizierà.
Vi faccio una lista di alcune delle esercitazioni di Baldessari:
“One person copies or makes up random captions. Another person takes photos. Match photos to captions”. Forse introdurrò proprio questa all’inizio del corso o nella parte dedicata alla “narrazione per immagini”, mi fa pensare alle sculturine in terracruda di Fischli e Weiss, mostro sempre il loro video Der Lauf Der Dinge prima o dopo aver mostrato alcuni disegni di Munari dal suo libro Le Macchine di Munari.
Ecco le altre:
– Defenestrate objects. Photo them in mid-air.
– Photograph backs of things, underneaths of things, extreme foreshortenings, uncharacteristic views. Or trace them.
– Repaired or patched art. Recycled. Find something broken and discarded. Perhaps in a thrift store. Mend it.
– Create art from our procedures of learning. How does an infant learn?
– Cooking art. Invent recipes. They are organizations of parts, aren’t they? (Anche questa mi fa pensare ad altre cose, ancora Munari in Da cosa nasce cosa quando spiega il metodo progettuale e il fatto che cucinare sia “arranging things” che è un’altra parte del mio corso).
– What are the minute differences in things that are supposed to be the same? (Questa mi fa pensare a Linda).
– Describe the visual verbally and the verbal visually. (Questa, poi!)
E non so quanto sia diverso da “Cercare buchi tra le reti. Fotografare l’ultimo centimetro di natura” di Antonio. Scavalcare le reti fregandosene del “keep out” è desiderio di esplorare l’ignoto, ma è anche saper vedere. Anche le cose minime, minori. Come ha detto Albers ai suoi studenti del Black Mountain College. Balbettava ancora un bislacco inglese, veniva dalla Germania, dalla Germania nazista che aveva chiuso nel ’33 la scuola, li avevano invitati a insegnare, lui e la moglie Anni, come lui discente e docente. È stato un respiro e un nuovo inizio, sono sbarcati a New York per un fine settimana prima di andare in North Carolina, proprio in tempo – e che sincronia! – per vedere la mostra di Brancusi organizzata da Duchamp. Appena arrivato, uno studente gli ha chiesto: “Che cosa ci insegnerà? “To Open Eyes”.
Linda ancora interrompe, questa volta chiamando a colloquio Francis Alÿs: “Waiting for an accident to come” che è un caso ancora diverso da quello di Munari e dell’arte programmata che Eco approfondisce nell’Almanacco Letterario Bompiani 1962 e già si intuisce nel titolo La forma del disordine? Vediamo un poco: “C’è un romanticismo del Caso. Si sprizzano follemente tubetti di colore sulla tela stesa in terra, si picchia con un martello sul pianoforte: il Caso disegna le sue figure e il pittore le coglie e le riconosce per sue, il Caso orchestra i suoi rumori e il musicista li accoglie nella sua gamma priva di pregiudizi. Ma in verità, quanto più è artista, tanto più chiede aiuto al Caso ma infine lo addomestica, lo dirige, lo sollecita ma lo sceglie, lo accetta ma ne rifiuta una parte, non fa a caso le sue forme ma dà delle forme al Caso. Ma se così fa il romanticismo del Caso, l’espressionismo astratto, la pittura di azione, il neo-dada musicale, si potrà tuttavia afferrare il Caso anche dal lato opposto: prevederlo, programmarlo, non sceglierlo una volta accaduto, ma farlo accadere secondo le regole imprescindibili della probabilità statistica, in cui il massimo di casualità coincide col massimo di prevedibilità.
È questa una seconda stagione delle nozze tra l’arte e il Caso, e potremmo vederne le manifestazioni in varie arti, se le proposte che ci fanno in queste immagini un gruppo di pittori (pittori? o programmatori? pianificatori di forme?) non ci inducessero a un discorso più circostanziato, che dai loro esercizi prenda lo spunto per azzardare ipotesi che peraltro li superano. Costoro, come si vede, assumono dunque per lo più una conformazione geometrica di base e la sottopongono a rotazioni e permutazioni (così come avviene per certe serie musicali) programmandone tutte le variazioni necessarie e allineandole tutte senza discriminazione. Risultato: non una forma, ma la pellicola di una forma in movimento o la scelta complementare tra varie forme […] L’opera non consiste nell’elemento meglio riuscito, scelto tra tutti gli altri, ma proprio nella compresenza di tutti gli elementi pensabili”.
Non è certo un caso che Antonio sia andato a NYC. Linda ha parlato di caparbietà, di una necessità, forse c’è da chiedersi se l’urgenza sia la stessa dei land artisti o in che cosa sia diversa. Ma in fondo la geologia del paesaggio americano Antonio l’ha trovata a Central Park e quel vuoto, che è stato così importante anche per Morton Feldmann e John Cage, negli empty blocks.
Il lavoro sul waterfront di NYC e Orizzonte in Italia riverberano, si parlano, confrontandosi coraggiosamente con l’ovvio. Linda ha detto che i tuoi lavori si riconoscono, condivido che si possa parlare di poetica.
E poi ci siamo divertiti a giocare con la storia dell’arte quando hai mostrato il Bennet Field Airport. Scriviamo su whatsapp, proprio come gli studenti, anche con Marta, l’assistente di Linda, durante le lezioni. Linda e Marta hanno pensato a Orozco, io all’Automobile Tire Print di Rauschenberg che è una linea come quella di Manzoni, che è tempo congelato nel concetto.
Minuscola deviazione perché prima ho citato Anceschi e stiamo parlando di tempo. Abbiamo preparato per lui un libro per i suoi ottant’anni, li ha compiuti l’anno scorso a settembre, ognuno ha scritto una cosa secondo l’alfabeto, io avevo più di una lettera tra cui la T di Tempo: “Ho consumato tre fazzoletti di carta Tempo nel tempo della scrittura di questo testo. Confesso che non ero a mio agio a parlare del tempo, si fa solo quando non si sa cosa dire. E invece di cose ce ne sono e ho impiegato del tempo a scegliere bene qui e là, nello spazio-tempo, quel che volevo. Perché si tratta di una persona che al tempo ci ha pensato a suo tempo e l’ha agito nell’arte (Tavole di possibilità liquide, Quadri clessidra, Percorsi fluidi, Strutturazioni cilindriche virtuali, Ambienti a shock luminosi), nel design (registica), nella scrittura, nell’insegnamento (il basic design è una disciplina che al tempo si adatta) e con il corpo (ballerino). Da tempo si era determinata la necessità di considerare il tempo come dimensione. Con altri tre ragazzi che aveva incontrato ai tempi dell’Università parlava del divenire di Bergson e, testardamente, della temporalità di Husserl e di inserire nelle opere la nozione di tempo e aveva fatto un gruppo che si chiamava T dove la T sta proprio per Tempo.
La storia può essere pensata come una forma molto sofisticata di tassonomia, in cui gli esemplari, gli items, i dati e forse i fatti, si dispongono lungo una time table o una cronologia o un percorso genetico o evolutivo e che comunque si appoggiano sulla dimensione temporale (l’ha scritto lui in Protagonismo del tempo).
Ecco come guardare alla prima mostra Miriorama 1. Gli artisti del gruppo T si sono posti in una sorta di genealogia della tematica temporale nell’arte. Hanno scelto opere e autori che parlavano – con loro e prima di loro – del tempo gestuale dell’esecuzione (Concetto spaziale di Fontana), del tempo in modificazione meccanica (Meta-Malevich di Tinguely), del tempo dell’interazione dello spettatore (Specchio rotto di Baj), del tempo congelato nel concetto (Linea di Manzoni), del tempo degli spazi in variazione (Macchina inutile di Munari). Tempus divitiae meae, tempus ager meus (Goethe, Divano occidentale-orientale). A poco a poco stavamo entrando in argomento ma non c’è più tempo”.
Vi va di leggere anche la M di Munari? Se no saltate ventitré righe circa: “Ma come si fa, come faccio – io – a scrivere su Munari, pensando ad Anceschi, quando è da circa quindici anni che voglio scrivere un libro su Munari e, su Anceschi, ho scritto solo un saggio di recente. Li conosco entrambi dal 2003, in forme diverse: Munari da un poco prima, ed è grazie a lui che ho conosciuto Anceschi. E poi, come si fa, dopo i ritratti capolavoro che Anceschi ha fatto di Colombo, Devecchi e Munari, dopo le esatte estesie, le brachiestesie, la lingua degli specchi e Perelà, ma lupu ulula, lupu ululà. Là. Cosa? Lupo ululà e castello ululì. Ma come diavolo parli. È lei che ha cominciato. No, non è vero. Non insisto, è lei il padrone. Beh, ecculullà. Caasa.
Ma in fondo con loro, appunto, mi sento a casa. Forse è, per questo, che non riesco a scriverne, c’è troppo poca distanza, parlare di loro significa troppo parlare anche di me. Come per Anceschi scrivere di Boriani.
E infatti, quando l’ha fatto, ha capito che doveva scegliere la forma della lettera “non solo perché amo moltissimo il genere epistolare (Jean Jacques Rousseau, J. W. Goethe, ma soprattutto Choderlos de Laclos e Bram Stocker), ma propriamente e specificamente perché questa forma è quella che per principio mette in scena una relazione. Hai presente il ‘monologo interiore’ della nostra adorata Molly dell’Ulisse di James Joyce? Mi viene da dire che quello che fluisce, che va avanti e indietro fra noi è una sorta di continuo ‘dialogo interiore’: io penso di continuo ‘Che cosa direbbe Davide di questo? E di questo?’. La forma epistolare riflette il nostro continuato, ininterrotto sostanzioso e a volte profondo dialogo come riflette anche la nostra rizomatica e sbrodolante chiacchiera, su tutto e contro tutti. Dialogo e conversazione fatti di segrete confabulazioni, di reciproche affabulazioni, ma anche di tremendi scazzi e di grotteschi sghignazzi”.
Ecco, appunto, vedete? Come si fa? L’ha fatto già lui. Quando qualcuno dice: “questo lo so fare anch’io”, vuol dire che lo sa rifare, altrimenti lo avrebbe fatto già fatto prima (Munari, Verbale Scritto). E poi si assomigliano, Munari e Anceschi, pur se diversissimi, complessi e ramificati come l’albero che ha disegnato Munari e Leonardo prima di lui, un nugolo di saperi, di pratiche, d’invenzioni variegati e incantevoli come di lucciole o di formiche.
Insomma… ci stavamo divertendo con la storia dell’arte… tu, Antonio, poi, hai mostrato Michel Heizer e Linda, ricombinando la trama del suo corso, ha parlato ancora degli engrammi di Warburg, perché – stavamo quasi scordandoci di dirlo – c’è anche un tempo interiore per le immagini e la linea può essere anche quella della storia dell’arte e della storia. E poi Klee inizia gli Schizzi pedagogici citati sopra proprio con una linea sotto cui scrive, cito in inglese l’edizione tradotta e introdotta da Sibyl Moholy Nagy anche se Linda potrebbe godersi il tedesco: “An active line on a walk, moving freely, without goal. A walk for a walk’s sake. The mobility agent, is a point, shifting its position forward”.
Quella di Klee è una linea che si aggira oziosa, è quella di un disegno di Steinberg che senz’altro conosci Antonio e in cui forse ti riconosci, la meta non si dà da A a B, non è una ripetizione di una cosa fissata su una economia di tragitto, ma è continua invenzione di percorsi diversi. È c’è una differenza tra il camminare con un disegno e il camminare per il camminare.
Ci hai detto di aver pensato ai luoghi interstiziali di cui parla Gilles Clement, a quei margini che sono possibilità di rinascita. Io ho pensato, ancora con Anceschi, che vale anche per le discipline: “Non si constata solo la perdita dei confini netti fra le discipline, ma anche che tutto si svolge negli interstizi e nelle sovrapposizioni fra le discipline. E che tutto il mondo ormai è ipermoderno, o surmoderno. Non è nella specializzazione, ma è là dove le discipline sfumano l’una nell’altra che scaturiscono le novità e si ridefiniscono le pratiche, la ricerca e la formazione”.
E attribuisci a te stesso, dicendo che sei un artista non fotografo, questo movimento ondivago, posso dire anche di me stessa di avere più disposizione per il “varius multiplex multiformis” (Yourcenar, Memorie di Adriano).
Il prato si taglia dritto, avanti e indietro, striscia dopo striscia – almeno io ho visto fare così e ho imparato –, uso un tagliaerba che raccoglie in una cesta attaccata alla macchina quella tagliata e ogni tanto si svuota, dopo quattro o cinque strisce, a seconda della condizione dell’erba, più è alta, più svuoti, portando a spalla la cesta, talvolta alleggerisco il peso appoggiandola alla carriola. Questi ciuffi sminuzzati sono meglio dei coriandoli, soprattutto profumano di erba tagliata. In giardino vanno ad accumularsi a quella che ormai è una collina, addossata alla stanza degli attrezzi, di rami, foglie secche, qualche verme, lì sotto abbiamo seppellito uno dei nostri cani, un altro è vicino al faggio, forse si ribelleranno come in Pet Sematary.
Quel pomeriggio, ero alla sesta o settima striscia, non ho resistito, ho deviato e poi ancora (v. allegato, poi ho tagliato tutto dritto!). Il giardiniere è per me quel goffo vestirsi di un’altra professione di cui avete parlato – è stato il passaggio di maggior complicità tra voi – quando Antonio ha ricordato Giro di campo e si era prima detto del Tentativo di far formare dei quadrati invece che dei cerchi intorno a un sasso che cade nell’acqua di De Dominicis e c’è anche il suo Tentativo di volo. Mi piacerebbe andare avanti a parlare con voi di fallimento, sarebbe utile per una cosa che sto tentando di scrivere…
Ciao,
Azalea
.

Richard Long, A Line Made by Walking, 1967
Capitolo 29: [ THINGS THAT DEATH CANNOT DESTROY ]
Linda Fregni Nagler, artista, Milano, Italia
Introduction
«This volume introduces a selection of images from an artists’ collection of magic lantern glass slides. They were carefully gathered over the years, and joined into a rich archive devided into personal and arbitrary cathegories. The photographs, shot between 1860 and 1920, have different geographical origins and have been conceived for different purposes: didactic, familiar, documentary… Some of them report exhaustive captions, with date, place and copyright, and sometimes they even carry personal writings of the photographer, the printer or the owner of the slide, whereas others lack completely of information.
In the book, every page will show both the transparent (glass) and the opaque (paper or fabric) surface of the image, thus showing also what is normally hidden when the slide is projected: the frame contaninig captions, codes, various informations. The aim is to show the beauty of the image as object, with its thickness, cracks, imperfections, colored and modified frames. A short text will accompany the image, explaining what is shown in the photograph. The explanation should be not taken for granted: in some cases the subjects are very legible, but it is hard to nd explanations if the image does not carry a caption. In these cases, the text will be surreal, personal and fictional.
Moreover, the images will be associated by form, and not by content, making it impossible to trace a rational classification or order for the images within the volume. Through the union between image and text and the stream of uncanny pairing of photographic subjects, the different pages of the book will suggest various interpretative keys: manuals of science and anthropology, historical documentary reports, surreal, ctitious and sometimes even comical tales. Every photograph, though belonging to very different contexts, will be fed by the former one, the visual path developping into a sort of cadavre exquis. The distance of time and cultural interpretation codes, together with the visual arrangement of the images’ choreography, raises issues about staging the human gure, social categorization, censorship and copyright. In this personal and ambiguous encyclopedia, what is legible is not History, but glance on many pieces of a mosaic that may be combined with infinite variations.»
.

Left
[ ARCH-027-ML ]
99173 Fuller, Richard Buckminster, 1895-1983 Dymaxion House: model. 1927
Art. Dept. Smith College
Conceived and designed in the late 1920’s but not actually built until 1945, the Dymaxion House was Fuller’s solution to the need for a mass-produced, affordable, easily transportable and environmentally efficient house. The word “Dymaxion” was coined by combining parts of three of Bucky’s favorite words: DY (dynamic), MAX (maximum), and ION (tension). The house used tension suspension from a central column or mast, sold for the price of a Cadillac, and could be shipped worldwide in its own metal tube. Toward the end of WW II, Fuller attempted to create a new industry for mass-producing Dymaxion Houses. Bucky designed a home that was heated and cooled by natural means, that made its own power, was earthquake and stormproof, and made of permanent, engineered materials that required no periodic painting, reroofing, or other maintenance. You could easily change the floor plan as required – squeezing the bedrooms to make the living room bigger for a party, for instance. Downdraft ventilation drew dust to the baseboards and through filters, greatly reducing the need to vacuum and dust. O-Vol- ving Shelves required no bending; rotating closets brought the clothes to you. The Dymaxion House was to be leased, or priced like an automobile, to be paid off in five years. All this would be possible now if houses were engineered, mass-produced, and sold like cars. $40,000.00 sounds about right.
In 1946, Bucky actually built a later design of the Dymaxion House (also known as the Wichita House). I had the honor to lead a bunch of volunteers that took it apart in 1992. It was mostly intact despite being abandoned (except for the incumbent herd of insolent, filthy raccoons) for several decades. The 747 First-Class ambiance was faded and smelly, but you could still sense the elegance of a living room with a 33-foot window. The Dymaxion’s round shape minimized heat loss and the amount of materials needed, while bestowing the strength to successfully fend off a 1964 tornado that missed by only a few hundred yards. And the Dymaxion only weighs about 3000 pounds (1,36 tons) versus the 150 tons of an average home!”
J. Baldwin, 30 year associate of Buckminster Fuller.
Abstract from J. Baldwin, Bucky Works, Buckminster Fuller’s Ideas for Today, Wiley.
Right
[ OGGMES-081-ML ]
Fo Y 96 Negative no. 72/12 Australia. Pile of Pearls Valued at $40,000. Broome, Western Australia (1919) , New York State Education Department, Visual Instruction Division.
On the northwestern tip of Australia, Broome is 1,800km from the nearest city, Darwin. The town was founded in 1883 and named after the then-state governor, Sir Frederick Napier Broome. One of the most fascinating of all Australian towns, its history began in the 1870s, when it was discovered that the waters around the town were home to the Pinctada maxima – the world’s largest pearl oyster. At first it was the shells that were thought valuable – the mother of pearl was used to make buttons and cutlery and jewellery that would be exported to New York and London – and the oysters were collected by divers who sailed in and out on pearling luggers.
Around the turn of the 20th century, 80% of the world’s finest pearls came from here – and the trade didn’t just transform the town’s fortunes but also its population. Pregnant Aboriginal women were believed to make the best divers, as it was thought they had greater lung capacity.
When blackbirding was outlawed, Broome was faced with the challenge of finding others to do the dangerous work of diving for pearls. In 1901 the Australian government passed the Immigration Restriction Act – which limited the numbers of non-whites coming into the country – but Broome was given a special exemption and immigrants arrived from China, Japan, Malaysia and elsewhere to work as pearl divers and settle in the town. The legacy of that immigration and early multiculturalism is everywhere in Broome: the town centre is called Chinatown.
.

Left
[ ASTR-073-ML ]
22 Astronomy
Photography had become successful and popular by the mid-19th century both professionally and amongst “gentleman scientists” looking to add to and make their mark on popular knowledge. James Nasmyth was such a man: he showed an early competency for mechanics, set up his own foundry, designed and patented the steam hammer and other machines and retired at the age of 48 to Kent to pursue his hobby of astronomy.
Once retired Nasmyth, as an industrial gentleman of the steam age, built his own 20-inch reflecting telescope (now on display at the Science Museum in London) and joined the ranks of Democritus, da Vinci, Galileo and Johannes Hevelius as an amateur selenographer. Thus he embarked on a series of lunar observations which finally culminated in the 1874 publication of a work by him and James Carpenter entitled The moon: considered as a planet, a world, and a satellite (London, John Murray).
This work was advertised as including “twenty-four illustrative plates of lunar objects” and was significant as it was one of the first books to feature photographs of the Moon’s surface, or so it seems! Astrophotography had its beginnings in the 1840s but by the 1870s there was no photographic process in place to capture the details of the lunar surface that Nasmyth and Carpenter were observing. So this pair of enterprising gentlemen set forth and built a series of plaster models based on their observations, lit them with raking light and produced photographic illustrations for their book. In fact, in the whole of their book there is only one photograph of the actual Moon, which was taken by Warren De la Rue (Plate III of the first edition, right). The illustrative plates of this first edition of The moon employ multiple different types of illustrative and early photographic reproduction techniques: engravings, woodburytypes and heliotypes (a type of collotype). These new photo-mechanical printing techniques allowed a more standard print process using permanent carbon-based inks and stream-lined the production of photographically illustrated books. This process truly underlines photography’s basic characteristic of being a construct (in this instance twice over!) and very much an act of interpretation which can sometimes be far from the truth.
Right
[ PERS-029-ML ]
12 – 12 / 192 My old man
“My anecdote, then, is drawn from the annals of the early sixties art world, a world just about to be swept up into the hyperspace of minimalism and pop art. It is a story that was told me by a critic – Michael Fried – about an artist – Frank Stella. It starts with a question. “Do you know who Frank thinks is the greatest living American?” Michael asked me one day. And then, grinning with pride at the sheer brilliance of the answer, he said it was Ted Williams, the amazing hitter for the Red Sox. “He sees faster than any living human,” Michael said. “His vision is so fast that he can see the stitching on the baseball as it comes over the plate. Ninety miles an hour, but he sees the stitches. So he hits the ball right out of the park. That’s why Frank thinks he’s a genius.” I remember the urgency in Michael’s voice as his tone was divided by total hilarity at the image and utter seriousness about its import. But it was the early 1960s and I was in the grip of a certain view of modernism and so its import did not escape me either. I too found it a completely brilliant, wholly perfect idea: Ted Williams, the spectacular homerun hitter, the perfect metaphor for visual modernism.”
Rosalind E. Krauss, The story of the Eye, in History And–: Histories Within the Human Sciences, Edited by Ralph Cohen and Michael S. Roth, University Press of Virginia, 1995, pp.73-74.
.

Left
[ PERS-023-ML ]
Southampton, Tel: 22428 Chandlers Studio, 11, Commercial Road Art F.I.B.P. F.R.P.S.
(?) of photography – E 79
“Since the Brow speaks often true, since Eyes and Noses have Tongues, and the countenance proclaims the heart and inclinations; let observation so far instruct thee in Physiognomical lines .we often observe that Men do most act those Creatures, whose constitution, parts, and complexion do most predominate in their mixtures. This is a cornerstone in Physiognomy there are therefore Provincial Faces, National Lips and Noses, which testify not only the Natures of those Countries, but of those which have them elsewhere”.
Sir Thomas Browne (1605–1682), Christian Morals, Part 2 section 9, circa 1675.
Right
[ ANIM-020-ML ]
11 Ourang Outan
“…the keeper showed her an apple, but would not give it her, whereupon she threw herself on her back, kicked & cried, precisely like a naughty child. — She then looked very sulky & after two or three fits of pashion, the keeper said, “Jenny if you will stop baw- ling & be a good girl, I will give you the apple. — She certainly understood every word of this, &, though like a child, she had great work to stop whining, she at last succeeded, & then got the apple, with which she jumped into an arm chair & began eating it, with the most contented countenance imaginable”.
Charles Darwin, letter to his sister, after climbing into a cage of the London zoo and having his first encounter with a young female orangutan named Jenny, 1837.
.

Left
[ SET-003-ML ]
Slide No. E28
Victor Animatograph Co. Patented Oct.5.1915 Davenport. Iowa. U.S.A. “In a little time I felt something alive moving on my left leg, which advancing gently forward over my breast, came almost up to my chin; when, bending my eyes downwards as much as I could, I perceived it to be a human creature not six inches high, with a bow and arrow in his hands, and a quiver at his back. In the mean time, I felt at least forty more of the same kind (as I conjectured) following the first. I was in the utmost astonishment, and roared so loud, that they all ran back in a fright; and some of them, as I was afterwards told, were hurt with the falls they got by leaping from my sides upon the ground.”
Jonathan Swift, Gulliver’s Travels, Part 1, A Voyage to Lilliput, Chapter 1.
Right
[ UCC-041-ML ]
41/II94 Nu Hur Ruby-throated Hummingbird: Adult perched on a finger covering her nest. Kansas City Public Schools Department of Visual Instruction
The male ruby-throated hummingbird does indeed have a striking red throat, though the female of the species does not. You would have to look quickly to see either, however, as these speedy little birds can beat their wings 53 times a second and fly in an acrobatic style matched by few other birds. They hover often, and also fly upside down and backwards. These hummingbirds have extremely short legs, so they cannot walk or even hop with any efficiency.
Ruby-throated hummingbirds live in woodland areas, but also frequent gardens where flowering plants are plentiful. They hover to feed on flowers, nectar, and sap. During this floral feeding process, the birds pollinate many plants. These tiny birds are omnivores, sometimes feeding on insects and spiders. An adult ruby-throated hummingbird may eat twice its body weight in food each day, which it burns up with the high metabolism necessary to sustain its rapid wing beat and energetic movements. This hummingbird breeds in eastern North America and is the only hummingbird species to do so. Males establish a territory and court females who enter it with flying and diving behaviors, and by showing off their red throat plumage. Females provide all care for young hummingbirds. They lay one to three eggs, incubate them for about two weeks, and, after hatching, feed their young for about three weeks. A female may have several broods in a year. Ruby-throated hummingbirds are largely solitary outside of the breeding season. Ruby-throated hummingbirds winter in Mexico and Central America. To get there from their North American breeding grounds some birds embark on a marathon, nonstop flight across the Gulf of Mexico. They may double their weight in preparation for this grueling journey.
.

Left
[ UCC-006-ML ]
Wood Pigeons Nest
“If it became necessary immediately to discard every line and method of communications in the front, except one, and it were left to me to select that one method, I should unhesitatingly choose the pigeons. It is the pigeon on which we must and do depend when every other method fails. During quiet periods we can rely on the telephone, telegraph, flag signals, our dogs and various other ways in use on the front with the British Army, but when the battle rages and everything gives way to barrage and machine-gun fire, to say nothing of gas attacks and bombing, it is to the pigeon that we go for succour. When the troops are lost or surrounded in the mazes on the front, or are advancing and yet beyond the known localities, then we depend absolutely on the pigeon for our communications. Regular methods in such cases are worthless and it is at just such times that we need most messengers that we can rely on. In pigeons we have them. I am glad to say that they have never failed us.”
Major General Fowler, Chief of the Department of Signals and Communications for the British Army during WW1
Right
[ PERSABS-021-ML ]
Millie and Christine McKoy (also known as McCoy or McKay) were conjoined twins. They were born into slavery in North Carolina on 11th July 1851 and were joined at the pelvis. The McKay farm was near the town of Whiteville, North Carolina, which resulted in the girls also being referred to as The Carolina Twins. Prior to the sisters’ birth, their mother had borne seven other children, all of ordinary size and form.
The twins were first sold at 10 months of age to South Carolinian John C. Pervis. From an early age, Millie and Christine were exhibited to the public. At one stage, the twins were kidnapped and taken to England. During their time in Britain, they met Queen Victoria. In 1869, a biography on the twins, titled History and Medical Description of the Two-Headed Girl, was sold during their public appearances.
The twins were reported as being very intelligent and talented. They apparently spoke five languages, played a specially adapted piano, composed songs and poetry and were accomplished in singing and dancing. As the twins had musical talent, they were often billed as the “Two-Headed Nightingale”. The McKoy twins toured Europe and the Northern states of America before being “rescued” in 1857 by their former owner and being brought back to America’s South to be reunited with their family. Still technically slaves, the McKoy twins were exhibited for years by their owner-manager. On January 1, 1863 the Emancipation Proclamation en- ded their slave status and they were no longer anyone’s property.
Eventually, the twins earned enough money on the “freak show” circuit to purchase the plantation on which they had been born. Photographer Louis Bertin, known for his celebrity cartes de visite, entitled their portrait “Miss Millie Christine”, as if Millie and Christine McKoy were a single entity. The twins were quoted as saying “Although we speak of ourselves in the plural, we feel as but one person”.
On October 8, 1912, Millie and Christine died of tuberculosis; Christine died 12 hours after her sister. They were buried in unmarked graves but in 1969 they were moved to a cemetery in Whiteville.
CAPITOLO 30: NEI COLORI DEL GIORNO
Giacomo Monza, artista, e Antonio Rovaldi, Milano, Italia
Milano • giovedì 28 maggio
Giugno.
L’allegria di giugno – Il tempo delle rose – Il giardino delle rose – La Reine Blanche – La vecchia rosa bianca – Le rose rampicanti e sarmentose – Le rose selvatiche – La difficoltà degli ibridi perpetui – Gli ibridi di tea – La potatura – I piselli odorosi seminati in autunno – I sambuchi – La martensia – La divisione delle piante e fioritura primaverile – Le due varietà migliori di tassobarbasso – L’Epilobium – Le felci.
Che cosa si può dire di giugno, il periodo perfetto della giovane estate, l’adempimento di promesse dei mesi precedenti, e ancora nessun segno che faccia ricordare che la sua fresca giovane bellezza un giorno svanirà?
Per quanto mi riguarda, passeggio nel bosco e dico: “È arrivato giungo – è giugno; Dio ti ringrazio per lo stupendo giugno”.
Gertrude Jekyll in Bosco e Giardino – Note e pensieri pratici e critici di un giardiniere appassionato, “Il corvo e la colomba”, Collana diretta da Ippolito Pizzetti, Franco Muzzio Editore.
Giacomo,
è arrivato il mese di giugno e grazie alle tue fotografie ritorno sulle pieghe di questo libro che lessi per la prima volta durante gli anni dell’Accademia, periodo in cui spendevo molto tempo a leggere libri sulla storia dei giardini. Le pagine sono piene di sottolineature rosse che ora ripercorro capitolo dopo capitolo, stagione dopo stagione. Gennaio / febbraio / marzo / aprile / maggio / giugno / luglio, agosto / settembre / ottobre / novembre / dicembre…sono i titoli dei capitoli che compongono il diario botanico di Gertrude Jekyll, la giardiniera inglese allieva di Ruskin che inventò il ‘mixed border’, ovvero la bordura mista.
“Dove comincia il giardino e dove finisce il bosco?”, si domanda spesso Gertrude nei suoi quaderni di appunti botanici.
Ci siamo conosciuti una mattina di ottobre del 2019, dal mio corniciaio a Milano – dove tu lavori qualche pomeriggio a settimana – che da anni si prende cura delle mie fotografie dando a ciascuna di loro una cornice, spesso in legno di acero con profilo sottile, un vetro antiriflesso e un giusto e invisibile distacco dalla realtà (motivo per cui, negli anni, non ho mai lasciato una fotografia senza cornice e senza vetro).
Tu lavoravi nella stanza di sinistra – il nuovo ampliamento del laboratorio – e stavi ultimando di stendere la cera d’api sugli ultimi profili assemblati. Quelle fotografie in bianco e nero erano parte delle sessanta fotografie che compongo l’installazione End. Words from the Margins, New York City che sarebbero poi partite per Somerville, Boston volando sopra un oceano per la mia mostra alla Lab Library del GSD, il dipartimento di Landscape di Harvard, per la prima tappa espositiva del premio dell’Italian Council, da cui tutto è nato e motivo per cui, ora, sono ancora qui a scriverne, passando attraverso il tuo giardino vicino a Varese. E così, anche a quest’anno, siamo arrivati al mese di giugno, guardando passare la primavera dall’alto di una finestra o da un balcone.
Ci siamo messi a parlare mentre ti aiutavo a incartare i lavori e ho scoperto il tuo amore per la fotografia e per il tuo giardino, a Gerenzano, località dove vivi e coltivi il tuo orto. Ogni giorno ti prendi cura di piante e fiori, alternando scatti fotografici di piccole porzioni di natura ad autoritratti davanti allo specchio, spesso scattati durante il gesto di tagliarti i capelli con la lametta e la schiuma da barba. Fotografi quasi esclusivamente dentro le mura del tuo giardino e poi, di tanto in tanto, quando sei davanti a uno specchio mentre fumi una sigaretta o indossi un cappello di paglia. I fiori crescono con un tempo che sembrerebbe aver la stessa durata dei tuoi capelli. I bulbi si schiudono durante la notte, molti appassiscono e si seccano e il mattino seguente ricominci il tuo rito quotidiano: lametta, acqua, schiuma da barba e un piccolo specchio rotondo.
La settimana scorsa mi hai mandato una cartella carica di fotografie. Fra le tante due immagini hanno particolarmente colpito la mia attenzione: da un gruppo di margherite con i petali afflosciati verso il basso si stanno per staccare gocce d’acqua; in un autoritratto davanti allo specchio – la macchina fotografica impugnata con le mani che indossano un paio di guanti in lattice – un occhio inquadra il tuo volto e dall’altro esce una lacrima…
Osservo a distanza i tuoi gesti reiterati nei giorni, i petali delle rose selvatiche in questo mese di giugno, la superficie della tua testa rasata con una lametta e la schiuma da barba.
Ho selezionato alcune fotografie con il tuo aiuto – dovresti raccoglierne in un libro diviso per stagioni, come il diario di Gertrude – che ora ti mostro qui, convinto che prendersi cura della crescita del proprio giardino e del proprio sguardo sulla natura, possa essere la migliore pratica quotidiana, soprattutto in questo periodo.
Ci vediamo dal nostro corniciaio presto per tirare di nuovo la cera d’api sull’acero….
PS: Giacomo, dimenticavo… Nei colori del giorno è il titolo di un libro di Peter Handke. Un romanzo-saggio sulla pratica pittorica di Paul Cézanne, in relazione al luogo a cui il pittore rivolgeva il suo sguardo ogni giorno: la Montagne Sainte-Victoire.
I colori del tuo orto mi hanno ricordato anche questo libro.
.

.

Gertrude Jekyll in Bosco e Giardino – Note e pensieri pratici e critici di un giardiniere appassionato, “Il corvo e la colomba”, Collana diretta da Ippolito Pizzetti, Franco Muzzio Editore.
.

_______________________________________________________________________________________________
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Fotografie di Giacomo Monza
CAPITOLO 31: OVER THE FENCE
(I’m silently correcting your grammar)
Ben Bazalgette Staple, traduttore, Londra-Modena, Regno Unito – Italia
What’s meant by allotment?
Like Despina, one of Calvino’s Invisible Cities, it depends on where you’re standing. From the outside, it’s a corner of nature, a bastion of wilderness, a pinhole pierced in the urban fabric encroached upon on all sides, a stage where birdsong and bees provide the music, and the wind directs the movement of the players.
From the inside, on the other hand, it’s a different story. On closer inspection, the presence of all things anthropic is rife throughout the allotment, almost as much as in the streets and houses surrounding it. The land is divvied up into plots of property along the railway embankment, each with its own model of government, of care, order and exploitation, while swaying netting and dangling CDs are positioned to guard its treasures from curious magpies and hungry sparrows. Even the boughs of the trees in the patch of woodland at the south end, the only area not allotted, serve to hide from view that epitome of human existence: waste, the abandoned, the broken, the rusted and the worn.
However, for those lucky enough to reign temporarily over one of those straight-edged patches of the planet, it is perhaps neither. A sort of ‘third space’, away from home and work, from unruly children and ageing parents, from the unpleasantness of public transport and of private solitude. A place where – unlike the world over the fence – problems tend to be tangible and can largely be solved by the use of a watering can, some metal wire, a spade and some elbow grease. A nation state small enough to be seen in its entirety while standing at its end, endlessly changing and yet endlessly changeable, the plaything of a benevolent dictator. And so, over time, the mind of each allotmenteer cannot but spill out onto the allotted portion of earth, reflecting his or her hopes, outlooks, manias, commitments and disappointments. Just as much as the inside of a car, a desktop or a bathroom cabinet does.
And yet – as all soil knows – however much we toil and slave, cut and tie, dig and turn, divide and conquer, at some point the buzz of the bees will outlive the buzz of the strimmers. Sooner or later the soil will bury us all.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

CAPITOLO 32: L’APPARIZIONE
Gaia Carboni, artista, Torino, Italia
Giovedì 30 gennaio 2020
Quella mattina mi sono diretta in bici verso lo studio e ho pensato che finalmente mi ero riconquistata il tempo da dedicare ai nuovi disegni che stavo preparando per la mostra che avrei avuto da CLER ad aprile, insieme ad Alessandro Biggio e a Linda Fregni Nagler.
Col buon umore in corpo ho accelerato la pedalata per non perdere un minuto di più.
Sono entrata in studio seguendo la mia solita routine di gesti e sovrappensieri, la stufa già accesa da un’ora ma l’aria ancora fredda, mi sono cambiata alla svelta e avvicinandomi al tavolo da lavoro ho ripreso quello che avevo lasciato a metà il giorno prima.
Ho passato la mattina su quel tavolo a fare esperimenti con un colore e la grafite in polvere, poi si è fatta ora di pranzo, ho mangiato vicino alla stufa, mi sono preparata un caffè e ho ripreso a lavorare. Non mi sono accorta di nulla fino al primo pomeriggio, quando il mio occhio è caduto improvvisamente su una massa marrone che spuntava sotto il tavolo.
Sono rimasta immobile e incredula per quell’apparizione.
Era un fungo!
Per la precisione una famiglia di sfiandrine, le mie preferite.
Da quanto stava lì? Come diavolo avevano fatto le spore a trovare rifugio nel foro di quel truciolare laminato?
Da quel momento non è passato giorno che non gli regalassi sguardi contemplativi, come per tenerlo d’occhio, per assicurarmi che stesse bene, osservando la sua crescita e lui l’avanzamento dei miei nuovi lavori.
Ad oggi il fungo è ancora lì, non so se sia vivo o morto, la quarantena mi ha tenuto lontano da lui e non ho potuto osservare il suo decadimento.
Ha l’aspetto di un anziano e, nell’illusione che sia ancora vivo, continuo ad accudirlo con i miei sguardi.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Gaia Carboni, dentro lo studio, sotto e sopra i miei tavoli da lavoro
.

.
.
CAPITOLO 33: CHE TU SIA PER ME IL COLTELLO
Giovanna Brambilla, responsabile servizi educativi, GAMeC, Bergamo, Italia
Con Maria Grazia Panigada abbiamo iniziato a lavorare anni fa sulle narrazioni. Posso dire che la pratica dei racconti legati alle opere è nata proprio alla GAMeC: io sentivo che ogni opera aveva qualcosa da dire, e che esistevano persone capaci di raccogliere questa ricchezza e di ritrasformarla in parole e storie, con delicatezza e rispetto verso l’artista e conoscenza profonda dei contenuti di ciò che era di volta in volta un quadro, una scultura, un’installazione.
Adesso il museo è chiuso, ci si chiede se le opere senza persone siano ancora tali. O sono interruttori spenti che si accendono solo al risuonare dei passi, alla carezza degli sguardi, alla percezione delle voci e dei commenti, o dei silenzi? Fare il mio lavoro significa creare dei legami, il più possibile capaci di tenere nel tempo, tra l’arte e le persone, quindi forse potrei avere questa deriva, pensare che le opere in una stanza chiusa siano come dei carillon a cui nessuno ha dato la carica. Per la mostra di Antonio Rovaldi non è così. Le opere non ti investono solo quando le vedi, ti lasciano una sorta di persistenza retinica, di branding emotivo, entrano sotto pelle e poi iniziano a legarsi ai tuoi pensieri, come se fosse una reazione chimica. Ovviamente non accade per tutte le opere, per tutte le mostre, ci sono sempre i favoriti, e non è questione legata alla presenza o meno di una qualità estetica: la ragione sta nelle nostre biografie. Accade e basta.
Accade che quell’immagine per me abbia un significato, lo diceva bene David Grossman, in un libro che è uno dei miei preferiti, Che tu sia per me il coltello: “Perché a volte, nei momenti più impensati, per strada, puoi sentire l’anima lacerarsi, catturata dalla storia di qualcuno che ti è appena passato accanto.” A me succede con le opere. Mi è successo con Rothko, con la Pietà Rondanini, con il Polittico della Misericordia di Piero della Francesca, con Kiefer. L’opera si lega a me, a come sto, a quello che sto passando, o semplicemente agli aspetti più nascosti e personali della mia identità.
Il 6 marzo è morta una mia carissima amica, a cui mia figlia deve il nome che porta; sarcoma e non covid-19. Londra e non Bergamo. Ero riuscita a vederla spesso nell’ultimo anno, e l’ultima visita l’avevo fatta a dicembre. Ma il virus, e tutte le restrizioni che ha comportato, non hanno concesso il viaggio del compianto, la presenza al funerale, e come molti amici che hanno perso familiari in questi mesi in cui la mia città viaggia in una terra di morte e strazio, sentivo profonda la necessità della memoria. Di dare forma a tutto lo tsunami di ricordi, frasi, pensieri, dai più piacevoli ai più impossibili da percorrere, come i file vocali lasciati su Whatsapp, una voce che ora non ha più corpo.
Il 6 marzo è morta Sofia, l’8 marzo i musei hanno chiuso le loro porte, ma a me la mostra di Rovaldi è rimasta impressa come un piano sequenza del film Arca Russa di Alexandr Sokurov, ed è attraverso quelle immagini che ho costruito il mio memoriale, la mia elaborazione personale. Un artista ha una sua idea quando realizza un progetto; l’idea di Antonio Rovaldi è stata quella di lavorare, per un lungo periodo, camminando in solitaria lungo i confini dei cinque distretti di New York. Quella città così iconica, che nel nostro immaginario è fatta di grattacieli e persone che si accalcano ai semafori, di taxi gialli e sirene della polizia, diventa sotto il suo sguardo una distesa di terre di nessuno, dove si incontra il waterfront, dove la presenza umana traspare attraverso minimi indizi e la natura, con una straordinaria resilienza, si re-impossessa del terreno. Confini, e non margini. Luoghi di trasformazione, e non di emarginazione, porte e non limiti. Un artista ha la sua idea quando fa un lavoro, ma poi con una staffetta questa idea viene vissuta dagli altri, e ognuno la rielabora. Per me la sua mostra è stata una serie di “stazioni” della memoria. Le raccolgo qua, in veste assolutamente non istituzionale ma personale, perché mi restino.
Questo orologio nel bidone è il mio principio. La prima cosa a cui ho pensato quando il suo compagno mi ha chiamato e mi ha detto in lacrime “So, this is it”, intraducibile in italiano, perché significa che si è arrivati al non ritorno, che qualcosa è accaduto, che niente si può cambiare, che quella è la notizia, io ho pensato alla scena di Quattro matrimoni e un funerale, in cui viene recitata la poesia Funeral Blues, e da soli, come un meccanismo a orologeria, mi sono arrivati i primi versi “Fermate tutti gli orologi, isolate il telefono, fate tacere il cane con un osso succulento, chiudete i pianoforte, e tra un rullio smorzato portate fuori il feretro, si accostino i dolenti.” Lei suonava. Ha suonato sino a quando la morfina lo ha concesso. Ma quella notizia fermava il tempo in un dolore infinito, spaccava gli orologi, fermava le lancette. Il dolore ha sempre questo lascito, sospende il tempo in un rimbombo che non sappiamo quando finirà, ha una dimensione tutta sua, che non si misura con termini fisici. Non è spazio, non ha altezza, larghezza e profondità. È una sospensione. Perdere una persona cara è come essere improvvisamente una scarpa sola. Manca un pari, manca qualcuno che sta al passo con te, manca una parte fondamentale che da un certo punto della tua vita, venticinque anni fa, ha iniziato a fare un percorso con te. Ci si sente così, come questa scarpa, anzi questo scarponcino, pensato per essere utile, per camminare a lungo, per durare. Non per stupire per il tacco, il colore o il design, ma per essere fedele in un lungo percorso. Come si può perdere una scarpa fatta per durare? Se ci accadesse ci rivolgeremmo al produttore, ci lamenteremmo del pessimo acquisto, ma nella vita non va così. Sophia era una pianista, aveva sempre tenuto il suo corpo con cura, come spesso fanno i musicisti. Organic food, palestra, niente fumo, vita salutare. Ma un sarcoma chemioresistente non ha alcuna remora, semplicemente arriva. E allora si resta come una scarpa a bordo di una strada. Sospesi. Si interrompe il cammino, viene anche voglia di guardare giù, di chiedersi se si può proseguire il cammino, o se – da scarpa sola – ci si farà male, con la pelle esposta. Nelle sue peregrinazioni, nel suo cammino, con scarpe buone, determinazione, e passione Antonio Rovaldi inciampava in indizi di vite anonime, oggetti lasciati a terra, abbandonati perché inutili.
.

Antonio Rovaldi – Introduction, The Sound of The Woodpecker Bill: New York City, 2009.
.

Antonio Rovaldi – November 2, 2017 / Belt Pkwy and Paerdegat Basin / Brooklyn, The Sound of The Woodpecker Bill: New York City, 2009.
.

Antonio Rovaldi, November 21, 2017 / Zerega Ave and Lacombe Ave /The Bronx, The Sound of The Woodpecker Bill: New York City, 2009.
Mi avevano colpito da subito i pattini senza lame. Simili alla scarpa sola. I pattini sono una promessa di grazia, chiedono dura disciplina, ma fanno volteggiare. Vederli a terra, senza lame, era per me di un impatto struggente. Come lo scarponcino sono legati al percorso, ma del percorso salvavano la leggerezza, la capacità di avere dei momenti anche di divertimento. A Sophia, che era russa, moscovita, piaceva molto pattinare sul ghiaccio, quando lo faceva, in inverno, a Londra, mi telefonava e me lo raccontava sempre, sembrava quasi tornasse bambina, fino a quando, una volta cadde, e si danneggiò il polso. Per una pianista il polso è come per me la vista, furono mesi di fatica, riabilitazione, e quell’attività venne definitivamente accantonata, perché pericolosa, non solo per la vita, ma anche professionalmente; basta una caduta e si cancella una stagione, con grandi danni. Pattini senza lame, Sophia che non pattina più e io che senza di lei mi sento incapace di volteggiare, di muovermi con grazia. Pattini senza lame, e quelle lame forse non sono lì perché adesso stanno tagliando me. Credo di sapere dove sono finite quelle lame, stanno tra le costole, e non si vogliono spostare.
Nel mio piano sequenza passa una ragnatela. L’immagine è un fulmine a ciel sereno. L’ultima uscita dalla città su lunghe percorrenze è stato il regalo in anticipo che mi sono fatta per mio compleanno. Andata e ritorno a Firenze, in giornata, per l’inaugurazione della mostra di Tomás Saraceno, dove ragni e ragnatele diventano opere d’arte. Ho sempre amato i ragni – aracnidi, e non insetti, la loro capacità di tessere, di lanciare fili invisibili ma resistenti tra rami, foglie, spazi, un po’ come quello che faccio in museo. Tessere fili tra opere e luogo, tra opere e persone, tra luoghi e persone e tra persone e persone, e questa amicizia era come una tela preziosa, costruita nel tempo. Qualche volta avevamo sofferto, nelle nostre vite, ma la tela aveva resistito, eravamo fatte per durare. La lontananza ci rendeva facile parlare di qualsiasi cosa, vivere in luoghi diversi senza possibilità di interazione faceva sì che ci potessimo dire tutto, sapere l’una dell’altra quello che non avremmo mai confidato ad altri. Bergamo/Londra, una ragnatela che andava lontano, ma che veniva spesso percorsa da un capo all’altro. Mostre, biennali, viaggi, ogni incontro la tela si faceva più estesa, ogni incontro e ogni anno diventava un anello esterno, crescevamo come le stratificazioni degli anelli del tronco di un albero.
.

Antonio Rovaldi – Introduction, The Sound of The Woodpecker Bill: New York City, 2009.
La tela diventava anche un paracadute. Ho sempre amato la poesia Two Roads di Robert Frost, soprattutto nel finale quando si legge “due strade divergevano in un bosco, e io presi la meno frequentata, e questo fece la differenza”. Le strade mia e di Sophie sono state come la poesia di Frost. Quando nella vita ci siamo trovate davanti a dei bivi, abbiamo preso la strada meno frequentata. Come ha fatto Antonio Rovaldi, con il pensiero divergente di esplorare di New York ciò che nessuno immagina che New York sia. Eravamo, su questo, testarde e determinate. La strada facile, quella scontata, non era mai la nostra. Abbiamo in alcuni momenti preferito perdere – perdere sonno, perdere possibilità, perdere apprezzamenti – pur di non fare ciò che non ci sembrava corretto. Abbiamo intrapreso progetti su cui nessuno avrebbe scommesso. Abbiamo avuto cadute e soddisfazioni ma quella strada, quella meno frequentata, sarebbe sempre stata la nostra. Nelle relazioni umane, nelle amicizie, nel lavoro.
Ci confrontavamo spesso sui nostri progetti. E lei sapeva che stavo preparando un piccolo libretto sul tema dell’inferno, letto soprattutto alla luce dell’arte contemporanea. Le avevo detto che sulla copertina avrei voluto mettere l’immagine dell’incisione di Goya Il sogno della ragione genera i mostri. Era un’immagine perfetta dell’Inferno, era qualcosa che lei associava alla malattia. La malattia addormenta la ragione e ti fa dire e provare cose che mai avresti voluto, scatena e libera i demoni, mette alla prova la già complessa idea di Dio. Quando ho visto questa immagine in mostra prima dell’inaugurazione il colpo è stato forte, perché era un’immagine su cui avevo scritto, e di cui avevo parlato con lei, come una traslazione di una parte della mia vita nella sala di un museo attraverso l’opera di un artista…
Che si era ammalata lo sapevo da tempo, da più di un anno, era l’estate del 2018 e io ero da lei. Qualche dolore allo stomaco, il consiglio di un medico di fare un’ecografia, che poi era diventata una biopsia che poi era diventata quella parola nuova, che avrei imparato a conoscere e a pronunciare spesso: leiomiosarcoma: tumore del tessuto connettivo muscolare liscio. È una parola che ha un inizio dolce suadente e una fine dura: leiomio-sarcoma.
.

Antonio Rovaldi -April 18, 2016 / Highbridge Park, Edgecombe Ave and 165th St / Manhattan, The Sound of The Woodpecker Bill: New York City, 2009.
.

Antonio Rovaldi – March 28, 2016 / 131st St and Broadway / Manhattan, The Sound of The Woodpecker Bill: New York City, 2009
Lei o mio? Si chiama subito un caro amico, un primario, chiedo un consulto qua, mi fido di questo amico perché è una persona sincera, che non indora la pillola, anche lui colpito negli affetti familiari da una morte per tumore. Mi dice che non c’è niente da fare, che questo leiomiosarcoma è chemioresistente. Due parole da sei sillabe. Martellano nella testa come una mitragliata. Non lasciano nemmeno uno spiraglio. Tumore del tessuto connettivo muscolare. Come una crepa nel muro. Lei è il muro e questa è la crepa. Si apre e si fa strada piano piano dentro di lei. Non si può fare nulla. Non è operabile, è troppo innervata. Come una crepa segue i sentieri del corpo, segue le vene, si va ad innestare sui tessuti, diventa una espansione lenta ma inesorabile. Si può solo guardarla. Andare in vacanza fino a che il corpo regge. Monaco. La Francia, i castelli di Ludwig. Mi arrivano fotografie. Non di lei, ma dei paesaggi. Non si sarebbe più fatta fotografare. Lei era “quella prima”, prima della malattia, sentiva di essere radicalmente diversa, di non volere trasmettere l’immagine del corpo malato. La prima crepa è stata la caduta dei capelli, la scelta della parrucca, la ricerca di una perfezione estetica che non facesse capire che la casa aveva una crepa. Che non facesse annullare le lezioni e i concerti. Ma la crepa si apriva.
La fine, a volte, arriva prima di esserci. Come questo cartello, fotografato da Antonio Rovaldi, titolo che la mostra aveva quando è stata tenuta a Harvard. Che cosa finisce? Di cosa segnala la fine? Che cosa è la fine? La fine è stata l’inizio, la fine è stata sapere che non c’era nessuna possibilità. Fa paura la fine quando si estende nel tempo, quando significa prepararsi alla perdita, al dolore, agli oppiacei, alle gambe che non camminano, all’addome gonfio, fino a quando si prega perché la sofferenza finisca. Quel cartello però sta in un punto sospeso. L’ultima conversazione avuta con Sophie, l’unica conversazione reale fatta condividendo uno spazio e un tempo era su quello. Perché io? Si chiedeva? Perché ora? Perché Dio lo consente? Era stata la partenza per un discorso sulla fragilità. È così facile credere e avere certezze quando si sta bene. Il tema della fine lo abbiamo fatto a pezzi come dei chirurghi. Sarà la fine? Ci sarà altro? La teniamo questa speranza? Sofia chiedeva le mie preghiere, perché lei non riusciva più a pregare, e io mi sentivo così inerme.
.

Antonio Rovaldi – Introduction, The Sound of The Woodpecker Bill: New York City, 2009.
.

Antonio Rovaldi – November 25, 2017 / end of Yeomalt Ave / Staten Island, The Sound of The Woodpecker Bill: New York City, 2009.
La fine di una persona azzoppa anche chi resta. Eppure, in mezzo a questo dolore, le immagini di Rovaldi, come dicevo, sono state delle stazioni di riflessione, non un trampolino per precipitare nel vuoto. Perché la mia amica è morta. Perché non potevo andare in ospedale nei due ultimi giorni, perché per il virus non potevo partire. Perché il cartello della fine ho potuto vederlo da lontano, piangendo per e con la distanza. Ma le immagini a volte ci dicono molto. Ci accompagnano, forse anche ci indicano una strada, ci portano quasi conforto. Perché non è vero che finisce il mondo, dopo il cartello fine. Lì c’è il confine, il limite tra mare e terra. Non è un cartello che blocca il passaggio ma che segna un passaggio. Dopo c’è un orizzonte sconfinato. E non è vero che una scarpa da sola non può camminare, perché la riflessione non è sul bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno, è sul fatto che ci sia un bicchiere, ed è già tanto. Perché sul dolore della scomparsa di questa persona a me così cara io posso reagire onorando il ricordo, perché – ed è la foto che Antonio Rovaldi ama forse di più tra quelle esposte – ai bordi di una strada che non è più soggetta a interventi di manutenzione, cresce tenace l’erba, come la ginestra, o il fiore del deserto di Leopardi. È una poesia che il professore del liceo mi fece amare, che si conclude cosi: “Ma non piegato insino allora indarno / Codardamente supplicando innanzi /Al futuro oppressor; ma non eretto / Con forsennato orgoglio inver le stelle, / Né sul deserto, dove / E la sede e i natali / Non per voler ma per fortuna avesti; / Ma più saggia, ma tanto / Meno inferma dell’uom, quanto le frali / Tue stirpi non credesti / O dal fato o da te fatte immortali”. La resilienza di quest’immagine mi ha dato conforto, perché l’arte alla fine non è qualcosa che si guarda, ma che si prova. Ed è grazie all’arte che ho potuto affrontare l’amputazione della perdita, con queste righe, in un immaginario dialogo per nessuno, un’elegia funebre per me e per lei, idealmente sedute su queste sedie vuote nella radura.
Giovanna Brambilla
.

Antonio Rovaldi – May 22, 2018 / Murray Hubert Ave / Staten Island, The Sound of The Woodpecker Bill: New York City, 2009.
.

Antonio Rovaldi – November 27, 2017 / inside Fairview Park / Staten Island, The Sound of The Woodpecker Bill: New York City, 2009.
CAPITOLO 34: PRIMO CAMPO
Marina Ballo Charmet, fotografa e psicanalista, e Antonio Rovaldi, Milano, Italia
Caro Antonio,
pensando anche alle esperienze accumulate durante questo lockdown mi domando a che distanza dobbiamo metterci dall‘oggetto, dall‘altro?
Questa è la domanda che mi viene in mente quando ripenso al lavoro di Primo campo.
È per me interessante rivedere queste immagini di avvicinamento forzato in questo periodo di distanziamento forzato.
Primo campo è un lavoro iniziato nel 2000, proseguito per qualche anno.
Mi ha insegnato molto sulla prossimità. Rimanda allo sguardo del bambino piccolo – o anche a quello dell’amante e del suo oggetto del desiderio.
Il titolo riguarda il primo campo visivo del bambino piccolo in braccio alla figura famigliare. Anche se vede solo una parte di chi gli sta vicino – il mento o il collo, quella parte che sta tra gli occhi e il petto – il bambino piccolo sente e odora, tocca e vede immensa una parte – la parte per il tutto – che si rende presente, diventa «cosa», significante che il bambino riconosce.
Non è la faccia, il ritratto intero, convenzionale, a interessarmi ma la zona del campo visivo considerata in genere di sfuggita. Si potrebbe dire che non si tratta di un ritratto ma di olfatto, di tatto, di intimità percettiva. Gli elementi impercettibili che Bollas chiama “conosciuto non pensato”.
Era difficile mettersi negli occhi del bambino piccolo ma in questo forse mi ha aiutato la mia formazione nell’ambito della psicoanalisi infantile nella quale è necessario sapersi identificare con i modi in cui il bambino sente e percepisce il mondo.
Volevo rendere lo “stare dentro” all’esperienza e non solo di fronte, quel tipo di esperienza descritta da Merleau-Ponty quando afferma che la luce può essere considerata come un’azione per contatto simile “a quella delle cose sul bastone del cieco”.
Sono immagini che sfumano a volte in un poco definito – in parte fuori fuoco – che può turbare poiché in certi casi è anche prossimo al mostruoso.
Non c’è il ritratto e la frontalità dell’oggetto come forma stabile e afferrabile ma è il vagare nel fuori campo, fuori dalla centralità antropocentrica che non si lascia spaventare dal vagare con disattenzione quasi seguendo il caso: l’immagine esce quasi da sé.
Una delle mie prime letture psicoanalitiche molto amate è stata Gioco e realtà di Winnicott in cui descrive come il precursore dello specchio sia la faccia della madre. La madre guarda il bambino e ciò che essa appare è in rapporto a ciò che essa scorge.
In Primo campo si tratta del corpo che rimanda alla carne e forse alla madre stessa. Mi accorgo per la prima volta, parlandone ora, che forse lo si potrebbe considerare anche un lavoro sulla madre. Mi avevano molto colpito le reazioni di donne spettatrici che esprimevano un profondo coinvolgimento come se l’osservazione dell’immagine di Primo campo attivasse emozioni e fantasie relative al corpo, al femminile e al materno.
Per quanto riguarda la dimensione ho scelto di mostrare le foto di Primo campo molto grandi, per rendere l’esperienza del bambino piccolo in braccio alla figura familiare – l’ingrandimento è di circa quattro volte – come se il corpo fosse visto da molto vicino così da ritrovare quella intimità.
La stessa fotografia stampata piccola rimanda a un’osservazione non partecipe: un’osservazione che è separazione, distanza fuori dall’esperienza. In questo lavoro si trattava di portarsi dentro.
Il libro Primo campo pubblicato in Francia da Le point du jour ha un montaggio di una trentina immagini presentate in forma di serie – una lunga sequenza con continue interruzioni visive della ipotetica narrazione – un po’ come avevo fatto per Con la coda dell’occhio.
Ho voluto creare, oltre alle immagini singole, anche delle sequenze di tre immagini dove emerge il minimo spostamento del corpo. La presenza – il corpo – si ripropone ma è all’interno la nostra mobilità percettiva, i nostri colpi d’occhio: elementi minimi.
È forse un po’ come il tuo girovagare per le periferie di New York quasi che il volto umano diventi una terra .
A presto,
un abbraccio
Marina
.

Marina Ballo Charmet, Primo Campo, trittico, 2004
.

Marina Ballo Charmet, Primo Campo, 2001
.

Marina Ballo Charmet, Primo Campo, 2002
.

Marina Ballo Charmet, Primo Campo, 2002
.

Marina Ballo Charmet, Primo Campo, 2002
.

Marina Ballo Charmet, Primo Campo, 2002
.

Marina Ballo Charmet, Primo Campo, 2001
.

Marina Ballo Charmet, Primo Campo, 2003
.

Marina Ballo Charmet, Primo Campo, 2002
.

Marina Ballo Charmet, Primo Campo, trittico, 2005
_______________________________________________________________________________________________
Milano • 7 giugno 2020. domenica
Ciao Marina,
grazie per avermi mandato la tua sequenza di Primo Campo. È un lavoro che ho sempre amato molto, forse perché è stato il primo progetto che mi ha fatto avvicinare alla tua pratica fotografica, poco prima che ci trovassimo a lavorare entrambi nella galleria di Alessandro De March, a Milano, non pochi anni fa. Nonostante la condivisione della stessa galleria, ci siamo incontrati poche volte in questi anni milanesi, ma sono felice di averti ritrovato qualche mese fa in occasione della mostra collettiva a cui hai partecipato da Cler, Lo spazio tra le cose.
Le tre fotografie della sequenza Le ore blu che hai esposto nel nostro studio sono porzioni di acqua della laguna veneziana vista dalla Giudecca.
“Mi sembrava una posizione vicina a quella che si assume durante la meditazione, semplicemente stando lì davanti all’acqua che scorre e alla luce che cambia nel tempo. Vagare con l’occhio con un’attenzione che fluttua e riprende profondità scura o la superficialità, l’opacità o la trasparenza dell’acqua in vari momenti. Le ore blu sono quel momento di sospensione tra luce e buio intorno al crepuscolo della sera e del mattino”. (Marina Ballo Charmet, in Lo spazio tra le cose, brochure n.8, CLER).
Mi sarebbe piaciuto poter camminare per Venezia durante la quarantena. Forse attendendo il crepuscolo del mattino, più che quello della sera. Aspettare il giorno, piuttosto che la sua fine.
Ora che riguardo Primo Campo, carico della tensione di questo ultimo periodo di distanziamento fisico tra le persone, mi accorgo che anche il mio sguardo, un po’ come quello del bambino quando cerca di mettere a fuoco la distanza dalla madre nelle tue immagini ravvicinate, si appoggia sui dettagli di un corpo. Una bocca, un pezzo di collo, una piega del volto che è un paesaggio, i capelli che cadono sulla fronte…
È cosi faticoso e innaturale stare lontano dai corpi.
Questa mattina mi sono svegliato presto e dopo aver messo in fila le tue fotografie per gli ultimi capitoli dell’ultimo martedì de Il Giro del Giorno, ho riguardato il film La double vie de Vèronique, Krzysztof Kieślowski, uno dei miei film preferiti di sempre.
Ci sono due scene del film che mi fanno pensare a Primo Campo.
La prima è l’inizio del film, dove un cielo stellato notturno introduce la protagonista bambina nell’atto del guardare le stelle, il cielo, l’oscurità e la luce insieme.
La seconda scena è quando Vèronique appoggia e fa scorrere un anello sul bordo dei suoi occhi, come per rimettere a fuoco il suo sguardo… (a volte ho provato a farlo anch’io con il bordo freddo di una moneta).
That’s the star we’are waiting for
To start Christmas Eve. You see it?
And there…
look at the haze there below.
It’s not haze.
Show me.
(La double vie de Vèronique, Krzysztof Kieślowski, 1991)
Il Giro del Giorno è arrivato al suo compimento dopo due mesi di scambi intensi con gli autori che amo e sono sicuro che arriverà presto un nuovo giro, a cominciare da quando passerai a trovarci in studio per riprendere le tue Le ore blu che in tutte queste lunghe e silenziose settimane sono state anche un po’ nostre, appese ai muri del nostro studio.
A Milano piove, spengo il computer che si è fatto tardi e cerco di finire quel libro di cui ti ho parlato: Il dono oscuro.
Antonio
.

.

.

.

.

La doppia vita di Veronica (La Double Vie de Véronique), immagini tratte dal primo minuto del film di Krzysztof Kieslowski, 1991.
.

.

.

La doppia vita di Veronica (La Double Vie de Véronique), immagini tratte dal film di Krysztof Kislowki, 1991.
_______________________________________________________________________________________________
Milano • 9 giugno, 2020, ore 7:00, avvicinandomi alla fine del libro…


CAPITOLO 36: JAMAICA
Francesco Simeti, artista, New York, Stati Uniti
.

On the Beaches of Jaimaica, Social distance Walk #5
CAPITOLO 36: CONEY ISLAND
Leonardo Merlini, giornalista scrittore, e Antonio Rovaldi, Milano, Italia
Fotografie: Anna de Manincor, artista, Bologna
Coney Island
C’erano quei tronchi che entravano nel mare controluce, come una specie di mappa indecifrabile. C’era lei, con il cappotto verde che le altre donne in città ammiravano spesso per il taglio e il colore. E dentro il cappotto c’era un corpo, che poi si metteva a correre sulla sabbia all’improvviso, percorso da scosse di quella che a lui sembrava una nervosa felicità. Lei correva e lui aspettava. Lei parlava di Eliot e lui ascoltava, a volte distratto dal pensiero delle conchiglie che aveva visto poco prima. Un gran numero di conchiglie nere. Uno stormo, aveva pensato lui con un certo disagio. Lei era la poetessa pubblicata, lui uno che fotografava le metropolitane. Lei aveva denti magnifici che lui a tavola non smetteva di guardare, fingendo che fosse la bocca il punto del suo interesse, quelle labbra conosciute e raggiungibili. Mentre a ipnotizzarlo era la forma degli incisivi, il loro modo di stare nel mondo, lontanissimi da tutto il resto. La sua poesia, pensava lui, veniva dai denti, non c’era altra spiegazione. Poi lei lo chiamava per seguirla in riva al mare e, mentre si avvicinava, lui lasciava sulla sabbia grandi impronte a pois, da cartone animato.
Arrivare fino a lì era stata un’operazione lenta, a tratti esasperante per via dei cambi di intensità della luce lungo il tragitto, come se una serie di momenti della sua vita (ricordava la luminosità lattiginosa dietro le persiane nella sua classe alle scuole elementari, la penombra in una stanza in una pensione di provincia, il cielo di metallo sopra Bilbao) come se quei momenti si fossero susseguiti a una velocità assurda.
Per poi fermarsi di colpo di fronte al luna park affacciato sulla spiaggia. Immobile, in eterno. Lei rideva, lui aveva la nausea, ma rideva comunque insieme a lei. Il sole stava da qualche parte sopra di loro mentre lui la filmava con il cellulare quando camminava a piedi nudi, con gli stivali in mano, persa nella morbidezza del luogo.
Il Castello di Kafka si erge sopra al mondo come un’ultima bastiglia del “Mistero dell’Esistenza”, diceva lei recitando Ferlinghetti. E poi “il tempo sfodera la sua frusta scaltra”, e ancora altri versi che sono scivolati via insieme al ricordo di quella giornata.
E i palazzoni in fondo alla spiaggia, il venditore solitario di gadget sbiaditi, il parcheggio nella gloria distesa del pomeriggio atlantico. Perché hai fatto finta di non vedere quell’attore, stava chiedendole lui. Quale attore? Rispondeva lei. E poi – aggiungeva subito – aveva un cane troppo grosso. Tutti hanno cani grossi a Central Park, diceva lui. Ma non grossi in quel modo, ribatteva lei.
I gabbiani in cielo sembravano volare esattamente sopra la ruota panoramica, come un’aureola malsana. Ma era solo un’illusione della prospettiva. Dimmi qualcosa in tedesco, chiedeva lei. E lui lo faceva, recuperando ricordi della filosofia studiata al liceo. Lo faceva più per vederle i denti un attimo prima che lo baciasse, piuttosto che per il bacio in sé. La cosa in sé. Anche questo si poteva dire in tedesco. E lui lo diceva, proprio dentro la bocca di lei. Lo stava dicendo, ne era consapevole, da sempre.
Il resto della giornata era un susseguirsi di fotogrammi leggermente sbiaditi dalla salsedine dell’aria, era una spedizione dentro gli odori che un tempo avevano sentito i balenieri come Melville e poi, decenni dopo, le schiere di giovanotti con i muscoli spalmati di creme, dolciastre come i loro confusi desideri.
Lei davanti, e poi accanto a lui, talvolta dietro. Lui con una sigaretta in mano, quasi sempre spenta, la macchina fotografica in tasca, mai usata. A vederli da lontano, come facevo io, sembravano muoversi seguendo una qualche coreografia. Avevano una loro eleganza, una capacità ingenua di stare davanti a quel mare senza scomparire. È perché fanno l’amore, ricordo di avere pensato, ma forse era soltanto una mia illazione. Una specie di speranza.
Del resto a Coney Island tutto sembrava una speranza finita in altri modi, quasi sempre sfortunati. Come un cappotto fuori stagione. Ma adesso, benché sembrasse estate, era solo novembre, per fortuna.
.

ZimmerFrei – Tomorrow is the question, 2010.
.

Anna de Manincor – Toni, Coney Island 2009.
_______________________________________________________________________________________________
Coney Island Baby, Lou Reed
You know, man, when I was a young man in high school
You believe in or not, that I wanted to play football for the coach
And all those older guys
They said that he was mean and cruel but you know
I wanted to play football, for the coach
They said I was a little too lightweight to play lineback and so I’m playing right-end
Wanted to play football for the coach
‘Cause, you know some day, man you gotta stand up straight unless you’re gonna fall
Then you’re going to die
And the straightest dude I ever knew was standing right for me, all the time
So I had to play football for the coach
And I wanted to play football for the coach
When you’re all alone and lonely
In your midnight hour
And you find that your soul
It has been up for sale
And you’re getting to think about
All the things that you done
And you’re getting to hate
Just about everything
But remember the princess who lived on the hill
Who loved you even though she knew you was wrong
And right now she just might come shining through
And the
Glory of love
Glory of love
Glory of love, just might come through
And all your two-bit friends have gone and ripped you off
They’re talking behind your back saying “man, you are never going to be no human being”
And you start thinking again about all those things that you’ve done
And who it was and what it was
And all the different things that made every different scene
Ah, but remember that the city is a funny place
Something like a circus or a sewer
And just remember, different people have peculiar tastes
And the
Glory of love
The glory of love
The glory of love, might see you through
Yeah, but now, now
Glory of love
The glory of love
The glory of love might see you through
Glory of love, uh, huh-huh
The glory of love
Glory of love, glory of love
Glory of love, now, glory of love, now
Glory of love, now, now, now, glory of love
Glory of love, give it to me now, glory of love to see you through, huh
Oh, my Coney Island baby, now
I’m a Coney Island baby, now
I’d like to send this one out to Lou and Rachel
And all the kids at P.S. one-ninety-two (Coney Island baby)
Man, I’d swear, I’d give the whole thing up for you
.
.

IL GIRO DEL GIORNO è un quaderno personale di Antonio Rovaldi, nato dal desiderio di dare voce ai contenuti della mostra Il suono del becco del picchio, inaugurata lo scorso febbraio alla GAMeC negli spazi dell’Ala Vitali dell’Accademia Carrara. Rovaldi ha invitato artisti, scrittori, fotografi e giornalisti ad accompagnare, con il loro sguardo, il lettore verso nuove possibili geografie che non richiedono sforzi fisici, ma soltanto uno spostamento immaginifico del nostro pensiero.
GAMeC ringrazia sentitamente tutti gli autori coinvolti in questo progetto per i loro contenuti.
*End. Word from the margins, New York City di Antonio Rovaldi, progetto realizzato grazie al sostegno dell’Italian Council (V edizione, 2019), programma di promozione di arte contemporanea italiana nel mondo della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo.
CLICCA SULL’INDICE PER LEGGERE IL SINGOLO CAPITOLO
Una conversazione a distanza
Antonio Rovaldi e Alessandro Biggio, artisti, Milano e Cagliari, Italia
Francesca Benedetto, paesaggista illustratrice, Milano - Boston, Italia - Stati Uniti
Alessandro Sciarroni, coreografo e artista, e Antonio Rovaldi, Porto d’Ascoli – Milano, Italia
Pier Luigi Tazzi, curatore e critico, e Antonio Rovaldi, Capalle (FI) – Milano, Italia
Una lettera come un ritorno a New York
Leonardo Merlini, giornalista, e Antonio Rovaldi, Milano, Italia
Michael Höpfner, artista, e Antonio Rovaldi, Vienna - Milano, Austria - Italia
Diletta Colombo, libraia di SpazioB**K, e Antonio Rovaldi, Milano, Italia
Andrea Marinelli, giornalista, e Antonio Rovaldi, Milano, Italia
Francesco Pedrini, artista, e Antonio Rovaldi, Bergamo - Milano, Italia
Cecilia Canziani, Critico d'arte e curatrice, e Antonio Rovaldi, Roma – Milano, Italia
Claudia Durastanti, scrittrice e traduttrice, Roma - New York City, Italia - USA
(I’m silently correcting your grammar)
Ben Bazalgette Staple, traduttore, Londra-Modena, Regno Unito - Italia
Giovanna Brambilla, responsabile servizi educativi, GAMeC, Bergamo, Italia
Marina Ballo Charmet, fotografa e psicanalista, e Antonio Rovaldi, Milano, Italia
Leonardo Merlini, giornalista scrittore, e Antonio Rovaldi, Milano, Italia
Fotografie: Anna de Manincor, artista, Bologna